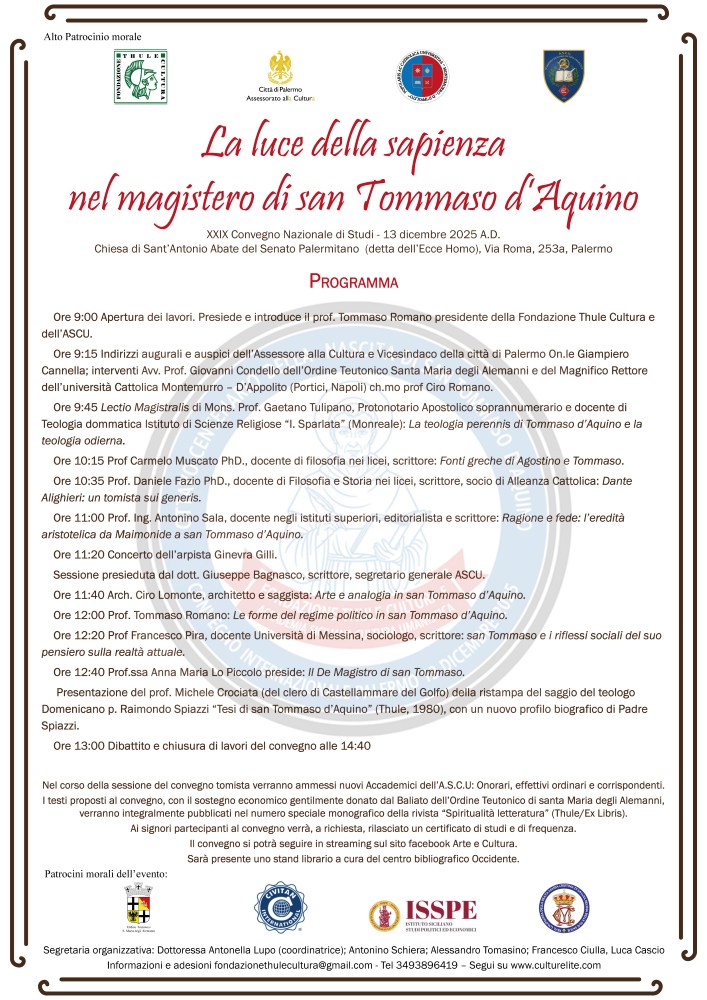Mariolina La Monica, "Vagheggiando Itaca" (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 16 Gennaio 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2114
di Giuseppe Bagnasco
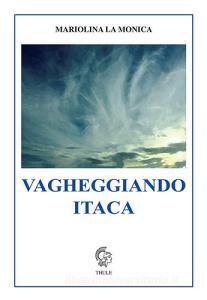 Non è facile approdare alle rive di Vagheggiando Itaca (Ed, Thule, Palermo 2016) se non imbarcandosi con Mariolina La Monica su una zattera e percorrere con lei tutto il viaggio poetico fino all’ultima esplicativa lirica. Una zattera, quella rabberciata sull’isola di Ogigia da Ulisse, che non è la Zattera della Medusa di Theodore Gericaut e tuttavia bisogna seguirla pedissequamente per cogliere tra i tanti prati seminati di concetti e parole, come fiume in piena, quel tanto che sa d’infinito nel tanto piccolo orizzonte umano. Un orizzonte dove accanto al contingente del quotidiano si staglia quello esistenziale e dell’Oltre. E’ un viaggio dove l’ombra di Ulisse, ma solo l’ombra, permea tutto il percorso lirico della poetessa in quanto viaggio di un uomo alla ricerca della sua anima, del suo definitivo approdo. Un viaggio temporale e apparentemente materiale ma che la poetessa compie anche in funzione introspettiva e durante il quale emergono amare considerazioni insieme a luci di speranze, il tutto vissuto come una sospensione tra il mare dove si trova e il cielo, tra mente e anima, tra corpo e spirito. La raccolta, composta da cinquanta e una lirica, forma una circolarità dove l’ultimo verso di quest’ultima ritorna e offre il titolo alla raccolta e non a caso. Ma c’è un diverso indizio che rivela a metà i temi ivi contenuti e sta nel primo verso posto nel frontespizio: “ Scivola a fondovalle il corpo stanco” facendo da “pendant” col primo verso della stessa ultima lirica (che abbiamo staccata dal “corpo”): “ Ulisse è stanco”. Una sensazione che traspare dall’insieme e che emerge dalle meditazioni corpose e numerose che la Nostra espone con domande che si pone e ci pone, tanto che a ben vedere il tutto assurge a tracciare un mediatico percorso di filosofia che appare a tratti come cosmica perché universale è il suo pensiero. Un percorso che parla degli affanni del quotidiano e che vengono poi esposti alla luce della speranza. Uno stare a mezz’aria, in mezzo al mare come la zattera di Ulisse che cerca la sua isola ma non la scorge, l’avverte nel suo sentire ma non la materializza e intanto sta lì nell’attesa che si compie il suo destino come chi sulla soglia sa che dovrà varcarla con serenità d’animo giacché, afferma la poetessa, non siamo altro che dei calchi che producono altri calchi. E ciò ci richiama alla mente i versi di un altro poeta in un’altra poesia “Solo un anello” (in “Poieteche” – Thule, Palermo 2006) laddove si paragone la vita a “quella della catena di una nave/ che l’ancora inesorabile/ tira giù/ e per uno che sprofonda/ un altro sbuca fuori sopra il mare” . Ma c’è ancora un altro indizio che preclude e cela, e insieme svela il sentire della voce della raccolta e sta nella pagina della dedica “ai miei amori”. E’ una frase esplicativa, quasi un’esortazione:” Per te che sogni/ e superi le ombre e il tempo della morte/ gioconda si libra la mia speme/ al pieno sole”. In questo ci sono tre parole emblematiche che indirizzano a percepire lo snodo del viatico poetico: morte, speranza e sole. E’ in queste il senso del superamento del tempo del dopo-vita senza perdere la speranza di vedere ed essere confortati dalla luce. Il volume manca della prefazione, solo una postfazione dell’ottima Franca Alaimo e supplita da una nota dell’Autrice che anticipa e chiarisce la metafora di un’isola, Itaca, cercata a lungo da Ulisse e rappresentante la patria perduta. Non siamo al canto verdiano del “Nabucco” perché Itaca rappresenta un “luogo” dove lo spirito trova il giusto respiro nel quale trovare la forza di resistere a restare. E non a caso la poetessa chiude la raccolta con “ stare/ stare sul mare/ vagheggiando Itaca!”. Ma è solo un incitamento, una speranza perché nelle cinquanta liriche si snodano e vi emergono i dubbi, le sofferenze, il dolore controbilanciati dalla bellezza, “ ho visto…giardini di pesco e filari di vigne maturati al sole/…fringuelli di liberi trilli… furono essi a scovare in me la bellezza” (v. Viaggio) o ancora dalla gioia nel vedersi circondata dallo splendore del creato rispetto alla pochezza del quotidiano “…intanto che le stelle adornano la notte/ e alla finestra fiorisce lento/ il fiore taciturno dell’aurora/… e nelle albe in cui luna e stelle/ danno il loro ultimo bacio a questa terra” (v. Abbraccio notturno). Un inno al Creato come fosse il rinverdire “Il cantico delle creature” o meglio conosciuto come “Il cantico di Frate Sole”, come qui conviene, del Poverello d’Assisi. Mariolina La Monica ama tutto ciò, ne assapora nel suo intimo quel senso che la riappacifica alla vita, sebbene minata nel fisico “per le fragili ossa che io sono/ e che mi fanno giocattolo”. Parla del dopo-vita in modo sereno sperando solo, nella restante “collana di giorni”, di non essere di peso per non opprimere il petto dei “suoi amori”, quegli amori a cui è dedicata la presente raccolta. L’opera è divisa in quattro sezioni (La Luce, Amicizia e Amore, Arbusti e Il Margine al Cuore. In copertina la raffigurazione opacizzata di un mare procelloso. Quel mare che lei ama perché, a parte il suo annuale incontro estivo con l’esplosione della sua naturale bellezza, dopo l’inquieto inverno, rappresenta la natura stessa della vita vissuta, spesso in ansia, talvolta tempestosa. Ma tutto dimentica come il suo Ulisse che “bacia la tempesta e fa vela alla sua isola sperata”. Un’isola “assurdamente voluta”, cioè contro ogni logica oggettiva. Perché assurdamente, ci chiediamo?. Perché, secondo la nostra personale interpretazione, al di là del “carpe diem”, della “dolce vita” nei sette anni trascorsi accanto alla bella Calipso ( non sappiamo, né Omero lo lascia percepire se ha avuto dei figli) e nonostante fosse stato visto dalla romantica Nausicaa “ bello di fama e di sventura” come lo canta il Foscolo per il destino che li accomuna, nonostante tutto questo e senza avere mai avuto notizie della sua famiglia, ha un dovere da compiere, il ritorno alla sua Patria, certo un nobile sentimento, ma per esaudire le suppliche di Penelope alla dea Athena sua protettrice come lo era dello Stato e delle leggi e soprattutto per eseguire la volontà di Zeus. Quindi, in un certo senso è infuso in Ulisse il valore stoico della sua missione raccolto in un trinomio che costituirà nei secoli avvenire un indirizzo, quella base ideologica che giungerà fino a Mazzini che la sintetizzerà nel motto “Dio, Patria, Famiglia” tre dei fondamentali del suo apostolato, base su cui si esplicheranno i doveri dell’uomo e che sono presenti in Ulisse sia verso gli dei (Zeus), sia verso la patria (Itaca) che verso la famiglia (la sposa e il figlio). E’ la filosofia dei doveri e che in fondo riflette in parte anche la stoicità della poetessa, quando assolve i suoi compiti verso i suoi amori come i figli “sudati ad uno ad uno senza sconti/ resi adulti/ non consoni alla compravendita”. Ed è qui sui ragazzi d’oggi che si innesta una sorta di lirica filippica contro una società in cui “questi nostri figli, cittadini del mondo…colti manovali speranzosi…che per difendersi dagli attacchi della sorte (un vero eufemismo) …espatriano (v. Sereno infranto) mentre altri “mammut che incombono tra i pilastri… per non soffrire come è dato ai furbi”. E’ un’amara considerazione sui valori del vivere odierno e sull’estremo laicismo d’un mondo corrotto mentre sottolinea “ a immaginare le cose la gente di questa vita/ in un mondo più verace ed equo/ in cui più alcun dolore esista che l’animo c’opprima/… se l’occhio ristretto del livore/ non affresca con colori di sereno il proprio cuore/ ” (v. Il sogno più grande). E a rimarcare ciò ecco confermato nei versi “un po’ più in là/ dalle fumose nebbie del presente… oggi, dilaga l’onda della riva aperta”/ (v. Calcinacci). Ma, a parte queste constatazioni sul contingente, dal sapore socio-politico, la Nostra riserva la sua verve alla ricerca della sua anima, una introspezione che pervade grande spazio della raccolta. Un riflesso di uno specchio esistenziale soprattutto riguardo la morte nei versi : “ pur se implacabile/ l’autunno si fa inverno/ lentamente gli impeti d’Acheronte inonderanno l’aria…/”…o ancora in “ ora che il tempo piano mi scompone/ mi chiedo inutilmente cosa siamo/ se non dei calchi/ resi nomi da altri calchi/” e infine “ quando riapparirà il tarlo alla mia soglia/ mi mostrerò alla luce per marcire”. Ecco in queste meditazioni appare la contrapposizione ombra-luce che richiama alla memoria il titolo della sua prima raccolta “Dall’ombra e dalla luce” (1997) e che qui si presenta nella dicotomia Acheronte-Luce così come richiamato in un frammento dei Carmina di Orazio (“Melanippo, ubriacati con me/ sceso di là dai gorghi d’Acheronte,oltre il varco/ vedrai questa luce chiara?”. Da quanto sopra riportato appare ineluttabile un’anima stanca che serenamente sta sulla soglia in attesa dell’altro “fiume”. Un’anima che non sta inerme anche se nel corpo “crollano le fattezze e la figura”, un’anima che spera sempre “d’assaporare la gioia/ di giorni illuminati dal Sole” (v. Allumacando), perché in lei “ ancora si leverà l’occhio e cercare stelle…e il sole anticipante il rosa quasi spento del vespro autunnale…/ (v. Cardine). A tutto questo non è estranea la consapevolezza della presenza di Dio. Dio, afferma la poetessa, “ è in noi/ sta nelle cose che diamo per scontato/ banali all’apparenza/”. E’ il Dio Pantocratore, quell’unico Dio quale fu nella cultura dei nativi americani chiamato “Il Grande Spirito”che offre ai defunti le celesti praterie del cielo e in terra ai vivi la generosità della Natura. Quella stessa Natura amata dalla poetessa in tutte le sue manifestazioni e che Essa estrinseca nei versi in cui l’avverte “ come foglia che dondola al vento/ il pigolio dei passeri/ il filo di un aquilone che scorre”, sensazioni che le procurano gioia, bellezza e amore nonostante che ogni cosa, piccola o grande che sia, la si apprende in un mondo cosparso di pietre e di fango. Ma, al di sopra di queste palpabili negatività, “Lui”, pronome allusivo a Dio, c’è e la vita altro non sarebbe che “ uno schizzo” creato in cielo, una idea, un soffio creatore (biblico), una creazione abbozzata simile alla Pietà Rondanini di Michelangelo a cui solo noi, rimarca la poetessa, possiamo donarle colore, sapore e il giusto umore (v. Cardine). Ma sopra un mondo in cui prosperano insieme gioie e sofferenze, su tutto domina dall’alto il Sole chiamato “ Polline celeste dell’Amore”, inteso come Luce, come fonte di vita, quasi un devoto credo verso un dio supremo che richiama le antiche religioni di alcuni popoli che, separati dall’ignoto mare-oceano, non vennero mai a contatto tra loro come gli egizi e i celti da un lato e gli aztechi ed i maya dall’altro. I romani lo chiamarono Sol Invictus la cui solenne festività finì per confluire, per opportunità politiche, con il Natale cristiano. Nell’esame approfondito di questa raccolta in cui Mariolina La Monica ha racchiuso i suoi pensieri ed esplorato a fondo la sua anima, ciò che si può trarre dalle liriche, a parte quelle poche dedicate a personaggi che tessono di qualità la letteratura, è lo stupore che suscitano giacché non avendo una ben definita unica identità spaziano a tutto campo senza porsi limiti come la costruzione dei versi, delle strofe, la loro architettura. Sono tutti versi sciolti, non ingabbiati in rime e dodecasillabi, perché libera è l’analisi della realtà come libera deve essere la voce alla stregua di quei poeti ritenuti grandi perché fanno capire ciò che hanno da dire usando tecnica semplice e strumenti adatti a ciò. Emblematico il relegare a fondo pagina deduzioni personali come espressioni cavate dal cantuccio del cuore e della mente. Sul numero delle liriche che, come prima anticipato, abbiamo suddiviso in cinquanta più una, Mariolina La Monica in tutte le cinquanta contenute nelle quattro sezioni, mai fa il nome di Ulisse sebbene il titolo “Vagheggiando Itaca” lo richiami. Il suo nome infatti figura solo nella prima parola dell’ultima lirica, la cinquantunesima: “ Ulisse è stanco”, stanco come la poetessa che dopo tanto dire, ne esce stremata, ma non come contraccolpo del suo fisico comunque provato, ma perché ha scandagliato a fondo tutti i perimetri del suo pensiero e ha esaurito e svenato finanche il suo cuore. Una stanchezza che la porta a dire “null’altro voglio che scriva di me il vento” (v. Null’altro) e che fa il paio con quel “non abbiate memoria di me “ ultimo verso dell’ultima lirica di L’Airone celeste di Tommaso Romano. Ma alla fine ciò che in fondo risulta altro non è che un attaccamento alla vita, ma non in quel modo parossistico ma come vita che vale la pena vivere per contemplare ancora la bellezza, la natura, la luce che sono il suo naturale nutrimento. E comunque, come sopradetto, non è affatto un “carpe diem” riconducibile al puro epicureismo sebbene non esula dall’esaltare il godimento della giovinezza quale un fiore finché è “ in sboccio e prima che sfiorisca… finchè non giunga la notte”, ma una esortazione a contrastare, a lottare contro la natura della debolezza umana per cui “più coscienza possiedi, più isola divieni” (v. Non è di gennaio). Ecco come nella poesia di Mariolina, ma in genere in tutte le poesie, ci sono parole che fungono come pietre miliari capaci di illuminare il pensiero del poeta. Perché, ci chiediamo, più si ha consapevolezza profonda del proprio pensiero, più si diventa isola?. Una frase apparentemente enigmatica ma che racchiude uniformemente al pensiero qui esposto la considerazione che nel contrasto a questo “vanaglorioso e scarno presente”, si rischia di restare isolati sommersi da quell’onda anomala, chiarisce la poetessa, che è pioggia di rovine e, aggiungiamo noi, prima che il buio dell’ateismo civile e reale dilaghi. Un’isola che nella romaniana accezione, è altrimenti intesa come ultimo remoto rifugio per resistere al disfacimento dell’umanità e come ultimo baluardo dei valori che trovano nella tradizione la loro nobiltà. Mariolina La Monica non ha, né vuole un’isola, ma parla da una valle, la sua valle che nella accezione semantica si immagina verde dove sosta la pace e dove nasce e prende corpo la sua voce. Una voce che non si pone limiti ma spazi e si erge dapprima quasi in severo trono giudicante per poi declinare nella consapevolezza che a tutto ciò c’è rimedio se si crede e ci si riappropri di quel sentire la natura, di quell’ascoltare il cuore, di quel credere che il mondo in fondo è un dono di Dio. Contorna il suo pensiero lo sfondo di un’anima romantica che fa da contraltare alle domande che la poetessa si pone e ci pone. Quindi tra un punto di partenza (la vita) e uno d’arrivo (la fine) c’è un mare di mistero perché mistero è la vita stessa. Un punto in mezzo al mare, sospeso tra mare e il cielo e come Ulisse ciascuno cercare la sua isola e quella riva che è il punto d’arrivo ma che ancora non vede. Una ricerca quindi che tra domande e risposte, come suggerisce il modo d’indagare socratico, compie e scruta parallelamente un percorso introspettivo che spazia tra la psicologia, la filosofia e l’antropologia. E lo fa prendendo a simbolo proprio il pellegrino uticese che scopre viaggio dopo viaggio, avventura dopo avventura mondi di sofferenza e mondi di pace, mondi di oblio e mondi che dalla magia dominante di Circe o dall’amore genuino di Calipso fino alla candida purezza di Nausicaa, riconducono alla propria terra sebbene tra dubbi e certezze. Ma, conclude la Poetessa, è proprio lo stare in questo mare di dubbi, dove mancano le certezze, che nascono le parole che emergono da quel profondo di cui non conosciamo il principio perché vengono su specchiandosi in ciò che l’animo detta. Nella tecnica puramente intesa ma che pur scaturisce da quel sommovimento dell’animo che nella composizione si esprime, le strofe quasi scompongono il tessuto classico, ma dove tutto poi viene armonizzato con una proposizione avversativa che lega come un ponte, scenari descritti quali fossero tesi, antitesi che si fondono nella sintesi, spesso messa a parte, come riflessione ultimativa del pensiero. E’ quel “ma” oppure “ora” a volte “oppure” che sovvertono, includono escludendo, infine affermando ciò che per il pensiero della poetessa è incontrovertibile. Mariolina La Monica con questa raccolta tratta dell’amarezza e della speranza come una condanna e ma anche come una assoluzione se solo l’uomo saprà riportare in se stesso quei valori che lei sintetizza nelle parole bellezza, armonia, amore. E lo fa con quella pacatezza d’animo e con quella consapevolezza che insieme ad una sorta di gravità e di solennità la fa apparire come una Vestale custode della Natura e dell’Amore che attende al fuoco sacro della Verità e della Famiglia e intesa nell’estensione del termine come salvaguardia dell’umanità. Ma è ora di porci due domande: chi è Ulisse e cosa rappresenta Itaca. Ulisse siamo noi, Ulisse è Mariolina che tra un pensiero e i “rovi quotidiani” che le impone la vita, non dimentica il suo ruolo di governatrice della famiglia (intenta a rigirare frittelle), il tutto mentre cerca di traguardare al meglio e con animo serena la sua vita. Ulisse ha fame di conoscenza, è già disceso nell’Ade, ha visto il “dopo” ma è anche l’uomo normale che cede alla stanchezza e altro non vuole che pace e rendere la sue ossa al patrio lido. Ulisse accetta e difende la sua condizione di mortale ma cerca di mitigare il senso della morte rendendo la sua anima permeabile a quella bellezza che ci offre la Natura e a quell’Armonia che questa vi traspone nel proposito di accostarsi al Vero purché nello spirito alberghi la purezza. Il suo è un viaggio esplorativo e non solo del mondo geograficamente inteso, ma anche di quello suo, del profondo del suo IO. E’ una ricerca che compie tra tanti dubbi ma che “bypassa” conformando il suo destino come Ulisse lo conforma al volere degli dei. Proprio quello che in noi cristiani si traduce in “Sia fatta la volontà di Dio”. Ulisse è l’antesignano dello stoicismo dove prevale il valore del dovere e simile al suo coevo Enea che abbandona la disperata e amata Didone per eseguire il disegno divino di fondare una nuova civiltà, la nuova Roma, quella Roma che considererà suoi lontani parenti quegli Elimi (profughi da Troia come il loro Enea) al punto da dimezzargli le tasse. E veniamo a Itaca. Itaca, come afferma l’Autrice nella sua nota introduttiva, è un “ altrove primordiale situato in uno spazio indefinito, sospeso tra l’acqua e il cielo” e rappresenta in metafora la patria, quella patria che i nostri emigranti, ora come allora, cercano e conservano nei loro cuori, parlando tra loro anche in dialetto per non obliare quella lingua che consenta loro di conservare la loro identità. Itaca è la famiglia che dà protezione, fatta di affetti, comprensione, complicità. Itaca è il rifugio ideale, la casa dove nascono i progetti di vita, dove crescono e si educano i figli, dove si vagheggia un futuro, un porto dove ormeggiare le speranze, dove partono i sogni che non conducano all’espatrio dei suoi giovani componenti. Ma Itaca è anche il simbolo della ricerca, del viaggio della vita, del percorso del destino ma è anche il simbolo del nostro pianeta alla deriva che bisogna ritrovare, un mondo dove imperversano “i Proci”, un’isola che bisogna raggiungere e salvare. E’ uno spazio spirituale dove il limite delle parole apre le porte dell’Oltre alla ricerca del suo intimo, del suo IO. E’ in fondo la ricerca del proprio spirito nel mare dell’incertezza perché è solo stando in mezzo a quel mare che si può meditare, interloquire con se stessi, sognare. E’ questo il senso del “viaggio” che Mariolina La Monica compie e lei con noi, e in ciò sta la grandezza della sua poesia.
Non è facile approdare alle rive di Vagheggiando Itaca (Ed, Thule, Palermo 2016) se non imbarcandosi con Mariolina La Monica su una zattera e percorrere con lei tutto il viaggio poetico fino all’ultima esplicativa lirica. Una zattera, quella rabberciata sull’isola di Ogigia da Ulisse, che non è la Zattera della Medusa di Theodore Gericaut e tuttavia bisogna seguirla pedissequamente per cogliere tra i tanti prati seminati di concetti e parole, come fiume in piena, quel tanto che sa d’infinito nel tanto piccolo orizzonte umano. Un orizzonte dove accanto al contingente del quotidiano si staglia quello esistenziale e dell’Oltre. E’ un viaggio dove l’ombra di Ulisse, ma solo l’ombra, permea tutto il percorso lirico della poetessa in quanto viaggio di un uomo alla ricerca della sua anima, del suo definitivo approdo. Un viaggio temporale e apparentemente materiale ma che la poetessa compie anche in funzione introspettiva e durante il quale emergono amare considerazioni insieme a luci di speranze, il tutto vissuto come una sospensione tra il mare dove si trova e il cielo, tra mente e anima, tra corpo e spirito. La raccolta, composta da cinquanta e una lirica, forma una circolarità dove l’ultimo verso di quest’ultima ritorna e offre il titolo alla raccolta e non a caso. Ma c’è un diverso indizio che rivela a metà i temi ivi contenuti e sta nel primo verso posto nel frontespizio: “ Scivola a fondovalle il corpo stanco” facendo da “pendant” col primo verso della stessa ultima lirica (che abbiamo staccata dal “corpo”): “ Ulisse è stanco”. Una sensazione che traspare dall’insieme e che emerge dalle meditazioni corpose e numerose che la Nostra espone con domande che si pone e ci pone, tanto che a ben vedere il tutto assurge a tracciare un mediatico percorso di filosofia che appare a tratti come cosmica perché universale è il suo pensiero. Un percorso che parla degli affanni del quotidiano e che vengono poi esposti alla luce della speranza. Uno stare a mezz’aria, in mezzo al mare come la zattera di Ulisse che cerca la sua isola ma non la scorge, l’avverte nel suo sentire ma non la materializza e intanto sta lì nell’attesa che si compie il suo destino come chi sulla soglia sa che dovrà varcarla con serenità d’animo giacché, afferma la poetessa, non siamo altro che dei calchi che producono altri calchi. E ciò ci richiama alla mente i versi di un altro poeta in un’altra poesia “Solo un anello” (in “Poieteche” – Thule, Palermo 2006) laddove si paragone la vita a “quella della catena di una nave/ che l’ancora inesorabile/ tira giù/ e per uno che sprofonda/ un altro sbuca fuori sopra il mare” . Ma c’è ancora un altro indizio che preclude e cela, e insieme svela il sentire della voce della raccolta e sta nella pagina della dedica “ai miei amori”. E’ una frase esplicativa, quasi un’esortazione:” Per te che sogni/ e superi le ombre e il tempo della morte/ gioconda si libra la mia speme/ al pieno sole”. In questo ci sono tre parole emblematiche che indirizzano a percepire lo snodo del viatico poetico: morte, speranza e sole. E’ in queste il senso del superamento del tempo del dopo-vita senza perdere la speranza di vedere ed essere confortati dalla luce. Il volume manca della prefazione, solo una postfazione dell’ottima Franca Alaimo e supplita da una nota dell’Autrice che anticipa e chiarisce la metafora di un’isola, Itaca, cercata a lungo da Ulisse e rappresentante la patria perduta. Non siamo al canto verdiano del “Nabucco” perché Itaca rappresenta un “luogo” dove lo spirito trova il giusto respiro nel quale trovare la forza di resistere a restare. E non a caso la poetessa chiude la raccolta con “ stare/ stare sul mare/ vagheggiando Itaca!”. Ma è solo un incitamento, una speranza perché nelle cinquanta liriche si snodano e vi emergono i dubbi, le sofferenze, il dolore controbilanciati dalla bellezza, “ ho visto…giardini di pesco e filari di vigne maturati al sole/…fringuelli di liberi trilli… furono essi a scovare in me la bellezza” (v. Viaggio) o ancora dalla gioia nel vedersi circondata dallo splendore del creato rispetto alla pochezza del quotidiano “…intanto che le stelle adornano la notte/ e alla finestra fiorisce lento/ il fiore taciturno dell’aurora/… e nelle albe in cui luna e stelle/ danno il loro ultimo bacio a questa terra” (v. Abbraccio notturno). Un inno al Creato come fosse il rinverdire “Il cantico delle creature” o meglio conosciuto come “Il cantico di Frate Sole”, come qui conviene, del Poverello d’Assisi. Mariolina La Monica ama tutto ciò, ne assapora nel suo intimo quel senso che la riappacifica alla vita, sebbene minata nel fisico “per le fragili ossa che io sono/ e che mi fanno giocattolo”. Parla del dopo-vita in modo sereno sperando solo, nella restante “collana di giorni”, di non essere di peso per non opprimere il petto dei “suoi amori”, quegli amori a cui è dedicata la presente raccolta. L’opera è divisa in quattro sezioni (La Luce, Amicizia e Amore, Arbusti e Il Margine al Cuore. In copertina la raffigurazione opacizzata di un mare procelloso. Quel mare che lei ama perché, a parte il suo annuale incontro estivo con l’esplosione della sua naturale bellezza, dopo l’inquieto inverno, rappresenta la natura stessa della vita vissuta, spesso in ansia, talvolta tempestosa. Ma tutto dimentica come il suo Ulisse che “bacia la tempesta e fa vela alla sua isola sperata”. Un’isola “assurdamente voluta”, cioè contro ogni logica oggettiva. Perché assurdamente, ci chiediamo?. Perché, secondo la nostra personale interpretazione, al di là del “carpe diem”, della “dolce vita” nei sette anni trascorsi accanto alla bella Calipso ( non sappiamo, né Omero lo lascia percepire se ha avuto dei figli) e nonostante fosse stato visto dalla romantica Nausicaa “ bello di fama e di sventura” come lo canta il Foscolo per il destino che li accomuna, nonostante tutto questo e senza avere mai avuto notizie della sua famiglia, ha un dovere da compiere, il ritorno alla sua Patria, certo un nobile sentimento, ma per esaudire le suppliche di Penelope alla dea Athena sua protettrice come lo era dello Stato e delle leggi e soprattutto per eseguire la volontà di Zeus. Quindi, in un certo senso è infuso in Ulisse il valore stoico della sua missione raccolto in un trinomio che costituirà nei secoli avvenire un indirizzo, quella base ideologica che giungerà fino a Mazzini che la sintetizzerà nel motto “Dio, Patria, Famiglia” tre dei fondamentali del suo apostolato, base su cui si esplicheranno i doveri dell’uomo e che sono presenti in Ulisse sia verso gli dei (Zeus), sia verso la patria (Itaca) che verso la famiglia (la sposa e il figlio). E’ la filosofia dei doveri e che in fondo riflette in parte anche la stoicità della poetessa, quando assolve i suoi compiti verso i suoi amori come i figli “sudati ad uno ad uno senza sconti/ resi adulti/ non consoni alla compravendita”. Ed è qui sui ragazzi d’oggi che si innesta una sorta di lirica filippica contro una società in cui “questi nostri figli, cittadini del mondo…colti manovali speranzosi…che per difendersi dagli attacchi della sorte (un vero eufemismo) …espatriano (v. Sereno infranto) mentre altri “mammut che incombono tra i pilastri… per non soffrire come è dato ai furbi”. E’ un’amara considerazione sui valori del vivere odierno e sull’estremo laicismo d’un mondo corrotto mentre sottolinea “ a immaginare le cose la gente di questa vita/ in un mondo più verace ed equo/ in cui più alcun dolore esista che l’animo c’opprima/… se l’occhio ristretto del livore/ non affresca con colori di sereno il proprio cuore/ ” (v. Il sogno più grande). E a rimarcare ciò ecco confermato nei versi “un po’ più in là/ dalle fumose nebbie del presente… oggi, dilaga l’onda della riva aperta”/ (v. Calcinacci). Ma, a parte queste constatazioni sul contingente, dal sapore socio-politico, la Nostra riserva la sua verve alla ricerca della sua anima, una introspezione che pervade grande spazio della raccolta. Un riflesso di uno specchio esistenziale soprattutto riguardo la morte nei versi : “ pur se implacabile/ l’autunno si fa inverno/ lentamente gli impeti d’Acheronte inonderanno l’aria…/”…o ancora in “ ora che il tempo piano mi scompone/ mi chiedo inutilmente cosa siamo/ se non dei calchi/ resi nomi da altri calchi/” e infine “ quando riapparirà il tarlo alla mia soglia/ mi mostrerò alla luce per marcire”. Ecco in queste meditazioni appare la contrapposizione ombra-luce che richiama alla memoria il titolo della sua prima raccolta “Dall’ombra e dalla luce” (1997) e che qui si presenta nella dicotomia Acheronte-Luce così come richiamato in un frammento dei Carmina di Orazio (“Melanippo, ubriacati con me/ sceso di là dai gorghi d’Acheronte,oltre il varco/ vedrai questa luce chiara?”. Da quanto sopra riportato appare ineluttabile un’anima stanca che serenamente sta sulla soglia in attesa dell’altro “fiume”. Un’anima che non sta inerme anche se nel corpo “crollano le fattezze e la figura”, un’anima che spera sempre “d’assaporare la gioia/ di giorni illuminati dal Sole” (v. Allumacando), perché in lei “ ancora si leverà l’occhio e cercare stelle…e il sole anticipante il rosa quasi spento del vespro autunnale…/ (v. Cardine). A tutto questo non è estranea la consapevolezza della presenza di Dio. Dio, afferma la poetessa, “ è in noi/ sta nelle cose che diamo per scontato/ banali all’apparenza/”. E’ il Dio Pantocratore, quell’unico Dio quale fu nella cultura dei nativi americani chiamato “Il Grande Spirito”che offre ai defunti le celesti praterie del cielo e in terra ai vivi la generosità della Natura. Quella stessa Natura amata dalla poetessa in tutte le sue manifestazioni e che Essa estrinseca nei versi in cui l’avverte “ come foglia che dondola al vento/ il pigolio dei passeri/ il filo di un aquilone che scorre”, sensazioni che le procurano gioia, bellezza e amore nonostante che ogni cosa, piccola o grande che sia, la si apprende in un mondo cosparso di pietre e di fango. Ma, al di sopra di queste palpabili negatività, “Lui”, pronome allusivo a Dio, c’è e la vita altro non sarebbe che “ uno schizzo” creato in cielo, una idea, un soffio creatore (biblico), una creazione abbozzata simile alla Pietà Rondanini di Michelangelo a cui solo noi, rimarca la poetessa, possiamo donarle colore, sapore e il giusto umore (v. Cardine). Ma sopra un mondo in cui prosperano insieme gioie e sofferenze, su tutto domina dall’alto il Sole chiamato “ Polline celeste dell’Amore”, inteso come Luce, come fonte di vita, quasi un devoto credo verso un dio supremo che richiama le antiche religioni di alcuni popoli che, separati dall’ignoto mare-oceano, non vennero mai a contatto tra loro come gli egizi e i celti da un lato e gli aztechi ed i maya dall’altro. I romani lo chiamarono Sol Invictus la cui solenne festività finì per confluire, per opportunità politiche, con il Natale cristiano. Nell’esame approfondito di questa raccolta in cui Mariolina La Monica ha racchiuso i suoi pensieri ed esplorato a fondo la sua anima, ciò che si può trarre dalle liriche, a parte quelle poche dedicate a personaggi che tessono di qualità la letteratura, è lo stupore che suscitano giacché non avendo una ben definita unica identità spaziano a tutto campo senza porsi limiti come la costruzione dei versi, delle strofe, la loro architettura. Sono tutti versi sciolti, non ingabbiati in rime e dodecasillabi, perché libera è l’analisi della realtà come libera deve essere la voce alla stregua di quei poeti ritenuti grandi perché fanno capire ciò che hanno da dire usando tecnica semplice e strumenti adatti a ciò. Emblematico il relegare a fondo pagina deduzioni personali come espressioni cavate dal cantuccio del cuore e della mente. Sul numero delle liriche che, come prima anticipato, abbiamo suddiviso in cinquanta più una, Mariolina La Monica in tutte le cinquanta contenute nelle quattro sezioni, mai fa il nome di Ulisse sebbene il titolo “Vagheggiando Itaca” lo richiami. Il suo nome infatti figura solo nella prima parola dell’ultima lirica, la cinquantunesima: “ Ulisse è stanco”, stanco come la poetessa che dopo tanto dire, ne esce stremata, ma non come contraccolpo del suo fisico comunque provato, ma perché ha scandagliato a fondo tutti i perimetri del suo pensiero e ha esaurito e svenato finanche il suo cuore. Una stanchezza che la porta a dire “null’altro voglio che scriva di me il vento” (v. Null’altro) e che fa il paio con quel “non abbiate memoria di me “ ultimo verso dell’ultima lirica di L’Airone celeste di Tommaso Romano. Ma alla fine ciò che in fondo risulta altro non è che un attaccamento alla vita, ma non in quel modo parossistico ma come vita che vale la pena vivere per contemplare ancora la bellezza, la natura, la luce che sono il suo naturale nutrimento. E comunque, come sopradetto, non è affatto un “carpe diem” riconducibile al puro epicureismo sebbene non esula dall’esaltare il godimento della giovinezza quale un fiore finché è “ in sboccio e prima che sfiorisca… finchè non giunga la notte”, ma una esortazione a contrastare, a lottare contro la natura della debolezza umana per cui “più coscienza possiedi, più isola divieni” (v. Non è di gennaio). Ecco come nella poesia di Mariolina, ma in genere in tutte le poesie, ci sono parole che fungono come pietre miliari capaci di illuminare il pensiero del poeta. Perché, ci chiediamo, più si ha consapevolezza profonda del proprio pensiero, più si diventa isola?. Una frase apparentemente enigmatica ma che racchiude uniformemente al pensiero qui esposto la considerazione che nel contrasto a questo “vanaglorioso e scarno presente”, si rischia di restare isolati sommersi da quell’onda anomala, chiarisce la poetessa, che è pioggia di rovine e, aggiungiamo noi, prima che il buio dell’ateismo civile e reale dilaghi. Un’isola che nella romaniana accezione, è altrimenti intesa come ultimo remoto rifugio per resistere al disfacimento dell’umanità e come ultimo baluardo dei valori che trovano nella tradizione la loro nobiltà. Mariolina La Monica non ha, né vuole un’isola, ma parla da una valle, la sua valle che nella accezione semantica si immagina verde dove sosta la pace e dove nasce e prende corpo la sua voce. Una voce che non si pone limiti ma spazi e si erge dapprima quasi in severo trono giudicante per poi declinare nella consapevolezza che a tutto ciò c’è rimedio se si crede e ci si riappropri di quel sentire la natura, di quell’ascoltare il cuore, di quel credere che il mondo in fondo è un dono di Dio. Contorna il suo pensiero lo sfondo di un’anima romantica che fa da contraltare alle domande che la poetessa si pone e ci pone. Quindi tra un punto di partenza (la vita) e uno d’arrivo (la fine) c’è un mare di mistero perché mistero è la vita stessa. Un punto in mezzo al mare, sospeso tra mare e il cielo e come Ulisse ciascuno cercare la sua isola e quella riva che è il punto d’arrivo ma che ancora non vede. Una ricerca quindi che tra domande e risposte, come suggerisce il modo d’indagare socratico, compie e scruta parallelamente un percorso introspettivo che spazia tra la psicologia, la filosofia e l’antropologia. E lo fa prendendo a simbolo proprio il pellegrino uticese che scopre viaggio dopo viaggio, avventura dopo avventura mondi di sofferenza e mondi di pace, mondi di oblio e mondi che dalla magia dominante di Circe o dall’amore genuino di Calipso fino alla candida purezza di Nausicaa, riconducono alla propria terra sebbene tra dubbi e certezze. Ma, conclude la Poetessa, è proprio lo stare in questo mare di dubbi, dove mancano le certezze, che nascono le parole che emergono da quel profondo di cui non conosciamo il principio perché vengono su specchiandosi in ciò che l’animo detta. Nella tecnica puramente intesa ma che pur scaturisce da quel sommovimento dell’animo che nella composizione si esprime, le strofe quasi scompongono il tessuto classico, ma dove tutto poi viene armonizzato con una proposizione avversativa che lega come un ponte, scenari descritti quali fossero tesi, antitesi che si fondono nella sintesi, spesso messa a parte, come riflessione ultimativa del pensiero. E’ quel “ma” oppure “ora” a volte “oppure” che sovvertono, includono escludendo, infine affermando ciò che per il pensiero della poetessa è incontrovertibile. Mariolina La Monica con questa raccolta tratta dell’amarezza e della speranza come una condanna e ma anche come una assoluzione se solo l’uomo saprà riportare in se stesso quei valori che lei sintetizza nelle parole bellezza, armonia, amore. E lo fa con quella pacatezza d’animo e con quella consapevolezza che insieme ad una sorta di gravità e di solennità la fa apparire come una Vestale custode della Natura e dell’Amore che attende al fuoco sacro della Verità e della Famiglia e intesa nell’estensione del termine come salvaguardia dell’umanità. Ma è ora di porci due domande: chi è Ulisse e cosa rappresenta Itaca. Ulisse siamo noi, Ulisse è Mariolina che tra un pensiero e i “rovi quotidiani” che le impone la vita, non dimentica il suo ruolo di governatrice della famiglia (intenta a rigirare frittelle), il tutto mentre cerca di traguardare al meglio e con animo serena la sua vita. Ulisse ha fame di conoscenza, è già disceso nell’Ade, ha visto il “dopo” ma è anche l’uomo normale che cede alla stanchezza e altro non vuole che pace e rendere la sue ossa al patrio lido. Ulisse accetta e difende la sua condizione di mortale ma cerca di mitigare il senso della morte rendendo la sua anima permeabile a quella bellezza che ci offre la Natura e a quell’Armonia che questa vi traspone nel proposito di accostarsi al Vero purché nello spirito alberghi la purezza. Il suo è un viaggio esplorativo e non solo del mondo geograficamente inteso, ma anche di quello suo, del profondo del suo IO. E’ una ricerca che compie tra tanti dubbi ma che “bypassa” conformando il suo destino come Ulisse lo conforma al volere degli dei. Proprio quello che in noi cristiani si traduce in “Sia fatta la volontà di Dio”. Ulisse è l’antesignano dello stoicismo dove prevale il valore del dovere e simile al suo coevo Enea che abbandona la disperata e amata Didone per eseguire il disegno divino di fondare una nuova civiltà, la nuova Roma, quella Roma che considererà suoi lontani parenti quegli Elimi (profughi da Troia come il loro Enea) al punto da dimezzargli le tasse. E veniamo a Itaca. Itaca, come afferma l’Autrice nella sua nota introduttiva, è un “ altrove primordiale situato in uno spazio indefinito, sospeso tra l’acqua e il cielo” e rappresenta in metafora la patria, quella patria che i nostri emigranti, ora come allora, cercano e conservano nei loro cuori, parlando tra loro anche in dialetto per non obliare quella lingua che consenta loro di conservare la loro identità. Itaca è la famiglia che dà protezione, fatta di affetti, comprensione, complicità. Itaca è il rifugio ideale, la casa dove nascono i progetti di vita, dove crescono e si educano i figli, dove si vagheggia un futuro, un porto dove ormeggiare le speranze, dove partono i sogni che non conducano all’espatrio dei suoi giovani componenti. Ma Itaca è anche il simbolo della ricerca, del viaggio della vita, del percorso del destino ma è anche il simbolo del nostro pianeta alla deriva che bisogna ritrovare, un mondo dove imperversano “i Proci”, un’isola che bisogna raggiungere e salvare. E’ uno spazio spirituale dove il limite delle parole apre le porte dell’Oltre alla ricerca del suo intimo, del suo IO. E’ in fondo la ricerca del proprio spirito nel mare dell’incertezza perché è solo stando in mezzo a quel mare che si può meditare, interloquire con se stessi, sognare. E’ questo il senso del “viaggio” che Mariolina La Monica compie e lei con noi, e in ciò sta la grandezza della sua poesia.