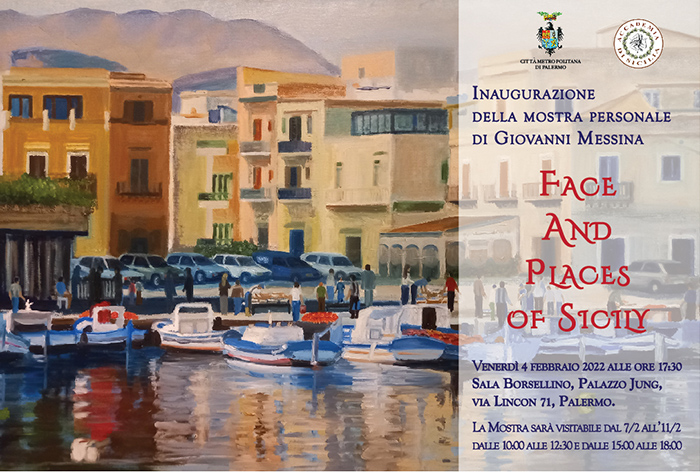“La Luce di Biagio” di Serena Lao
- Dettagli
- Category: Polis
- Creato: 25 Maggio 2023
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1534
 Quando lo incontrai per la prima volta tutti lo chiamavano solamente Biagio. Erano gli anni novanta, è trascorso tanto tempo, ma ricordo con dovizia di particolari ogni istante di quel giorno in cui varcai timorosa ed emozionata l’ingresso della Missione Speranza e Carità, la cui unica sede era allora in via Archirafi.
Quando lo incontrai per la prima volta tutti lo chiamavano solamente Biagio. Erano gli anni novanta, è trascorso tanto tempo, ma ricordo con dovizia di particolari ogni istante di quel giorno in cui varcai timorosa ed emozionata l’ingresso della Missione Speranza e Carità, la cui unica sede era allora in via Archirafi.Ero giovane e lontana dai veri valori spirituali. Forse ero atea forse no, vivevo in un mondo tutto mio fatto di sogni e di effimere concretezze.
Avevo iniziato da poco a muovere i primi passi nel mondo della cultura e dello spettacolo. Cantavo e recitavo! Quella era stata da sempre la mia aspirazione e, inconsapevolmente, con fatica, mi stavo incamminando verso un futuro in cui la mia passione artistica si sarebbe trasformata in autentica professione. Piccoli concertini in cui interpretavo canti della tradizione siciliana, qualche apparizione in tv locali dove, insieme a una compagnia di attori, mi esibivo in sketch di cabaret. Ma tutto ciò non bastava a riempire i malesseri esistenziali che mi opprimevano. La mia famiglia aveva reagito negativamente a quella scelta e i rapporti con loro si erano deteriorati. Il sostegno economico che mi elargivano fu drasticamente interrotto. La cosa mi faceva star male non tanto per l’aspetto materiale, ma soprattutto perché mi mancava mia madre! Durante le performance, con il pubblico plaudente, mi illudevo di essere felice, ma, passata l’ebbrezza momentanea, ripiombavo nella solitudine. I miei parenti mi avevano quasi ripudiato, amici ne avevo pochi. Tutto questo, aggiunto alle difficoltà economiche a cui spesso non riuscivo a fare fronte, era bastante per farmi vivere in continua apprensione.
Ebbe inizio uno dei periodi più oscuri e contraddittori della mia esistenza. Quando ero su di un palco o in tv scordavo i travagli quotidiani e mi sentivo appagata. Dopo, finito l’effetto dell’adrenalina, ripiombavo in quella che stava prendendo le sembianze di una vera e propria depressione.
La solitudine mi pesava, ma tutto sommato riuscivo a conviverci, quello a cui non sapevo trovare soluzione era la carenza di denaro. Ero agli inizi della carriera, i cachet erano minimi, non sufficienti, quindi, ad autogestirmi. Le bollette le pagavo sempre con ritardo, avevo difficoltà anche per l’acquisto di beni di prima necessità. Fare la spesa era divenuto un problema.
Conobbi, in quel periodo, musicisti, attori, organizzatori, ma, salvo qualche rara eccezione, con nessuno di loro strinsi rapporti di amicizia, erano semplici conoscenze legate in qualche modo al lavoro. Da giovane non ero bella ma carina sì, molti sostenevano che fossi sensuale e spesso ero costretta a difendermi dalle avance moleste di uomini senza scrupoli che, con il pretesto di aiutarmi a far carriera, volevano procurarsi la facile avventura.
Ma le eccezioni sfuggono alle regole e con Antonio fu tutta un’altra storia. Era un giovane chitarrista gentile e sensibile, sempre disponibile e premuroso nei miei confronti. Era altresì un bravo fotografo e conservo ancora un bel servizio fotografico realizzato da lui nel mio appartamento. In breve divenne il mio migliore amico e trascorrevo molto tempo in sua compagnia. Presumo fosse innamorato, una donna certe cose le intuisce, ma non approfondii mai la cosa; gli volevo bene ma non contraccambiavo i suoi sentimenti, era inutile indagare!
Spesso, non essendo autonoma per spostarmi - non avevo ancora un’autovettura mia - era lui che dopo le prove mi accompagnava a casa. Una sera, manifestando una gran voglia di pollo allo spiedo, si fermò davanti a una polleria. Mi pregò di attenderlo e, dopo poco, tornò con due involucri fumanti, uno me lo porse dichiarando dolcemente: “Lo mangerai a cena, così mi penserai”. Sapeva tutto di me e quelle soste davanti a pizzerie, pollerie e generi alimentari si ripeterono ancora. Non mi ferì mai, non mi fece mai pesare la mia condizione, non mi fece sentire mai in imbarazzo. Adducendo dei pretesti più o meno credibili, con garbo mi offriva il sostegno e la tenerezza di cui avevo bisogno e che io prendevo a piene mani.
Il fato, intanto, come un abile ragno, stava intessendo la sua tela. Pian piano cominciai a ingranare. Certo non divenni ricca, ma le mie condizioni economiche migliorarono. Facevo numerosi concerti in giro per la Sicilia e potevo permettermi di non mangiare più solo legumi e patate. Di frequente, dopo gli spettacoli, l’organizzazione ci invitava a cena e potevo gustare prelibatezze tipiche dei luoghi che ci ospitavano.
Il tempo inesorabilmente passava e, come capita nella vita, con Antonio - non so come né perché - ci perdemmo di vista. Ma quel mezzo pollo con patate arrosto, mangiato nell’isolamento della mia cucina e offertomi col cuore, non lo dimenticherò mai. Non lo vidi più. Dopo diversi anni seppi che era morto per un arresto cardiaco. Piansi. Era così giovane! E poi era nobile e generoso. Mi offriva il suo appoggio, ma non ci provò mai, e questo rendeva ancora più caro il suo ricordo. Povero dolce Antonio.
Tornando agli inizi, la mia esistenza, tranne la parentesi in cui cantavo, recitavo o componevo, era avvilente. Sì, componevo da sempre: poesie, canzoni, racconti. Quando mi immergevo nella scrittura, lasciavo la fantasia libera di volare estraniandomi dalla realtà, ma dopo tornavo con i piedi per terra a fare i conti con le mie frustrazioni. Con i familiari ero sempre in rotta, quindi nulla potevo sperare, e poi sarebbe stato umiliante accettare il loro aiuto. Frattanto le bollette continuavano ad arrivare e dovevo pagarle, la spesa al supermercato dovevo farla, con quali soldi, però, non lo sapevo. Ero ricorsa perfino al Monte dei pegni e lì avevo impegnato piccoli oggettini d’oro, ma non avevo risolto granché. Ricordo quel luogo con inquietudine, un brutto posto che non mi appartiene e dove spero di non tornarci mai più. Avevo una sorta di compagno, in quel periodo, ma era più squattrinato di me. Non saprei dire se il mio fosse stato amore, mi aggrappavo a lui per non crollare e quando lo mollai per i suoi frequenti tradimenti, mi sentii mancare il terreno sotto i piedi. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Ora ero veramente sola! La malinconia divenne la mia unica compagna. Le lunghe notti insonni le trascorrevo a rimuginare, crollavo all’alba e poi dormivo fino a ora di pranzo. Dopo aver spilluzzicato qualcosa, me ne stavo a bighellonare per casa come un’anima in pena. In verità, però, proprio sola non ero, arrivava puntuale, infatti, la telefonata di Antonio che mi proponeva di incontrarci per provare alcuni brani musicali. Era chiaro che fosse un espediente per vedermi; conoscevamo il repertorio alla perfezione, ma stavo al suo gioco perché mi faceva comodo, giusto per uscire da quel letargo in cui mi rintanavo. Perché non ricambiai i suoi sentimenti questo non lo so, eppure era un bel ragazzo! Me lo chiedo ancora oggi, a distanza di tanti anni, e non so darmi una risposta.
Di notte, a letto, non riuscivo a dormire e i pensieri si accavallavano nelle mente. L’angoscia era un turbine furioso che m’investiva. Mi chiedevo chi fossi e cosa ci facessi in questo mondo. La fede, allora, era lontana dalla mia percezione.
Ero stanca di lottare e poi perché, per cercare di assecondare il mio talento - se mai lo avessi avuto? - . Cosa c’era di sbagliato in tutto questo? A chi stavo facendo del male? Cominciai ad accarezzare idee bislacche e pericolose, che giorno dopo giorno prendevano sempre più corpo. “E se chiudessi gli occhi per sempre?” pensavo. “Finalmente riposerei e mi libererei della tensione fisica e psichica che mi soffoca”.
Da qualche tempo possedevo un’automobile, dono di Antonio. Era una vecchia cinquecento gialla che lui non usava perché ne possedeva una più grande e più nuova. Per me costituiva una vera conquista, permettendomi di spostarmi con libertà da un punto all’altro della città.
Dopo pranzo, spesso uscivo con la mia minuscola utilitaria per sbrigare qualche commissione, poi, dopo avere assolto alle varie incombenze, girovagavo senza meta per ore. Alla fine, esausta e avvilita, rientravo.
Quel pomeriggio, però, di fare ritorno a casa non ne avevo proprio voglia. Camminavo… camminavo e, mentre guidavo, sinistre evasioni facevano capolino nella mia mente ottenebrata. Mi diressi verso il porto e, una volta entrata, perlustrai il posto come se cercassi qualcosa. Mi fermai a osservare le scure e limacciose acque che con il loro ostile fluttuare mi attraevano paurosamente.
Sarebbe bastato così poco! Un colpo di acceleratore e avrei trovato la pace.
Ma qualcosa dentro me non era pronto a compiere quel definitivo e sciagurato passo. La Vita, caparbia, mi stringeva ancora tra le sue braccia.
Mi scossi… e, facendo retromarcia, mi allontanai veloce e uscii dal porto. Mi ritrovai di nuovo nel bel mezzo del traffico cittadino. Procedevo a velocità contenuta, come se non sapessi di preciso dove andare, e in effetti era così. Chissà se esisteva davvero un Aldilà, pensai.
Vagabondando, le ruote dell’auto mi condussero, quasi inconsapevolmente, in una strada da me non frequentata abitualmente, e si fermarono dinanzi a un grande cancello con sopra un’insegna su cui vi era scritto: MISSIONE DI SPERANZA E CARITÀ.
Frenai e spensi il motore. Con la testa tra le mani mi appoggiai al volante per riordinare le idee. Perché mi trovavo lì? Me lo chiesi più volte, ma non trovai risposta! Avevo sentito parlare di Biagio Conte, un missionario laico che si occupava degli ultimi che dormivano per strada, di coloro che cercavano rifugio dalle brutture del mondo, ma non mi ero soffermata più di tanto.
Apprezzavo il suo operato, ma conoscevo parzialmente la sua storia. Sapevo che intorno al 1991 aveva abbandonato gli agi in cui viveva in famiglia e si era dedicato a dare conforto ai senzatetto ed emarginati. La sua Missione, inizialmente, era nata sulla strada, sotto i portici della Stazione Centrale di Palermo, tra i vagoni in disuso in cui si rifugiavano vagabondi, alcolisti, ex detenuti, migranti. Di sera, assieme ad alcuni volontari, portava loro coperte e pasti caldi. Ma la sua più grande aspirazione era avere una struttura dove potere accogliere coloro a cui la vita non offriva più nulla e che sulle orme di San Francesco chiamava fratelli.
Ogni tanto, seguendo i notiziari in tv, mi imbattevo in qualche servizio dove lo si poteva vedere, accampato come un barbone, in qualche angolo di Palermo, una volta addirittura sotto i portici delle Poste Centrali. Faceva lo sciopero della fame per sensibilizzare chi stava al potere. Con voce accorata ma flebile per i tanti giorni di digiuno, invocava attenzione e amore verso i più fragili, disprezzando la superficialità e strafottenza di chi, avendo tutto dalla vita, si girava dall’altra parte.
Poi… dopo svariate proteste, gli era stato concesso di utilizzare i locali di via Archirafi, ex disinfettatoio comunale, - che avevo proprio li davanti a me - dove aveva fondato la Missione di Speranza e Carità che accoglieva tutti i derelitti della città.
Fui alquanto stupita di quella inspiegabile sosta.
“E ora che faccio?” pensai. Dopo non so quanto tempo, come guidata da una forza misteriosa, aprii lo sportello del veicolo, scesi e lentamente, quasi a rallentatore, m’incamminai verso l’entrata.
Varcato l’ingresso, nello spazio all’aperto che precedeva la costruzione, incrociai tante persone di diverse etnie che mi osservavano con stupore come fossi un marziano. Erano gli ospiti della Missione che, superata la momentanea curiosità, mi elargivano larghi sorrisi che, travalicando la sofferenza impressa nei loro volti, mi offrivano quella speranza di cui avevo tanto bisogno.
Col cervello annebbiato, le idee confuse e barcollando come gli ubriachi, attraversai saloni e camerate. Forse ero giunta lì perché, senza rendermene conto, come gli emarginati, anch’io cercavo un rifugio, un luogo dove ristorare l’anima. Il mio spirito era malato, aveva urgenza di un balsamo che lenisse le ferite.
Incedevo titubante, guardandomi attorno, ed ecco che in uno di quegli stanzoni, in lontananza, vidi due figure venire nella mia direzione. Uno era fratel Biagio, lo riconobbi avendolo più volte visto in tv, l’altro era don Pino, sacerdote e suo braccio destro. Mi accolsero con tanto affetto come se mi avessero conosciuta da sempre. I loro eterei e benevoli sorrisi li ricordo ancora oggi e mi si increspa la pelle per l’emozione. Quando fummo a distanza ravvicinata scoppiai in un pianto irrefrenabile. Intuendo il mio disagio i loro sguardi si fecero ancora più amorevoli.
Fu fratel Biagio a proferir parola per primo: “Sorella, che ti succede? Siediti e dicci cosa possiamo fare per te. La sua voce era soave, come pure l’intonazione, era il balsamo che avevo tanto agognato per il mio cuore dolente. Ciò che mi colpì particolarmente furono i suoi occhi di un colore celeste mare dai quali si irradiava una luce che poco aveva di terreno. Fu la volta di don Pino a parlare: Sorella, piangi pure, le tue lacrime sono liberatorie, poi, se vorrai, ci racconterai di te e mi sorrise ancora.
Ovviamente non me lo feci ripetere; avevo tanta voglia di esporre le mie pene a qualcuno che mi ascoltasse e singhiozzando vuotai il sacco, non tralasciando alcun particolare della mia esistenza.
Mi ascoltarono con grande interesse, mi consigliarono, mi consolarono e per la prima volta, dopo tanto tempo, mi sentii capita. Nessun giudizio, nessun rimprovero. Mi dissero che l’Arte era un dono di Dio e che non mi sarei dovuta sentire in colpa. Ogni parola di Biagio mi arrivava come un messaggio divino, una benedizione, ogni consiglio di Don Pino era carità umana e spirituale. Il mio sguardo era come calamitato dalla luce di Biagio, ma non erano solo gli occhi a emanarla, tutto il suo essere era Luce! La sua dolcezza, il suo tono pacato, il suo entusiasmo quasi fanciullesco, mi ricordavano tanto la letizia francescana.
Rimasi un paio di ore in loro compagnia, due ore piene, intense, ricche di fervore e misticismo.
Don Pino mi confessò e mi dette l’assoluzione e insieme a loro pregai. Poi un grande abbraccio a entrambi e andai.
Uscii dalla Missione che erano le 20,00 o forse le 21,00. Era molto tardi ma non me ne curai. Ero rigenerata: avevo fame e mi avevano sfamato, avevo sete e mi avevano dissetato. Mi avviai verso la mia auto come una farfalla che svolazza felice incontro a una giornata di sole, anche se fuori era buio fitto.
La fede - che in fondo all’anima cercavo - era entrata nella mia esistenza dalla porta principale. Ora credevo, sì credevo! Tutto il mio essere sprigionava gioia.
Passò altro tempo, i miei giorni erano pieni e appaganti. Ora ero una cantautrice popolare siciliana apprezzata e applaudita ovunque, sia che mi esibissi nei teatri che nelle piazze, ma non dimenticai mai quell’incontro che aveva dato una sterzata alla mia vita. Non ho mai parlato né mai parlerò di miracolo. Posso tuttavia riferire di un incontro provvidenziale e carismatico che mi aveva tirato fuori dal baratro in cui stavo precipitando, facendomi vedere la realtà da una prospettiva ottimistica e positiva. E cosa importantissima ero tornata a pregare! Avevo pregato tanto con fratel Biagio e don Pino e la sensazione rimasta era di un’immensa pace interiore.
Divenni un’assidua frequentatrice della Missione. Andavo ad assistere alla messa, m’intrattenevo a conversare con gli ospiti e qualche volta portavo loro dei regalini.
Si avvicinava il Natale e assieme ai musicisti stavo preparando il repertorio natalizio: erano canti della tradizione siciliana in cui si narrava di Gesuzzu Bamminu e della sua umile nascita.
Quell’anno fummo scritturati da molti paesi della Sicilia per proporre la nostra rappresentazione. Anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo ci assegnò due date. Era Natale, pertanto fummo destinati in luoghi di sofferenza: l’Ospedale “Cervello” e l’Istituto Penale Minorile “Malaspina” accolsero le nostre performance. Furono due concerti impegnativi ma indimenticabili; cantare in presenza di un pubblico particolare e sfortunato fu un’esperienza che mi ha segnato profondamente a livello artistico ma soprattutto umano. Gli applausi finali ma anche a scena aperta commossero non soltanto me ma l’intero gruppo musicale.
Da qualche giorno mi frullava un’idea nella mente. Entusiasmata dall’enorme successo ottenuto nei precedenti concerti, volevo fare un dono speciale a quel luogo di accoglienza che tanto ristoro mi aveva dato in una fase problematica della mia vita. In men che non si dica andai a incontrare fratel Biagio e gli chiesi il permesso di realizzare un concertino natalizio da dedicare a tutti gli ospiti. Aspettai trepidante la risposta che non si fece attendere. Con la sua serafica umiltà mi disse che tutto ciò che veniva loro offerto lo accettavano come un dono del Signore e sorrise. Quelle parole sono impresse in modo indelebile nel mio cuore.
Quello stesso pomeriggio ne parlai con i colleghi che accettarono di essere protagonisti insieme a me di quell’evento. Non c’era cachet per nessuno, era solo la voglia di mettere a disposizione il nostro talento per far trascorrere un’ora di svago a chi stava peggio di noi.
E arrivò il fatidico giorno. Ci sistemammo nel saloncino su di una sorta di pedana, aspettammo che si riempisse e iniziammo. C’era davvero tanta gente, alcuni addirittura non trovarono posto a sedere. Dentro di me si sovrapponevano sensazioni contrastanti. Nonostante fossi interiormente emozionata affrontai il pubblico con molta serenità.
Disinvolta e leggera illustravo i brani che via via facevamo ascoltare. Lo scroscio dei calorosi applausi mi dava la giusta carica. Ogni tanto Biagio faceva capolino e sorrideva compiaciuto mentre don Pino, appoggiato allo stipite della porta, assistette soddisfatto all’intera rappresentazione. Numerosi spettatori, invogliati da me, si cimentarono in simpatici coretti, mentre un ospite della Missione, sul ritmo vivace di un brano, si esibì in una personalissima danza, divertendo i presenti.
Alla fine ovazioni e tanta soddisfazione. Dopo ci offrirono perfino il rinfresco: nella saletta attigua, su un tavolo erano sistemati vassoi colmi di dolcetti dal sapore antico che mi ricordavano tanto la mia puerizia e le festicciole fatte in casa. E c’era anche il rosolio che i più giovani probabilmente disconoscono. Era un liquore domestico che avevo visto preparare tante volte dalla mia nonna. Mi sentivo catapultata in una dimensione nuova fatta di fratellanza e di semplicità: quanta tenerezza in quel povero rinfresco.
Di quel magico momento conservo gelosamente una preziosa registrazione artigianale che ogni tanto riguardo con commozione.
Lo scorrer del tempo mutava, impietosamente, l’aspetto fisico ma anche i sentimenti. A causa di pettegolezzi infondati, entrai in crisi. Alcuni denigratori sostenevano che l’operato di Biagio fosse solo narcisismo. Voleva stare al centro dell’attenzione, così asserivano. Non credetti ma il dubbio s’insinuò. Avere dei dubbi è umano, pure i santi ne hanno avuti ed io - che santa non ero - fui influenzata da quelle maldicenze. Ero dibattuta. E se fosse stato vero ciò che dicevano? E così poco per volta mi allontanai. Del resto, la vita frenetica che conducevo non mi lasciava molto spazio per meditare. I giorni si susseguivano tra prove, sala d’incisione, viaggi e spettacoli. Il dubbio rimase lì latente senza che facessi nulla per dissolverlo.
Tuttavia il risultato della sua filantropica attività era sotto gli occhi di tutti. Il suo impegno costante per aiutare i fratelli bisognosi era innegabile! A seguito di proteste e sofferenze aveva avuto in concessione dei locali siti in via Garibaldi a Palermo e lì aveva fondato la casa di accoglienza per le donne in difficoltà e successivamente era nata la sede di Via dei Decollati. La Missione di Speranza e Carità si era estesa in altri paesi della Sicilia accogliendo migliaia di esseri umani a cui la vita non offriva più nulla. Come si poteva restare indifferenti di fronte a tutto questo? Come si poteva dubitare della veridicità delle sue azioni?
A seguito di tali profonde riflessioni mi persuasi che la fede e l’altruismo di Biagio fossero beni autentici di cui non diffidare, anche se ogni tanto ripiombavo nelle incertezze. Quando, talvolta, appariva in tv così affaticato e fragile per i suoi estenuanti digiuni, riaffioravano la devozione e l’affetto che nutrivo nei suoi confronti, e che non sarebbero cessati mai! Lo osservavo e anche attraverso il monitor il suo sguardo mi perforava l’anima.
Tornai raramente alla Missione, e in quelle poche occasioni mi accolse sorridente ed entusiasta con lo stesso affetto di quando anni prima ci eravamo incontrati per la prima volta. I suoi lineamenti erano contratti, il suo viso era scavato dalla sofferenza, ciononostante mi salutava sempre affettuosamente: “Ciao cantante” e mi abbracciava. Poi, rivolto ai presenti, diceva che ero una bravissima artista e accennava a un sorriso. Non si era dimenticato del concertino che avevo organizzato in quel lontano Natale nella sua Missione.
Seppi dai notiziari che Biagio era gravemente malato, ciononostante continuava le sue battaglie a sostegno dei suoi fratelli bisognosi.
Una notte in cui faceva la sua estenuante protesta davanti a dei locali vicino casa mia, decisi di andargli a fare compagnia. Lo trovai disteso su di una sdraio, sempre più smagrito e stanco. Nonostante fosse stremato non mi negò il suo sorriso e con un filo di voce mi salutò: “Ciao cantante”. Gli presi la mano e con le lacrime agli occhi gliela baciai. Rimasi con lui un paio di ore, sperando che la mia vicinanza potesse dargli un po’ di conforto, quel conforto che tanti anni prima aveva elargito a me quando disperata ero andata a bussare alla sua porta.
Quella fu l’ultima volta che lo vidi. Presa dai numerosi impegni e da innata indolenza, non andai più a trovarlo. Oggi mi pento amaramente, ma ormai è troppo tardi, Biagio a soli cinquantanove anni ci ha lasciati. Posso solo chiedergli perdono attraverso le preghiere e sono certa che nella sua immensa bontà mi perdonerà.
Il corteo funebre quella sera attraversò le vie del centro storico cittadino. Quelle stesse vie che lo avevano visto tante volte dare soccorso agli ultimi, transitando con il pulmino per distribuire coperte e vivande calde a chi per casa aveva solo la strada e per letto un cartone, ora piangevano partecipando al dolore di tutti i palermitani. Dopo avere fatto una doverosa ed emozionante sosta nella piazza della Stazione Centrale dove tutto aveva avuto inizio, riprese il cammino.
Intorno alle 22,00 il corteo passò sotto casa mia. Affacciata al balcone piansi tutte le mie lacrime e pregai dinanzi a quella povera bara, realizzata a mano, con pezzi di legno grezzo, da un ospite della Missione. Era portata a spalla dai fratelli. La gente, stipata ai due lati della carreggiata, al suo passare applaudiva vigorosamente. Mi sorpresi ad applaudire anch’io mentre un grido spontaneo usciva dalle mie labbra: Ciao fratel Biagio, perdonami, ci mancherai, ci sentiremo più soli.
Avevo il cuore gonfio di amarezza, Palermo era vuota senza di Lui. Mi mancava la sua presenza rassicurante, il suo parlare entusiasta, gli appelli che lanciava alle istituzioni perché si prendessero cura dei fratelli meno fortunati. Mi mancava soprattutto la luce che effondevano i suoi occhi. Quelli erano i fari di Palermo che ormai si erano spenti per sempre.
A distanza di qualche giorno medito con la consapevolezza che quei fari non si sono spenti e non si spegneranno mai! Essi sono sempre puntati sulla nostra città e sui suoi amati fratelli. Le sue preghiere e la sua protezione non ci mancheranno mai. FRATEL BIAGIO GRAZIE