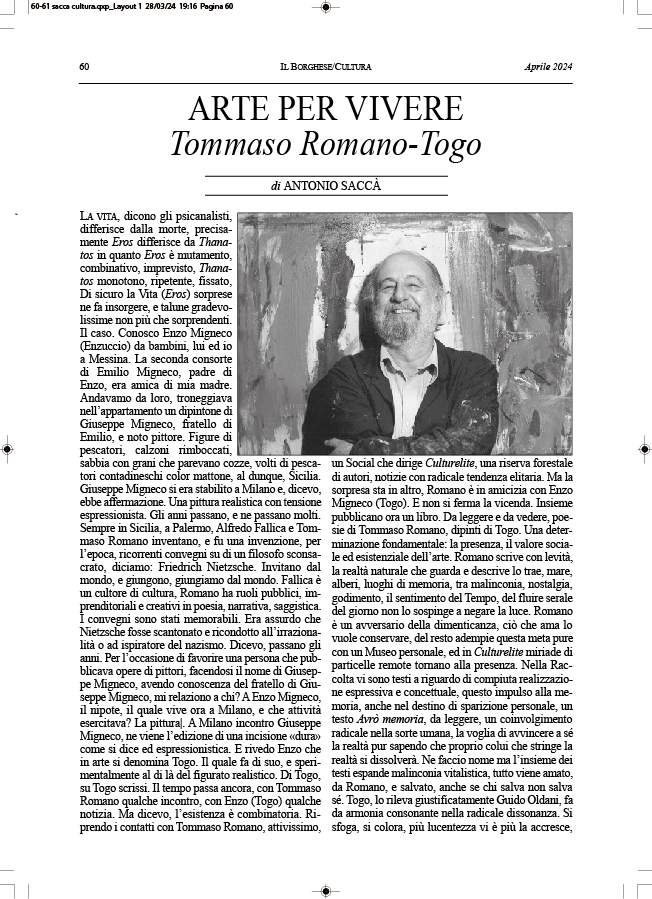“Contesto popolaresco e spiritualità francescana nei Fioretti di Alessio Di Giovanni” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 01 Marzo 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2366
 Dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, per il convergere di istanze spiritualistiche e di forti spinte sociali, si assiste in tutta Europa a un revival del francescanesimo, che in taluni ambienti decadenti si contamina di motivi spuri, come in un certo D’Annunzio. Tra ambigui misticismi di ritorno, secche dell’estetismo (si vedano pure i Poemi italici di G. Pascoli) e doloroso travaglio modernista con i suoi noti esiti storico-culturali e politici (encicliche di Pio X, vicende tormentate di E. Buonaiuti, A. Fogazzaro, R. Murri), anche Alessio Di Giovanni, che vive tale fase storica, individua e isola nel grande alveo francescano una sua via, pervenendo, dopo gli importanti esordi veristi, a un “misticismo naturalistico” che vede nell’anima solare del Poverello e nella sua estatica gioia di fronte all’Infinito e all’Inesprimibile un approdo non solo religioso, ma anche civile, il richiamo cioè a una “socialità” più mite e più fraterna. Dal 1900, anno di composizione dell’ode Cristu (pubblicata però nel 1905) al 1939, anno in cui l’autore dà alle stampe il romanzo La racina di Sant’Antoni, il francescanesimo di Alessio va incontro a delle trasformazioni. Lo scrittore evolve dalla pugnace denuncia della condizione di contadini e zolfatari nell’ode, nella quale soffiano ancora venti socialisteggianti (Dammi, Signuri, un lampu di ssu sguardu/ dammi vuci di focu e di sintenzi/ pi lu me cantu..), alla “utopia malancunusa”, nel poemetto Lu puvireddu amurusu (1907), della cità franciscana, la città benedetta della pace e dell’amore fraterno, dietro la cui lunga elaborazione (quattro anni) si indovina il dibattito interno al mondo cattolico spaccato fra cattolici moderati e democratici cristiani di R. Murri e L. Sturzo, alla introversione infine artistica e religiosa di padre Mansueto, il frate cappuccino pittore protagonista della Racina, nel cui isolamento e serena mestizia e abbraccio finale con la morte Di Giovanni vecchio traspone tutta la sua delusione storica e esistenziale. In questa parabola discendente, dalla speranza-attesa di un rinnovamento al chiuso ripiegamento interiore degli anni Trenta, la traduzione in siciliano dei Fioretti (1926) si colloca a metà strada, segnalando la caduta di ogni pragmatica indicazione di carattere politico-sociale ma anche la “resistenza” di un grande sogno spirituale, tramato di fervida nostalgia, pur se insidiato da un disincanto che si farà negli anni irreversibile come segnalano alcuni elementi biografico-letterari collocabili appunto fra gli anni Venti e Trenta. Si considerino la sostituzione, nella ristampa del 1926 del Puvireddu, della originaria epigrafe carducciana, che definiva San Francesco un frate innamorato di tutte le creature: socialista cristiano, con la prefazione [postuma] del felibrista Mistral, che dei Fioretti e dei testi medievali francescani sottolineava invece la grazia evangelica, l’ingenuità, la freschezza; la più che ventennale elaborazione del pessimistico romanzo che in vita Alessio non pubblicherà, Lu saracinu, in cui l’umanità appare bipartita ab aeterno tra villani reietti da un lato, socialmente irredimibili (cosa ‘nutili), e individui cinici e brutali, monaci fausi compresi, dall’altro; l’insoddisfazione vitale infine che trapela da un articolo-inchiesta del 1939, nel quale il poeta esprime fastidio per l’ermetismo, per la moda attardata di romanzi in lingua esotica e farciti dei soliti adulteri e amorazzi, e anche per una certa retorica celebrativa fascista, se fa notare al direttore de La Gazzetta che quando la poesia si vive, non si canta (cioè non può risolversi in fanfara patriottarda) perché essa è, anzi tutto, nostalgia e ricordo. Grumo in altri termini la poesia di affetti e di delusioni. E proprio dalla nostalgia e dal ricordo appare dettata la dedica digiovannea della versione dialettale dei Fioretti al poeta Giovanni Joergensen (1860/1956) che Alessio racconta di aver incontrato ad Assisi, paragonando il loro incontro a due episodi dei Fioretti, quello che ha a protagonisti frate Egidio e San Ludovico re di Francia (XXXIV) e quello che narra del novizio liberato dalla tentazione della carne e del mondo da Frate Simone (XLI). Ad Assisi Di Giovanni e il poeta danese Jorgensen non si sono detti nulla a voce, come Frate Egidio e San Ludovico, ma come loro si sono riconosciuti nell’intimo anime affini e fratelli: I nostri cuori -si legge nella dedica- si sentirono subito fratelli, ma noi non parlammo…Mi sarebbe stato tanto caro rimanere sempre con Lei, in quel suo romitorio nel paese di San Francesco…avrei voluto chinarle (con citazione testuale del fioretto XLI ) il capo in grembo per malinconia e tristizia, come appunto fa il novizio, interiormente persu, nel grembo di fra Simone. Confessa Alessio nella dedica che il cuore gli si stringeva di tristezza e di sgomento al pensiero di dover lasciare Assisi, caro paese dove l’anima sua aveva trovato finalmente la sua pace!. Nello stesso anno1926 (ma sarà pubblicata nel 1928) Di Giovanni tiene una conferenza dal titolo La modernità dell’ideale francescano dove focalizza la semplicità e la bontà del Santo che -dice- amava tutte le creature: piante, uomini, animali, astri, e che, gioiosamente grato a Dio del dono divino della vita e presentendo una sempre migliore e una sempre meno ferina umanità, avrebbe voluto formare di tutte le rette coscienze e di tutti gli spiriti puri, una grande, ideale, indistruttibile, famiglia. Emerge da quanto esposto fin qui una condizione psicologica soggettiva di malinconico e tormentato vagheggiamento interiore, in cui la “contemplazione” dei boni esempii del Puvireddu Gluriusu e di alcuni suoi santi compagni di prima e seconda generazione francescana, calati nel fragrante e vermiglio dialetto siciliano, si offre allo scrittore come ancoraggio salvifico e “ideale” per un ritorno alle scaturigini semplici e divine della Vita e della Natura, sulle orme di un uomo (Francesco) capace di vivere una intera settimana del canto di una cicala, e che si era costruito con due pezzi di legno, che strusciava uno sull’altro per accompagnare il suo canto, un violino rudimentale, da cui non poteva trarre alcun suono, tranne che per la sua anima mistica. Il nuovo “laboratorio” prosastico dialettale dei Fioretti, dopo La morte di lu Patriarca (1920), corrisponde dunque a una operazione culturale dalla duplice valenza, antropologica e spirituale, perché fonde e cerca un punto di equilibrio fra tre sollecitazioni ugualmente forti: quella che Di Giovanni sente come la dolcissima ingenuità dei dolcissimi racconti della tradizione francescana; l’ingenuità fantastico-religiosa dell’immaginario popolare siciliano; il suo stesso intellettualistico spiritualismo, nutritosi anche degli umori di Shelley, Tolstoi, Whitman, Burns, tutti apostoli per Alessio dell’amore universale come San Francesco. Insomma il candore e il fiabesco popolari vengono sul piano letterario assunti a metà degli anni Venti dal traduttore/Alessio, dopo la caduta del pragmatismo dell’ode Cristu e del Puvireddu amurusu, come strumenti atti a decantare le pesanti scorie della realtà contemporanea, per “ri-orientare” la quotidianità, quella appunto delle disponibili rette coscienze, ancora una volta verso gli ideali francescani dell’umiltà, povertà, carità, contemplazione, armonia fra l’uomo e la Natura, attraverso un processo di semplificazone/essenzializzazione dell’esistere (paradigma la semplicità colombina di fra Leone e dei suoi confratelli) che passa per Di Giovanni anche attraverso la dimensione linguistico-stilistica. Il versante popolare della “spiritualità” di questi Fioretti dialettali è infatti in perfetta simbiosi con l’anima colta digiovannea.
Dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi decenni del Novecento, per il convergere di istanze spiritualistiche e di forti spinte sociali, si assiste in tutta Europa a un revival del francescanesimo, che in taluni ambienti decadenti si contamina di motivi spuri, come in un certo D’Annunzio. Tra ambigui misticismi di ritorno, secche dell’estetismo (si vedano pure i Poemi italici di G. Pascoli) e doloroso travaglio modernista con i suoi noti esiti storico-culturali e politici (encicliche di Pio X, vicende tormentate di E. Buonaiuti, A. Fogazzaro, R. Murri), anche Alessio Di Giovanni, che vive tale fase storica, individua e isola nel grande alveo francescano una sua via, pervenendo, dopo gli importanti esordi veristi, a un “misticismo naturalistico” che vede nell’anima solare del Poverello e nella sua estatica gioia di fronte all’Infinito e all’Inesprimibile un approdo non solo religioso, ma anche civile, il richiamo cioè a una “socialità” più mite e più fraterna. Dal 1900, anno di composizione dell’ode Cristu (pubblicata però nel 1905) al 1939, anno in cui l’autore dà alle stampe il romanzo La racina di Sant’Antoni, il francescanesimo di Alessio va incontro a delle trasformazioni. Lo scrittore evolve dalla pugnace denuncia della condizione di contadini e zolfatari nell’ode, nella quale soffiano ancora venti socialisteggianti (Dammi, Signuri, un lampu di ssu sguardu/ dammi vuci di focu e di sintenzi/ pi lu me cantu..), alla “utopia malancunusa”, nel poemetto Lu puvireddu amurusu (1907), della cità franciscana, la città benedetta della pace e dell’amore fraterno, dietro la cui lunga elaborazione (quattro anni) si indovina il dibattito interno al mondo cattolico spaccato fra cattolici moderati e democratici cristiani di R. Murri e L. Sturzo, alla introversione infine artistica e religiosa di padre Mansueto, il frate cappuccino pittore protagonista della Racina, nel cui isolamento e serena mestizia e abbraccio finale con la morte Di Giovanni vecchio traspone tutta la sua delusione storica e esistenziale. In questa parabola discendente, dalla speranza-attesa di un rinnovamento al chiuso ripiegamento interiore degli anni Trenta, la traduzione in siciliano dei Fioretti (1926) si colloca a metà strada, segnalando la caduta di ogni pragmatica indicazione di carattere politico-sociale ma anche la “resistenza” di un grande sogno spirituale, tramato di fervida nostalgia, pur se insidiato da un disincanto che si farà negli anni irreversibile come segnalano alcuni elementi biografico-letterari collocabili appunto fra gli anni Venti e Trenta. Si considerino la sostituzione, nella ristampa del 1926 del Puvireddu, della originaria epigrafe carducciana, che definiva San Francesco un frate innamorato di tutte le creature: socialista cristiano, con la prefazione [postuma] del felibrista Mistral, che dei Fioretti e dei testi medievali francescani sottolineava invece la grazia evangelica, l’ingenuità, la freschezza; la più che ventennale elaborazione del pessimistico romanzo che in vita Alessio non pubblicherà, Lu saracinu, in cui l’umanità appare bipartita ab aeterno tra villani reietti da un lato, socialmente irredimibili (cosa ‘nutili), e individui cinici e brutali, monaci fausi compresi, dall’altro; l’insoddisfazione vitale infine che trapela da un articolo-inchiesta del 1939, nel quale il poeta esprime fastidio per l’ermetismo, per la moda attardata di romanzi in lingua esotica e farciti dei soliti adulteri e amorazzi, e anche per una certa retorica celebrativa fascista, se fa notare al direttore de La Gazzetta che quando la poesia si vive, non si canta (cioè non può risolversi in fanfara patriottarda) perché essa è, anzi tutto, nostalgia e ricordo. Grumo in altri termini la poesia di affetti e di delusioni. E proprio dalla nostalgia e dal ricordo appare dettata la dedica digiovannea della versione dialettale dei Fioretti al poeta Giovanni Joergensen (1860/1956) che Alessio racconta di aver incontrato ad Assisi, paragonando il loro incontro a due episodi dei Fioretti, quello che ha a protagonisti frate Egidio e San Ludovico re di Francia (XXXIV) e quello che narra del novizio liberato dalla tentazione della carne e del mondo da Frate Simone (XLI). Ad Assisi Di Giovanni e il poeta danese Jorgensen non si sono detti nulla a voce, come Frate Egidio e San Ludovico, ma come loro si sono riconosciuti nell’intimo anime affini e fratelli: I nostri cuori -si legge nella dedica- si sentirono subito fratelli, ma noi non parlammo…Mi sarebbe stato tanto caro rimanere sempre con Lei, in quel suo romitorio nel paese di San Francesco…avrei voluto chinarle (con citazione testuale del fioretto XLI ) il capo in grembo per malinconia e tristizia, come appunto fa il novizio, interiormente persu, nel grembo di fra Simone. Confessa Alessio nella dedica che il cuore gli si stringeva di tristezza e di sgomento al pensiero di dover lasciare Assisi, caro paese dove l’anima sua aveva trovato finalmente la sua pace!. Nello stesso anno1926 (ma sarà pubblicata nel 1928) Di Giovanni tiene una conferenza dal titolo La modernità dell’ideale francescano dove focalizza la semplicità e la bontà del Santo che -dice- amava tutte le creature: piante, uomini, animali, astri, e che, gioiosamente grato a Dio del dono divino della vita e presentendo una sempre migliore e una sempre meno ferina umanità, avrebbe voluto formare di tutte le rette coscienze e di tutti gli spiriti puri, una grande, ideale, indistruttibile, famiglia. Emerge da quanto esposto fin qui una condizione psicologica soggettiva di malinconico e tormentato vagheggiamento interiore, in cui la “contemplazione” dei boni esempii del Puvireddu Gluriusu e di alcuni suoi santi compagni di prima e seconda generazione francescana, calati nel fragrante e vermiglio dialetto siciliano, si offre allo scrittore come ancoraggio salvifico e “ideale” per un ritorno alle scaturigini semplici e divine della Vita e della Natura, sulle orme di un uomo (Francesco) capace di vivere una intera settimana del canto di una cicala, e che si era costruito con due pezzi di legno, che strusciava uno sull’altro per accompagnare il suo canto, un violino rudimentale, da cui non poteva trarre alcun suono, tranne che per la sua anima mistica. Il nuovo “laboratorio” prosastico dialettale dei Fioretti, dopo La morte di lu Patriarca (1920), corrisponde dunque a una operazione culturale dalla duplice valenza, antropologica e spirituale, perché fonde e cerca un punto di equilibrio fra tre sollecitazioni ugualmente forti: quella che Di Giovanni sente come la dolcissima ingenuità dei dolcissimi racconti della tradizione francescana; l’ingenuità fantastico-religiosa dell’immaginario popolare siciliano; il suo stesso intellettualistico spiritualismo, nutritosi anche degli umori di Shelley, Tolstoi, Whitman, Burns, tutti apostoli per Alessio dell’amore universale come San Francesco. Insomma il candore e il fiabesco popolari vengono sul piano letterario assunti a metà degli anni Venti dal traduttore/Alessio, dopo la caduta del pragmatismo dell’ode Cristu e del Puvireddu amurusu, come strumenti atti a decantare le pesanti scorie della realtà contemporanea, per “ri-orientare” la quotidianità, quella appunto delle disponibili rette coscienze, ancora una volta verso gli ideali francescani dell’umiltà, povertà, carità, contemplazione, armonia fra l’uomo e la Natura, attraverso un processo di semplificazone/essenzializzazione dell’esistere (paradigma la semplicità colombina di fra Leone e dei suoi confratelli) che passa per Di Giovanni anche attraverso la dimensione linguistico-stilistica. Il versante popolare della “spiritualità” di questi Fioretti dialettali è infatti in perfetta simbiosi con l’anima colta digiovannea.
La trasposizione in lingua siciliana mostra una fedeltà scrupolosa alle fonti originali in volgare. Relativamente pochi i passi in cui Di Giovanni sorvola su qualcosa, o fa qualche aggiunta, sempre comunque con funzionalità specifica: coloritura di un’immagine, di un concetto, o necessità di chiarimenti (XXVII, XLVIII e LIIl). Rispetta rigorosamente lo scrittore il “suo” metodo di traduzione, che tende ad accentuare la “spontaneità” e la semplicità dei Fioretti medievali atteggiati sin dal primo capitolo secondo l’intonazione caratteristica e il frasario tipico della trasmissione orale e del racconto religioso popolare (Ora dicitimi, lu Signuri, quannu cuminciau a pridicari, chi fici?). Molti gli echi e le somiglianze al livello di tecnica narrativa, terminologia, immagini, espressioni tipiche, movenze del parlato, con le versioni orali dialettali delle Parità e Storie morali tramandate da S. A. Guastella che hanno fatto pure esse da modello al traduttore, anche se non nello spirito di “cristianesimo alla rovescia” dei villani del Guastella. La traduzione digiovannea mostra rispetto ai racconti trecenteschi un uso più elevato della paratassi, che rende ancora più elementare la tessitura interna degli episodi, anche per l’artificio aggiuntivo dell’iterazione affabulante ora in chiave puramente didattica ora in chiave fantastico-fiabesca, iterazioni che non trovano riscontro nella fonte e che bene rispecchiano i criteri dell’oralità dialettale (ca comu ad iddu avìanu a disprizzari ogni cosa munnana, ed avìanu ad essiri poviri comu a iddu, e comu ad iddu, virtuusi e boni; …vitti ‘napocu di monaci ca trasianu, tutti caricati, nni ddu ciumi, e ca, comu trasianu tutti caricati nni ddu ciumi, ddu ciumi granni granni li facìa jiri a gammi all’aria… ) Indicativa è l’assunzione del formulario sacro e devozionale del popolo siciliano. Gesù Cristo e la Vergine Maria non sono semplicemente Gesù Cristu e Maria Virgini, come nudamente nominati negli originali, ma più spesso, e più espressivamente, lu Signuruzzu, Gesuzzu Crucifissu, la sò bedda Matri Maria Virgini, la gluriusa Maria Virgini, la Bedda Matri, l’Addulurata. Allo stesso modo “Santo Francesco” è San Franciscu, ma volta a volta anche San Franciscuzzu beddu, lu Patriarca San Franciscu, lu Santuzzu gluriusu, lu Puvireddu gluriusu, lu Patruzzu santu. “Dio” è ampliato talora in lu Patri di tutti e pure il termine “demonio” ha rispetto alle corrispondenti pagine in volgare più ricche varianti che fanno sentire all’interno degli episodi tutto il loro caratteristico e più materico peso. Oltre diavulu e dimoniu troviamo, nel campo semantico del “diabolico”: Cifaru, ncifaratu/’ncifarata, brutta bestia, nnimicu nfirnali, diavuli ‘ncurpurati… La “quotidianità” popolare (oralità e immaginario collettivo) emerge anche dalle formule fisse: armuzza biniditta, armuzza scunsulata, malatu nfirmu, tuttu priatu, cu cori cuntritu, cci parsi piatusu, cci ficiru preiu, ddu mischineddu…; dagli spezzoni correnti di parlato con aloni spesso di mimica facciale e gestuale: senza diricci mancu bizzi…ca la fami la vidìanu cu l’occhi…cci cuntau puntu pi puntu…lu cuntrariavanu na vota sì na vota no, cà pi iddi pigghiava la spata pi la punta…; da particolari descrittivi aggiuntivi che fanno dei protagonisti religiosi personaggi simili a quelli delle fiabe popolari: frate Bernardo è bonu quantu lu pani; l’angelo che bussa alla porta del convento è un giuvini beddu quantu lu suli; Cristo che appare a Francesco e discepoli è un giuvini beddu, beddu quantu nun si po’ diri; a frate Giovanni della Penna appare un picciriddu (Cristo) beddu quantu lu suli; San Francesco porta con sé per la Quaresima nell’isola maggiore del lago Trasimeno du’ panuzzi schitti schitti; frate Masseo poiché è autu e beddu sciacquatu riceve in elemosina tanti belli pezzi di pani e macari quarchi palata sana sana, mentre a San Francesco nicili di curpuratura toccano solo tuzzareddi sicchi di cent’anni. La duttile espressività della lingua siciliana vivacizza il dettato narrativo, dando fisicità, corposità, elementare concretezza a cose, immagini, reazioni, sensazioni, concetti, o viceversa alleggerendo e semplificando quest’ultimi e lo stesso dettato religioso e etico. Nella traslazione dialettale ad esempio il “cantare” degli uccelli si diversifica onomatopeicamente: le rondini sgriciavanu, le cornacchie vuciazziavanu e frate Masseo, felice per avere ottenuto la virtù dell’umiltà, gurruliava comu na palumma;.nel cap XLI il sintagma “un giovane vanissimo e mondano” viene reso con sonora felicità di sillabe con: era un veru donninnaru; nel cap XXV il lebbroso che ”svillaneggiava… sconciamente…di parole e battiture” i frati che lo servivano e che “vituperosamente bestemmiava” diventa con più rabbiosa crudezza di atti e referenti fonici e visivi un tipaccio che nun facìa autru ca diricci mali paroli ai frati e daricci vastunati all’armalisca…e …bistimmiava a la canina. Analogamente, nel cap XXII il demonio, che “si entrò nel luogo e ponsi in sul collo” di un frate, in dialetto più possessivamente trasiu nni lu romitoriu e accravaccau supra lu coddu di ddu monacu, e nel cap XXVI l’enunciato “Iddio gli permise una grandissima tentazione” passa a: lu Signuri pirmisi ca lu dimoniu lu mittissi cu li spaddi a lu muru. E non è solo “fango” quello che spregiativamente viene buttato addosso a San Francesco ma munnizza rimarrusa di li strati, e nel cap. XXX più spicci e pungenti risultano in siciliano le parole e gli atteggiamenti irridenti degli assisiati (Talìa talìa ca a ssi mischini….cci javanu appressu facennuci olè) verso la nudità provocatorio-dimostrativa di frate Ruffino e di San Francesco. Va inoltre sottolineato l’abbondante, per non dire costante, ricorso al diminutivo (suruzza, mischineddu, armuzza/armuzzi, picciutteddu, divuteddu/divuteddi, virgineddi, scaluneddu…) tendenza assente nei Fioretti in volgare. Il diminutivo è spesso coniugato al possessivo “mio” come nelle forme Patruzzu miu, fratuzzu miu beddu, fratuzzi mii, cumpagneddu miu oppure c’è ridondanza o semplice compresenza con altri termini in nessi tipo figghiu miu armuzza mia, figghiu miu beddu, patruni miu, San Franciscu miu…Tutte queste peculiarità stilistico-espressive di matrice popolare, con la loro varia valenza descrittiva pietistica affettiva esornativa, nonostante la stereotipia formulare, anzi grazie ad essa, rendono più familiari e meno distanti per chi legge (o ascolta) il “sovrannaturale” e la “santità”, e nell’ordito narrativo impostano su livelli più umili e dimessi i rapporti interpersonali, o aprono per credenti, peccatori, reietti, varchi inattesi o estremi di affettività, compassione, speranza, di contro a sofferenze terrene, castighi divini, paure oltremondane. Tessono insomma quella tenue trama psicologica che dà verosimiglianza e credibilità a narrazioni dall’aura più o meno leggendaria, specie quando anche linguisticamente (e quindi cromaticamente, visivamente e sul piano fonico) scattano le antitesi nette, care alla sensibilità elementare e all’immaginare corposo del popolo, tra Bene e Male, ricchi e poveri, Inferno (dannazione) e Paradiso (gloria), donde, nella traduzione di Di Giovanni, la presenza anche di quegli accrescitivi-peggiorativi d’effetto che non si trovano nei corrispondenti episodi in lingua: piccatazzi, armalazzi spavintusi (metafora dei peccati), munnazzu di guai, figghiazzu di panneri… Risulta pertanto più marcata nella versione dialettale la contrapposizione moralistico-pittorica (scuru/lustrura) tra inferno/paradiso, mondo terreno/mondo sovrasensibile. Realtà opposte, che per le scelte stilistiche sopra elencate, o per l‘aggiunta di qualche tocco novellistico che accentua l’orrido, il realistico, il meraviglioso (mantu tuttu stiddi stiddi e ddi stiddi eranu una cchiù bedda di l’autra), o per l’immediatezza stessa delle locuzioni prese dal parlato, si tingono di un fiabesco o di un patetico che distraggono non tanto dal fine edificante, cui tutti questi accorgimenti sono funzionalizzati, quanto piuttosto dal messaggio polemico insito in taluni dei Fioretti trecenteschi. Polemica già ben dissimulata nella redazione volgare medievale, e tuttavia presente, specie nelle sequenze che alludono ai contrasti interni all’Ordine minorita fra Conventuali e Spirituali, o alle lotte politiche e religiose del Duecento e del Trecento, o al contesto economico urbano dove maturava il nuovo compromesso fra la Chiesa-Istituzione e i ceti mercantili. È da notare che la stereotipia miracolistico-visionaria, che nel volgarizzamento trecentesco degli Actus allinea dal capitolo XLI al LIII una teoria di frati santi ed esemplari (frate Simone, frate Bentivoglia, frate Pietro da Monticello, frate Currado da Offida, frate Giovanni della Penna, frate Umile, frate Pacifico, frate Liberato, frate Giovanni della Verna), incorpora nella fitta sequenza devozionale anche riferimenti a frati zelanti e perseguitati: lo stesso frate Simone, frate Lucido Antico, frate Giovanni da Parma, frate Matteo da Monte Rubbiano…Importanti inoltre, dentro e fuori tale sequenza, le “visioni” polemiche di Pietro da Monticello (XLIV), di frate Leone (XXXVI), di frate Iacopo della Massa ( XLVIII), ispirata quest’ultima alla Storia delle sette tribolazioni dell’Ordine dei frati minori di Angelo Clareno, e infine quelle del novizio, che rifiuta inizialmente l’asprezza del “sacco” francescano (XX), e del terzo ladrone convertito, che sogna un suo viaggio nell’oltretomba (XXVI), tutte visioni il cui motivo conduttore è l‘ideale rigorosamente ugualitario, antimondano e antigerarchico, della “povertà assoluta” con allusioni, a ben leggere, anche nel corrusco e fantasioso al di là del cap. XXVI, ai 150 anni della storia dell’Ordine francescano.
Nella stesura siciliana in generale e nei fioretti or ora citati, a cui va aggiunto il XXXI° (un sogno di fra Leone sul giudizio universale), tale complessa articolazione politico-morale della fonte trecentesca, dove anche le marche temporali ad apertura di capitolo vogliono segnalare una “purezza” delle origini andata perduta, scompare o si disperde fra le pieghe di un narrare semplicemente “devoto” e “popolareggiante”. I Fioretti in volgare toscano hanno, pur nella semplicità del dettato, una loro naturale “letterarietà”. Basta confrontare nel fioretto IX, in cui S. Francesco non riesce, pur ordinandoglielo, a farsi svilire da frate Leone, l’annotazione in volgare ”dolcemente adirato e pazientemente turbato” con la corrispondente trasposizione dialettale menzu risulenti e tuttu aggrunnatu, ma cu tuttu chissu, sempri pacinziusu, per cogliere la “regressione” al livello di una realtà domestico-paesana. Inoltre, pur nella costante aura di miracolo e nell’apparenza di una disinteressata “fiabesca” soavità, i Fioretti toscani rivelano una solida tessitura teologico-dottrinale (Francesco alter Christus secondo l’interpretazione figurale della Storia tipica del Medioevo; le “dotte” controversie sulla interpretazione della Regola riflesse nella figura di S. Antonio di Padova; la questione dei suffragi e del Purgatorio; il mistero della transustanziazione…) e -come già detto- una concreta linea politico-morale che sul piano storico-civile simpatizza con le ragioni degli Spirituali. Di conseguenza in essi il tono del discorrere o del narrare, generalmente meno puntuale topograficamente e più concettuale o più astratto quanto anche al valore semantico di molti termini rispetto ai corrispondenti brani in siciliano, sfocia più naturalmente nel simbolo religioso, nell’allegoria morale (vedi l’episodio del “lupo” di Gubbio, più naturalisticamente “animale” invece, grossu e mmastinu, in Di Giovanni) o nella riflessione storica (storia dell’Ordine soprattutto) oltre che in enunciati teorici sempre sottilmente dottrinali e meditatamente etici. Diverse le finalità di Di Giovanni che, traducendo in siciliano gli aneddoti francescani, sa bene che, per non cadere nel grottesco, deve regredire al livello dei meccanismi mentali e psicologici della gente della sua isola incarnati nella prassi linguistica. Da questa immersione poi in una religiosità semplificata e dallo “spessore” linguistico-concettuale localmente caratterizzato, ciò che gli autori felibristi -come scrive lo stesso Alessio nella prefazione de La Racina…- chiamavano il “profumo du terroir (del territorio)”, lo scrittore ciancianese si ripromette, come abbiamo anticipato, il ritrovamento/risalita verso una innocenza aurorale del cuore e una rinnovata disponibilità a valori più alti come antidoto alle consuetudini correnti del mondo: egoistiche, particolaristiche e discriminatorie non solo tra uomo e uomo ma anche tra gli uomini e gli altri esseri del Creato. Donde la parallela rilevanza nella Modernità dell’ideale francescano del riferimento digiovanneo al Cantico delle creature e del giudizio su San Francesco, uomo medievale che non ha rancori, non ha ire: pura anima raggiante di luce, che vorrebbe spandere, non soltanto nella sua piccola Assisi e nella sua dolce valle spoletana, ma dovunque nel mondo l’amore per Dio, l’amore per gli uomini, l’amore per gli animali, l’amore per l’umana Bontà, l’amore per la Vita [universale], l’amore per la Morte.
In rapporto a quanto detto finora risulta coerente l’alone che irraggia attorno a sé anche il frasario più specificamente religioso dei Fioretti digiovannei con effetti analoghi di abbassamento, corposità, alleggerimento stilistico-espressivi e emotivo-concettuali. I sintagmi ad esempio: “tirare o portare anime all’inferno” e ”fare frutto a Dio” passano al più plastico carriari armuzzi all’inferno o al paradiso; l’idealistico “un grande esempio di santità” si fisicizza in “lu veru ciuri di li santi”; l’esperienza dell’“essere ratto in contemplazione” o di ”essere tutto elevato e congiunto con Dio” si familiarizza nelle annotazioni gratificanti (anche per l’io intimo digiovanneo): furtuna di putirisillu godiri a so piaciri lu Signuri… e… parrari vucca a vucca cu lu Signuri; il “ragionare della salute dell’anima” si concretizza nel parrari di comu l’armuzzi putianu aviri gloria e paradisu; “orare”, “orazioni” rientrano nella consuetudine del dirisi li cosi di Diu; una affermazione del tipo: ”ma tu hai la grazia della predicazione della parola di Dio a soddisfare il popolo” trapassa in siciliano a frase più dimessa nel tono ma più popolarescamente vivida nella visualizzazione degli effetti della parola divina nel popolo: hai la grazia di sapiri spiagari bonu la parola di Diu, tantu ca li gintuzzi cci scialanu a sintiriti parrari. E veramente la gente, con il suo dissentire o consentire, con il suo accorrere curioso o devoto, o con il suo più plateale pentirsi (cuminciaru a chiancirii e a mazziarisi), sembra “più attiva” in questi fioretti dialettali che non in quelli volgari più velatamente ”intellettualistici,” creando quella cornice rustico-paesana, fra pittoresca e realistica, che non stride, anzi più genuinamente circoscrive l’aura religiosa degli episodi e l’esemplarità dei personaggi seguiti dall’autore con occhio stupito e devoto. L’abilità del traduttore-artista mimetizzatosi in “narratore popolare” non fa violenza alla spiritualità di Di Giovanni, la cui religiosità e misticismo fatti di epifanie naturalistiche e sensibilità teologica e attraversati da angosce novecentesche meglio traspaiono dagli episodi che svolgono il tema della concordia fra uomini e animali (lupo di Gubbio, prediche agli uccelli e ai pesci, le tortore selvatiche, vita di fra Liberato), e là dove la lingua siciliana si tende e affina al massimo per scandagliare, seppure in flash brevissimi, il mistero di Dio. Nel cap. XLVIII, a proposito di Frate Giovanni da Parma (ministro generale perseguitato dell’Ordine), il poeta amplia il testo originale passando da: “il quale più compiutamente avea bevuto il calice della vita, per lo quale egli avea profondamente contemplato l’abisso dell’infinita luce divina, e in essa avea intesa l’avversità e la tempesta…” al periodo seguente: ca s’avìa vivutu ddu càlaciu ‘nzina a l’urtima stizza, e pi ssa cosa iddu avìa vistu ‘nzina a lu funnu l’abissu di la lustrura di Diu, ca nun avi né principiu né fini, e nni ss’abissu avìa ntisu tutti li cuntrariità e la timpesta… Nella trasposizione sono da notare il particolare fisicizzante del “sangue” (stizza) di Cristo, l’ampliamento di “infinita” in nun avi né principiu né fini, l’iterazione di abissu e il plurale cuntrariità: nell’abisso di Dio è qui lo stesso Alessio ad immergersi leggendovi, non tanto (o non solo) i contrasti interni all’Ordine minorita, quanto luci e ombre della sua e dell’esistenza di tutti. Nel cap. LlI Fra Giovanni della Verna una notte vede in visione non solo Dio, ma, con uno scarto da “Cantico delle creature”, lu suli, la luna, li stiddi, lu mari, li muntagni, l’arvuli, l’armali, li cristiani, enumerazione assente nel testo trecentesco dove è presente una terminologia di matrice teologico- dantesca: “vide in lui Creatore tutte le cose create, e celestiali e terrene, e tutte le loro perfezioni e gradi e ordini distinti”. Colpiscono anche, oltre l’immedesimazione personale con il silenzio densamente comunicativo che lega frate Egidio e re Ludovico, o il novizio tentato e frate Simone, sia l’intesa profonda che lega Chiara e Francesco (Chi si dissiru cu dda taliata? cap. XXXIX) sia “l’affinità” dell’inchiesta esistenziale di Di Giovanni con l’inquieta “ricerca” del rapporto intimo e costante con Cristo di frate Giovanni della Verna, sulle cui estasi lo scrittore indugia accentuando gli aspetti dell’eros mistico (cà sintìa li manu di lu Signuri ca…lu strincianu amurusi amurusi, comu nun sanu strinciri manu d’omu nni lu munnu). Giovanni della Verna vive ora la appagante presenza dentro di sé della vampa smisurata dell’amore divino (e vampa è parola-chiave digiovannea perché torna nei densi fioretti XV e XXVII), ora l’irrequieto anelito ad esso, quando sente di averlo perduto, errando sirva sirva, afflittu e ammartucatu, selva che è anche lo spazio ideale dell’immaginare lirico e religioso digiovanneo. Spazio realistico è la “selva” per i francescani, ma anche fortemente “simbolico” in senso medievale (si pensi alla mistica della Bellezza visibile dei Vittorini) per il loro incontro-colloquio con Dio. Nella selva si rifugia spesso a pregare San Francesco; nella selva si appartano insieme, ratti in Dio di l’avimmaria ‘nzina a l’arba, frate Bernardo e san Francesco; frate Bernardo sulle cime dei monti, volando alto nella contemplazione, si pasce nni l’aria comu la rinnina; camminando a ddi viola viola nella selva e mentri java e vinìa a dda sirva sirva, frate Masseo, dopo tante lacrime, sospiri e invocazioni, ottiene da Cristo la tanto desiderata virtù dell’umiltà, e Di Giovanni, con un altro incisivo scarto personale rispetto alla fonte trecentesca, ne tratteggia la vucca a risu, si ferma due volte sul lieto gurruliari del frate che fonicamente e visivamente fonde l’innocente motilità delle colombe con il gaudioso vivere da colomba di Masseo, e nella chiusa ne fissa la gioia di lu cori e il vibratile tonu. Anche nel fioretto della predica agli uccelli soggettivamente iterando per quattro volte il termine oceddi lo scrittore pare accompagnarne, con lo stesso religioso impeto, il canto e il “volo” (reale e metaforico) di sogno e di speranza fino ai confini della terra.