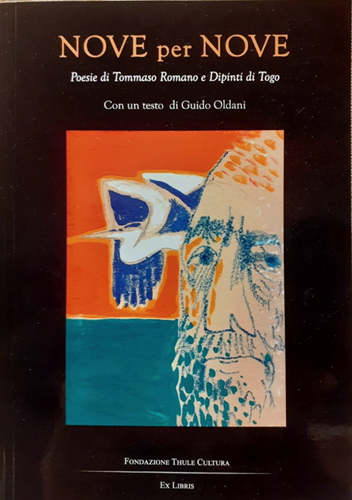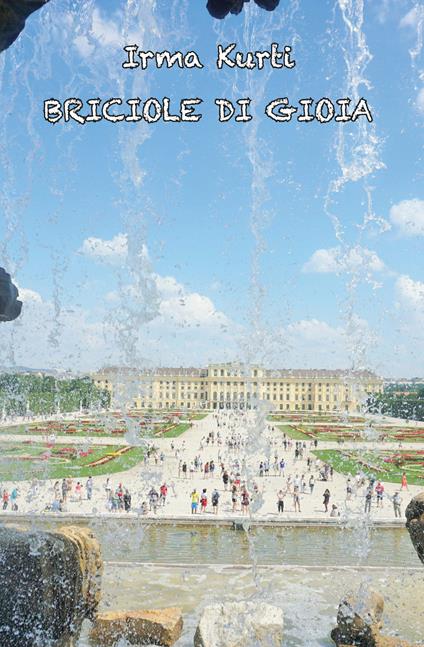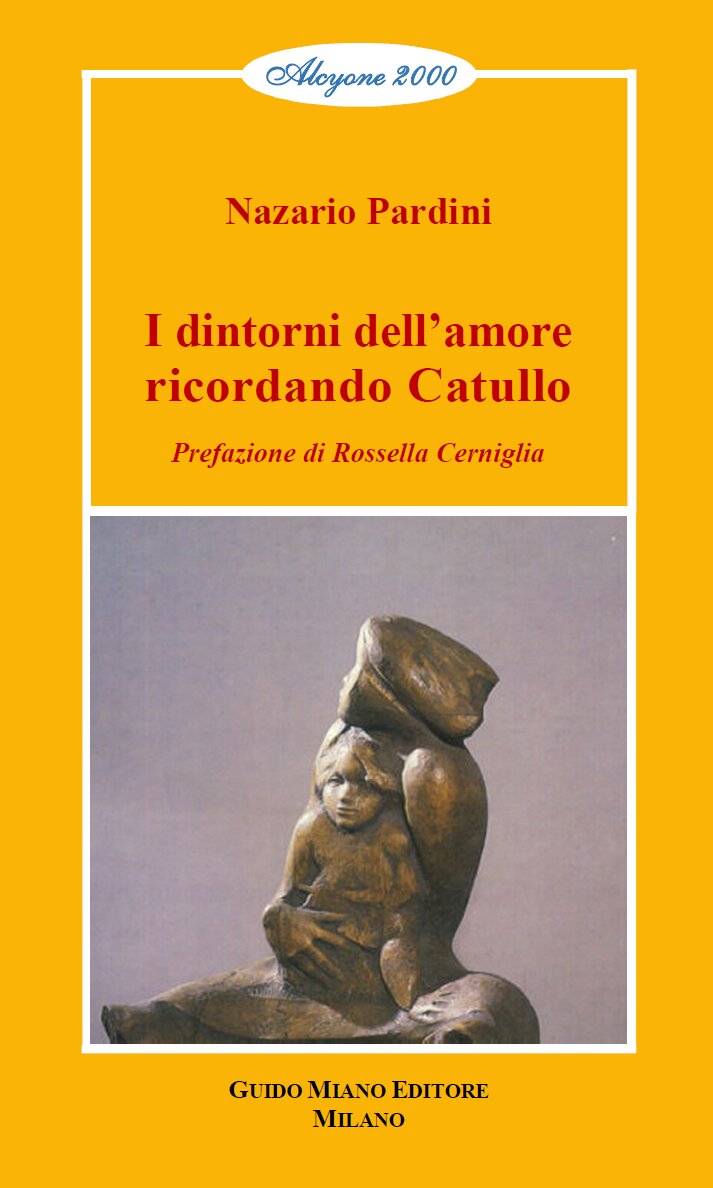“Coronavirus. La lezione di Kierkegaard” di Daniele Fazio
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 09 Marzo 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 3714
 Misure extraordinarie. Scuole chiuse. Limitazione delle uscite per anziani e bambini. Distanza di sicurezza. Niente baci e abbracci. Alcune Regioni con chiese chiuse, altre con celebrazioni liturgiche ridotte al minimo e imposizioni di nuovi “protocolli sacrali”: niente acqua benedetta, niente comunione in bocca, etc. Panico generalizzato. Crolla così ancora una volta la sicumera dell’uomo che crede il suo “io” un assoluto, complici oggi anche i potenti mezzi della tecnoscienza. Ora si è atterrati dalla paura di essere contagiati da un nuovo virus che giunge da quella stessa Asia da cui nel secolo XIV giunse il famigerato batterio Yersinia pestis – veicolato dai roditori all’uomo tramite la Xenopsylla cheopis, ossia una pulce parassita – che falcidiò 1/3 della popolazione europea. Anche oggi siamo nella situazione esistenziale di cui martella l’antico salmo: «l’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono» (Sal 48,20). Comprendere cosa? Comprendere innanzitutto chi è, ancor prima che il corretto modo di lavarsi le mani, e comprendere di che pasta è fatta la sua esistenza, ancor prima dell’utilizzo di qualsiasi precauzione.
Misure extraordinarie. Scuole chiuse. Limitazione delle uscite per anziani e bambini. Distanza di sicurezza. Niente baci e abbracci. Alcune Regioni con chiese chiuse, altre con celebrazioni liturgiche ridotte al minimo e imposizioni di nuovi “protocolli sacrali”: niente acqua benedetta, niente comunione in bocca, etc. Panico generalizzato. Crolla così ancora una volta la sicumera dell’uomo che crede il suo “io” un assoluto, complici oggi anche i potenti mezzi della tecnoscienza. Ora si è atterrati dalla paura di essere contagiati da un nuovo virus che giunge da quella stessa Asia da cui nel secolo XIV giunse il famigerato batterio Yersinia pestis – veicolato dai roditori all’uomo tramite la Xenopsylla cheopis, ossia una pulce parassita – che falcidiò 1/3 della popolazione europea. Anche oggi siamo nella situazione esistenziale di cui martella l’antico salmo: «l’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono» (Sal 48,20). Comprendere cosa? Comprendere innanzitutto chi è, ancor prima che il corretto modo di lavarsi le mani, e comprendere di che pasta è fatta la sua esistenza, ancor prima dell’utilizzo di qualsiasi precauzione.
La precarietà e la palese incertezza di questi giorni italiani, europei, mondali ci porta con la mente alla lezione controcorrente ed imperitura di un tormentato giovane danese, Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855), che da solo, ebbe il coraggio – nonostante il “grande terremoto” della sua esistenza, o forse grazie ad esso – di ergersi contro il Moloch filosofico dell’idealismo hegeliano e porre il singolo contro il sistema, la tragicità della vita umana contro il lieto fine della sintesi dialettica, l’aut- aut contro il pacificante et-et. Non il Pensiero che pensa l’individuo, non l’individuo fagocitato dallo Stato, realizzazione della razionalità dello Spirito, bensì la singolarità concreta è la protagonista del pensiero funambolico di Kierkegaard. Georg W. F. Hegel (1770-1831) e Kierkegaard sono opposti, ma intimamente legati. Senza la presunzione del pensiero hegeliano, probabilmente non ci sarebbe stata l’appassionata difesa del soggetto esistente, resistente ad ogni astrazione. Ed in questo sta l’originalità e la profezia del pensatore danese. Scrive Étienne Gilson (1884-1978): «il merito di Kierkegaard fu anzitutto di dire qualcosa di originale, ma di dirlo con tale accento che non si potrà mai dimenticarlo dopo di lui. La lezione che si riallaccia ormai al suo nome è che un’ontologia completa non può né concepire l’esistenza come tale, né eliminarla […]. Una così appassionata rivendicazione dei diritti dell’esistente, difficilmente avrebbe potuto avere luogo, senza che prima fosse stata spinta al suo termine l’esperienza in grande stile tentata da Hegel per includerlo nei quadri del pensiero logico».
L’esistenza dell’uomo – per Kierkegaard – si dà attraverso la categoria della possibilità. L’esistenza non è altro che movimento e pertanto non si lascia pensare, perché pensarla vorrebbe dire abolirla. Davanti ad essa si aprono infinite possibilità, ma non tanto quelle positive sono da prendere in considerazione, ma le «possibilità-che-non», ossia proprio le situazioni avverse, il male fisico, morale, la malattia, l’annullamento della stessa singolarità dell’uomo o per dirla veramente con Kierkegaard, il peccato. In un momento storico – quello d’esordio del XIX secolo – in cui tutto procedeva secondo le leopardiane “magnifiche sorti e progressive”, ossia verso un paradiso terrestre da cui era stato cacciato Dio, il “grillo parlante” o la “cornacchia” – per gli avversari – di Kierkegaard attirava l’attenzione sull’assoluta precarietà dell’esistenza e sulla minaccia del nulla che sempre la circuisce. Sul fatto concretissimo che l’autosufficienza dell’uomo è una mortale illusione.
Naturalmente inascoltato, avrà “successo” molti anni dopo la sua morte, quando l’ottimismo, idealista e positivista, conflagrerà e tuttora come scrive Karl Jaspers (1883-1969): «sta sulla porta d’ingresso della filosofia contemporanea, - questa filosofia giungerà al termine, quando Kierkegaard non avrà più niente da dirle». Al tempo del coronavirus, ancora, la lezione del filosofo danese ha qualcosa da dirci, interrogando, impertinente, l’egocentricità dell’uomo del nostro tempo proprio nel momento in cui la sua certezza vacilla e il pensiero egologico – da Cartesio ad Hegel e dalle ideologie del XX secolo al recentissimo transumanesimo – implode come un gigante dai piedi d’argilla. E la lezione del “discepolo dell’angoscia” – altra categoria inscindibile dall’esistenza – è proprio quella che l’uomo non è un assoluto, ma vive continuamente davanti ad una decisione da compiere nella sua singolarità. Egli non potrà autosalvarsi, ma ha solo da affidarsi, o meglio da stare davanti ad un Altro da sé, differente ontologicamente.
Se la filosofia dell’idealismo non ha lasciato esistere l’esistenza, se l’Io si è sostituito a Dio, chi potrà capire l’incertezza, l’instabilità e la precarietà dell’esistenza? Non certamente l’esteta, né tantomeno una prospettiva etica naturale, ma solo il cristianesimo. Attenzione però, non il cristianesimo borghese ed accomodante, incarnato dalla Chiesa luterana danese del suo tempo e neanche quello concettualizzato dall’imponente sistema di Hegel e reso teologia dal vescovo Hans Lassen Martensen (1808-1884), contro cui polemizza, ma il cristianesimo che fonda il suo nucleo essenziale sul rapporto con Dio. Ossia quello che fa decidere per un rapporto assoluto con l’Assoluto, di cui sublime modello è Abramo. Lungi dall’incastrare nella speculazione lo scandalo e il paradosso dell’esistenza, il cristianesimo serve per vivere nello scandalo e nel paradosso della fede. Nessun happy-end, ma la sfida di vivere l’angoscia – quale elemento di incertezza rispetto alle situazioni esterne – e la disperazione – quale modalità del rapporto del singolo con se stesso – alla sequela del Maestro, di cui siamo contemporanei. Non Socrate è il riferimento, ma Gesù Cristo, perché l’uomo non ha una verità da trarre fuori da sé con la maieutica – egli è la non-verità – ma ha bisogno di un maestro che comunichi a lui la salvezza e la verità e quindi lo rigeneri come “uomo nuovo”. Infatti – ricorda Kierkegaard – a chi « non abbindola l’angoscia che vuole salvarlo viene restituito tutto, come non avviene mai a un uomo nella realtà, anche se ricevesse dieci volte tanto; perché il discepolo della possibilità ottiene l’infinito, mentre l’anima dell’altro esala l’ultimo respiro nel mondo finito». Il luogo della verità allora non è il soggetto trascendentale, ma la soggettività esistente e la verità sarà tale quando lo sarà per me. Ossia quando il singolo finalmente avrà reso la verità vera per se stesso.
Oggi la lezione del filosofo di Copenaghen è attuale in quanto interroga con radicalità la nostra precaria esistenza che è possibilità, angoscia e disperazione. Ma quanti ancora una volta accetteranno di uscire dalla fantasia dell’autodivinizzazione per concepirsi come essere-dipendenti dalla Trascendenza?