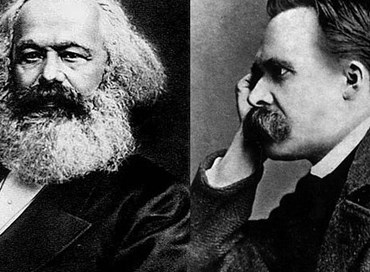Dante Alighieri, “De Monarchia” - di Sandra Vita Guddo
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 11 Giugno 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2675
 Pochi autori hanno saputo affrontare, come Dante Alighieri, il tema del Potere. Egli comprese molto prima di Montesquieu (1689-1755) che è fondamentale, per la saggia governance di un popolo, la divisione dei poteri. Il filosofo illuminista aveva indicato nel suo trattato “De l’Esprit des lois” la condizione imprescindibile della divisione dei tre poteri dello Stato da affidare ad istituzioni politiche differenti a garanzia della corretta e funzionale governance. Si comprende, dunque, quanto il “DE MONARCHIA” sia un’opera attualissima e di fondamentale importanza e in che modo Dante sia stato capace di intuire ciò che Montesquieu avrebbe elaborato quasi quattro secoli dopo.
Pochi autori hanno saputo affrontare, come Dante Alighieri, il tema del Potere. Egli comprese molto prima di Montesquieu (1689-1755) che è fondamentale, per la saggia governance di un popolo, la divisione dei poteri. Il filosofo illuminista aveva indicato nel suo trattato “De l’Esprit des lois” la condizione imprescindibile della divisione dei tre poteri dello Stato da affidare ad istituzioni politiche differenti a garanzia della corretta e funzionale governance. Si comprende, dunque, quanto il “DE MONARCHIA” sia un’opera attualissima e di fondamentale importanza e in che modo Dante sia stato capace di intuire ciò che Montesquieu avrebbe elaborato quasi quattro secoli dopo.
Il “ De Monarchia” può essere considerato, a pieno titolo, il primo vero trattato politico moderno anche se fu scritto in pieno Medioevo. L’opera si presenta con la forma espositiva del testo argomentativo, ciò in quanto viene introdotta dal “de” che in latino corrisponde al complemento di argomento e segue un procedimento logico serrato con una dissertazione lucida e colta che si muove sulla contrapposizione di tesi e antitesi, con un linguaggio espressivo di grande potenza descrittiva ed evocativa, arricchito da analogie e sinestesie, allegorie e metafore. Linguaggio che raggiunge la massima espressione nella Divina Commedia, dove l’ingegno creativo dell’Autore può spaziare e creare addirittura nuovi vocaboli e suoni!
Ma qual è l’approccio più corretto alle opere di Dante?
Sicuramente non quello “agiografico” utilizzato, quasi esclusivamente per i Santi e i Beati di cui Dante non ha certamente bisogno, ma quello euristico della ricerca dei dati storici e della loro comparazione con i testi dell’epoca.
Ecco perché, per affrontare uno studio sul DE MONARCHIA, partiamo proprio dall’analisi del testo di cui riporto un periodo, tratto dal libro terzo, capitolo quindicesimo:
- “Propter quod opus fuit homini duplice directivo secundum duplicem finem: scilet summo pontefice, qui, secundum rivelata, humanum genus perduceret ad vitam ecternam, et imperatore, qui, secundum philosophica documenta, genus humanum ad temporalem felicitatem dirigeret”.
Come dimenticare che, anche oggi, quando un capo di stato esercita entrambi i poteri nella stessa persona, si cade nell’oscurantismo e nella negazione delle libertà individuali, indispensabili a contribuire alla felicità? Dante, inoltre svela di possedere il temperamento, il coraggio, la coerenza con cui si oppone alla filosofia imperante di quel tempo cioè alla scolastica che pretendeva di spiegare i misteri della fede con la ragione, utilizzando come pezze d’appoggio, il pensiero dei maggiori filosofi della Grecia classica come Socrate, Platone e Aristotele. (Sic!)
La Struttura del “De Monarchi” è la stessa che ha utilizzato per gli altri due libri scritti in latino: il” De Vulgari Eloquentia” e le “Epistolae”.
E’ divisa in 3 libri per un totale di 41 capitoli.
Il primo libro si occupa della” DISSERTAZIONE SULLA QUESTIONE SE L’UFFICIO DELL’IMPERATORE SIA NECESSARIO AL BENE DELL’UOMO”.
2) Il secondo contiene la “DISSERTAZIONE SULLA QUESTIONE SE L’IMPERO ROMANO SI SIA IMPOSTO DI DIRITTO SUL MONDO O MENO”.
3) Nel terzo libro troviamo la “DISSERTAZIONE SULLA QUESTIONE SE LAUTORITA’ IMPERIALE DERIVI DAL PONTEFICE O DIRETTAMENTE DA DIO”.-SA
L’uomo necessita della guida dell’imperatore per raggiungere la felicità terrena attraverso gli ammaestramenti filosofici cioè la pratica dei suoi postulati. Esercitazioni e pratiche che certamente gioverebbero all’uomo di oggi per non scadere nell’homo lupus homini di cui parlerà il filoso inglese T. Hobbes. Dante insiste sulla necessità della forte e autorevole figura dell’Imperatore come garante dell’ordine pubblico e della pax tra tutte le genti. Una figura augustale in grado di gestire le controversie e di governare con equilibrio e senso altissimo della giustizia. Sostanzialmente, viene proposto il modello di “imperator augustus” che è quello dell’ Impero Romano, il più vasto impero del mondo antico in cui il saggio Imperatore riusciva a mantenere la PAX tra le varie etnie che lo abitavano.
La Pax di cui tratta Dante è una pacifica libertà e soltanto l’Imperatore Romano può assicurare che “in questa abitazione mortale liberamente in pace si viva”.
Certamente siamo di fronte ad una visione utopistica in quanto la realtà politica dell’Italia e della stessa Europa appariva, al tempo di Dante, estremamente frazionata e divisa da lotte per la supremazia in cui un ruolo importante ebbe sicuramente l’ingerenza della Chiesa Cattolica. Dante confessa che aveva ritenuto che la grandezza dell’Impero Romano, da Augusto fino a Carlo Magno e i suoi discendenti, dipendesse dal valore delle armi. Successivamente, ad un’analisi più scrupolosa, si rende conto invece che ciò è stato determinato dalla volontà divina, dalla provvidenza. E ciò che scaturisce dalla volontà di Dio non può che essere giusto e perfetto.
L’uomo dunque ha bisogno di una duplice guida per realizzare il doppio obiettivo della sua esistenza terrena e ultraterrena. A questo punto, il riferimento ai Vangeli Sinottici è lampante ma desidero ugualmente riproporlo a chiarimento dell’affermazione di Dante che scrive che “ onde e’ fu di bisogno all’uomo di due direzioni secondo i due fini”.

Un sedicente personaggio, che si lamentava delle tasse imposte dall’Imperatore romano, chiese a Gesù se ritenesse giusto che egli dovesse pagarle, senza fiatare. Era una provocazione o addirittura un tranello nel senso che se Gesù gli avesse dato ragione, sarebbe stato denunciato come nemico dell’Impero Romano e sobillatore di rivolte del popolo. Ma Gesù rispose con la celebre frase “Date a Cesare quel che è di Casare e restituite a Dio quel che è di Dio”.
La frase esprime in modo sintetico ma efficace l’idea che l’uomo segue due vie: quella terrena che compete al potere temporale dell’imperatore a cui bisogna piegarsi anche attraverso il pagamento dei tributi imposti e quella divina che chiede che l’Uomo venga restituito a Dio perché da Dio è stato creato a Lui dovrà tornare per subire il giudizio divino.
Nel secondo libro, Dante tratteggia in modo più esplicito il carattere e il fondamento dell’Impero Universale che affonda le sue radici nell’antico Impero Romano dalle sue origini fino a Carlo Magno e ai suoi discendenti. L’impero che nasce da Enea fuggito da Troia in fiamme con il figlioletto Ascanio e il vecchio padre Anchise per giungere, dopo la struggente storia d’amore con Didone, l’Italia e qui fondare la città da cui poi sarebbe sorta Roma. Grandi imperatori che, dopo la nascita di Cristo, hanno via via abbandonato le antiche credenze pagane e politeiste per abbracciare la nuova religione. Un cammino inarrestabile, seppur macchiato da tante persecuzioni crudeli contro i cristiani, ma un cammino glorioso voluto dalla Provvidenza divina.
Ciò porta all’immediata conclusione che il potere temporale sia autonomo rispetto al potere spirituale e viceversa, come esposto chiaramente nel terzo libro. Dante aderisce alla Teoria dei due SOLI che splendono ognuno indipendentemente dall’altro per guidare e arrecare la felicità all’Uomo. Con ciò si contrappone alla posizione ideologica proposta da Papa Bonifacio VIII (1230-1303) il quale sosteneva la teoria del Sole e della Luna; il Sole sarebbe il Papa che quindi splende di luce propria mentre la Luna è l’Imperatore che non ha luce propria ma splende di luce riflessa. Il potere temporale, esercitato dall’Imperatore deve guidare l’uomo alla felicità terrena, attraverso l’emanazione di leggi severe ma dettate dalla saggezza, il Potere Spirituale invece deve assicurare all’umanità la felicità spirituale a cui “nessuno o pochi potrebbero pervenire, se la generazione umana, sedate e quietate l’onde della cupidità, non si riposasse libera nella tranquillità della pace”
Soltanto attraverso il rispetto delle norme imposte dall’Imperatore è possibile tenere a bada la cupidigia dell’uomo per cui Dante vede in lui uno strumento della divina Provvidenza: non un destino né una fatalità ma il progetto divino e provvidenziale. I due poteri sono paritari, autonomi l’uno dall’altro eppure collegati dallo stesso nesso: la felicità dell’Uomo su questa terra di cui di occuperà l’imperatore con la sua guida e attraverso gli studi filosofici e la felicità spirituale e ultraterrena di cui si occuperà il Papa con la sua guida e attraverso gli studi di teologia e la pratica delle virtù quali pazienza, speranza e temperanza.
Il DE MONARCHIA venne scritto, secondo alcuni nel 1308, secondo altri tra il 1312 e 1313 o forse anche dopo. La controversia ruota attorno alla figura di Arrigo di Lussemburgo che, secondo Dante, incarna l’ideale di Augusto con riferimento al primo imperatore romano Ottaviano.

Enrico VII si era distinto per la saggia amministrazione e azione diplomatica prima come conte di Lussemburgo, poi re di Germania (1308), finché nel 1312 fu eletto imperatore del Sacro Romano Impero dopo avere raggiunto accordi diplomatici con i principali regni d’Europa: Francia, Spagna, Il piccolo regno di Savoia e la Chiesa con cui strinse accordi con il Papa Clemente a cui assicurò la sua protezione in ogni circostanza. Si recò in Italia accolto ovunque con grandi onori, portò alla pacificazione tutti i turbolenti comuni del centro nord, ricevette molte delegazioni ma non quella di Firenze e dei guelfi toscani. Ma nel 1313 Enrico muore improvvisamente a Buonconvento, nei pressi di Siena, forse avvelenato. Le speranze di Dante di rientrare a Firenze naufragarono miseramente.
Il libro non ebbe al suo esordio grande fortuna, anzi, fu posto al rogo con l’accusa di eresia dal cardinale francese Bertrando Del Poggio, nipote o addirittura figlio del papa Giovanni II. Successivamente, nel 1559, venne iscritto dal Sant’Uffizio nell’indice dei libri proibiti, dopo il, Concilio di Trento, e rimase ignorato per molto tempo, esattamente fino al volgere del XIX.
Soltanto nel 1921 il testo fu riabilitato dal Papa Benedetto XV nell’enciclica “IN PRAECLARA SUMMORUM” dedicato al poeta fiorentino di cui riconosce l’altissimo valore soprattutto riferendosi alla Divina Commedia. Nello stesso periodo venne ampiamente rivalutato dal filosofo Giovanni Gentile (1875-1944) che giudicò il De Monarchia un vero e proprio atto di ribellione alla trascendenza medioevale della Scolastica ma, molto più probabilmente, vedeva nell’esaltazione dell’Impero Romano quello stesso ideale di grandezza, riproposto da Benito Mussolini di cui Gentile fu accanito sostenitore.
Potrebbe stupirci, sic stantibus rebus, l’ammirazione che Attilio Momigliano ( 1883-1954) ebbe per tutta l’opera dantesca, considerando il fatto che Egli era ebreo e, come tale, subì le leggi razziali e la persecuzione antisemita. É stupefacente constatare come questi due letterati, coetanei e conterranei, abbiano apprezzato il De Monarchia, seppur con motivazioni diverse, a dimostrazione del fatto che, quando si critica un testo, quel che conta è il vertice di osservazione in cui ci si pone.
Dante, infatti, oltre ad esaltare l’Impero Romano, inneggia alla vera Pax romana, la sola che può garantire la libertà e quindi la felicità terrena. Recentemente, il filosofo Diego Fusaro (1983) ha definito il De Monarchia un testo modernissimo e dirompente in relazione al periodo in cui venne scritto. Fenomeno questo che capita soltanto a certi scrittori, come Dante, che hanno avuto la lungimiranza, conoscendo il passato, di interpretare il proprio tempo e di ipotizzare il futuro. Prerogativa quest’ultima riservata soltanto ai sommi autori!