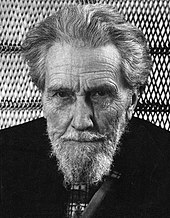Il sacro e la gioia nei “7 poemetti” di Franca Alaimo – di Guglielmo Peralta
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 16 Febbraio 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1113
 Tutto ciò che si riesce a trarre dal dolore è gioia. Questa ‘epifania’ del dolore, o della gioia, è il motivo centrale e ricorrente dei “7 poemetti” di Franca Alaimo, che, insieme con i “Frammenti”, costituiscono un unico iter poetico. Secondo una leggenda cinese nasciamo tutti con un filo rosso invisibile, annodato al mignolo della mano sinistra, col quale siamo legati alla nostra anima gemella. Il fiore della bellezza, il suo canto purissimo, di cui profuma ed è pregno il volumetto, ma che cresce da sempre, arricchito di essenze diverse nella piantagione ideale della nostra poetessa, induce a credere che la Poesia è la sua anima gemella, alla quale è legata con quel filo rosso fin dalla nascita. Il dolore, che accomuna tutti, muove alla ricerca della felicità, di una gioia che, se per Leopardi è un uscire provvisoriamente di pena, qui è un apprendimento e un mantra: una pratica meditativa da seguire con fiducia e costanza, come antidoto al male di vivere. La cognizione del dolore è trasformata in esperienza estetica, in una testimonianza, in una dichiarazione di poetica, in cui la poesia è rimedio, ristoro, conforto. Perché è per mezzo di essa che si trae la gioia dal dolore.
Tutto ciò che si riesce a trarre dal dolore è gioia. Questa ‘epifania’ del dolore, o della gioia, è il motivo centrale e ricorrente dei “7 poemetti” di Franca Alaimo, che, insieme con i “Frammenti”, costituiscono un unico iter poetico. Secondo una leggenda cinese nasciamo tutti con un filo rosso invisibile, annodato al mignolo della mano sinistra, col quale siamo legati alla nostra anima gemella. Il fiore della bellezza, il suo canto purissimo, di cui profuma ed è pregno il volumetto, ma che cresce da sempre, arricchito di essenze diverse nella piantagione ideale della nostra poetessa, induce a credere che la Poesia è la sua anima gemella, alla quale è legata con quel filo rosso fin dalla nascita. Il dolore, che accomuna tutti, muove alla ricerca della felicità, di una gioia che, se per Leopardi è un uscire provvisoriamente di pena, qui è un apprendimento e un mantra: una pratica meditativa da seguire con fiducia e costanza, come antidoto al male di vivere. La cognizione del dolore è trasformata in esperienza estetica, in una testimonianza, in una dichiarazione di poetica, in cui la poesia è rimedio, ristoro, conforto. Perché è per mezzo di essa che si trae la gioia dal dolore.
Richiami al mito, alla fiaba, alla filosofia, alla teologia, alle religioni, alla storia, all’arte, alla fisica, alla letteratura classica e contemporanea costituiscono un corpo di conoscenze, che rivelano la ricchezza spirituale e culturale dell’Alaimo e caratterizzano, definiscono, sostanziano l’intero componimento, in cui s’intrecciano contenuti realistici, ideali, ricordi, motivi civili, didattici, ed autobiografici, sentimenti diversi e contrastanti, aspetti piacevoli e dolorosi: il tutto, velato da una patina di malinconia che rende elegiaco il dettato poetico della nostra poetessa ed esprime il pathos della sua anima: la forza che agisce dal profondo e si contrappone al logos, alla parte razionale volgendo l’anima alla luce dell’amore, alla sorgente del sentimento qui declinato in tutte le sue espressioni, nelle quattro forme primarie individuate dagli antichi Greci: quello familiare, l’amicizia, il desiderio erotico ma anche romantico (eros), l’amore prevalentemente spirituale (agape). Quest’ultimo, lo stadio religioso che coincide con la fede ed è in relazione con l’etica e la morale, è, qui, epifania della gioia al cospetto dell’Assoluto - sia esso Dio o la Poesia - cui tutto è concesso e del quale ci si pone all’ascolto, all’obbedienza (ob-audire) fino al sacrificio, che non è quello di Abramo – secondo l’interpretazione di Kierkegaard e qui citato – , il quale pure trasse gioia da tanta dedizione a Dio, da tanto “Timore e Tremore”, ma è il sacer- facere: il compimento di un’azione sacra, che per l’Alaimo è la scrittura, è questi “poemetti”, ed è la grazia che riceve dalla visita del divino, il quale le si rese manifesto, per la prima volta, quando “ragazza / sfatta di pioggia e di lacrime” incontrò Cupido: “il ragazzo dell’amore mistico” e del desiderio sessuale, che mutò il dolore in gioia, alimentata dal soffio provvidenziale degli dei. Oggi è l’“amore della memoria”, che nel divenire del tempo e della crescita culturale si è fatto silenziosa presenza e dono, “la più alta felicità” nell’ascolto e nella benedizione, nel ricevere la luce sacra della Bellezza, della Poesia, quest’ultima associata alla madre, straniera e presto perduta, e dalla “lingua sconosciuta”; custode dell’amore che tutto rende sacro, e del segreto della vita, alla quale ogni cosa si consegna. Perché “Nulla ha riparo / se non nella vita stessa”. Tutto è esposto al pericolo, alla distruzione quando “muore / la grazia del mondo e comincia la barbarie”. Il miracolo dell’origine cede al terrore e alla crudeltà, di cui è qui esempio il tenente “Calley”, responsabile del massacro di My Lai durante la guerra del Vietnam. Nell’“oceano della vita” annegano “la bellezza e l’innocenza” insieme con i sogni, che sono l’alfabeto del corpo, i segni che ci aiutano a cancellare o a temperare il dolore; a misurarci con l’infinito, rispetto al quale siamo un microcosmo, una piccolissima parte, “un ghirigoro” “nel mare immenso di galassie e stelle”. Di fronte alla bellezza dell’universo, la vita è il canto che non si spegne. Finché fioriscono le parole, finché cresce l’albero della poesia, coltivato nel firmamento notturno, finché la luce dei grandi estinti continua a brillare, “la morte / abita altrove e non muore”. E la rinuncia alla vita è solo “un immenso sogno / un abbandono dei confini”. Nel marasma del mondo al tramonto, in bilico su un futuro incerto, esposto a una luce sempre più fievole, “la notte è così immensa, / così piena di Dio”, che ogni forma di vita s’infinita. Perché la notte è il principio e il non-luogo in cui tutto si crea, in cui si costruiscono i sogni, e la gioia è parola divina e rivelazione ed esplode colmando l’assenza, il vuoto di Dio. Se resta il mistero, se “nulla di noi sappiamo”, solo nella poesia il cuore trova risposte. Siamo sottratti al rito del dolore, alla crudeltà del destino e del sacrificio abramitico, al “volere che non vogliamo”, se agiamo «alla» e «nella» luce della Bellezza, se ‘praticando il sacro’ c’illuminiamo d’immenso e diamo così un senso a noi stessi e alla vita. Pianteremo l’albero, saremo noi stessi “il tiglio che sa, (…) e aspetta con pazienza di fiorire. / Sfiorire, fiorire e rifiorire sempre”. È questo l’annuncio segreto della vita. “Tutto ricomincerà”. “Tutto accadrà di nuovo”. Come ci è stato rivelato. Dobbiamo imparare ad attendere “e spargere semi / per vedere come crescono i fiori (…) come accadono intanto le altre cose”, per comprendere che tutto succede per amore. L’Amore è brama di luce, è la nostra realizzazione. C’innamoriamo per conoscerci, per guardarci nel profondo, nell’incommensurabile interiorità, dove il nome, il nostro “nome trema di fronte alla gioia”e al “soave mistero / della continuità della vita”. Dobbiamo guardare oltre, abolire il tempo, ridurre “la distanza fra desiderio e meraviglia” perché la Croce, e non il «caos», partorisca una stella danzante a conferma che Dio non è morto, che “Tutto non muore, tutto è vivo. / Nel più piccolo dei luoghi, / nella più piccola creatura”.
In questi poemetti gli elementi autobiografici segnano un tracciato, un percorso ‘fiabesco’, cioè magico, straordinario, pieno di suggestioni, senza incantesimi, che si snoda attraverso le diverse fioriture di un linguaggio lussureggiante, immaginifico, di grande ricchezza espressiva. L’Alaimo procede per incanto e per passione. La scrittura è memoria (”scrivo per ricordare”); è ritorno al tempo felice. La bambina “con una corona di latta sopra il capo / che giocava con il mondo / e lo ammirava stupita” e che è in lei e vive nel suo ricordo, l’esorta ad abbandonarsi, a gettare “sassolini”, come nella fiaba di Hänsel e Gretel, per non smarrirsi nella “selva oscura”, per ritrovare la strada di casa, la “fiaba iniziale”. L’abbandono di sé stessi è donarsi all’Assoluto (a Dio, alla Poesia) accettando con fiducia il corso degli eventi, attraversando anche le lacerazioni, le ferite più profonde. Ma senza il “timore e il tremore” di Abramo. Perché per l’Alaimo il sacrificio è aprirsi al sacro; è lottare contro il maleficio di una vita avara di attenzioni, di cura, d’amore, abbandonandosi alla stessa gioia che muove “i pianeti, le orbite, / la via Lattea, le costellazioni”. È sentirsi custode del Mondo. Ritrovare l’origine. È ritornare alla casa della propria infanzia e a quella del mondo, che fu la Parola, verso cui tutto qui volge ed è detto “con la bocca piena di luce”, come solo sa parlare la scrittura delle donne “assolutamente libere”, cioè con chiarezza e onestà, col dono della comprensione e della bellezza che curano “la ferita” del linguaggio oscuro e privo di senso, usato impropriamente, senza alcuna corrispondenza e tensione verso il Principio, verso la sorgente delle immagini rivelatrici, dove ci conducono questi poemetti, in cui la poesia è un rito sacro, purificatore, “da offrire all’altare della vita” per un nuovo battesimo, per l’inizio di una nuova “fiaba”. La scrittura è come quel gesto propiziatorio dell’adolescenza: il pestare “un’erba magica nel frantoio / per risvegliare i giorni della gioia”. È presente in questo rituale la natura, ora come veste indossata, aderente al corpo, fissata nella pelle come un tatuaggio, ora come ornamento, attributo delle cose, similitudine, termine di paragone:
“La mia casa di carne è un fiore”, le “orecchie (…) profumano di fiori”, “I lobi hanno il vermiglio del corallo”, “le rotule rotonde come due pesche”, “la voce luccicante come la pioggia”, “il sangue disegnò papaveri rossi”, “l’amore liscio come un ciottolo”, “Le vene diventano fiumi”, “le mie mani bianche colombe”, “Siamo fatti degli stessi atomi / di una stella che cade”, “gli dei mi guardavano / con occhi vegetali”, “la notte che guarda / con occhi stellati”, “I loro cuori fragili fioriscono / lungo i bordi della via Lattea, le loro voci sussurrano / come api che ronzano” (…) come il mare dentro le conchiglie”, “La notte (…) Tocca con tenerezza i capi dei passeri, / le cime degli alberi, / i fianchi delle montagne / e poi si raccoglie dentro i fiori che sognano”, “parole fatte di acqua, stelle e minerali”, “tutto è un fiume che va verso il mare”, “Le labbra sono due valve d’ostrica / che hanno il sapore di tutti i mari”, “ero un’allodoletta o una colomba / sul tetto della casa”, “dopo la madre-rosa, / ebbi la madre-spina”, “Il mare era incastonato / nel mezzo della carne / come un lapislazzulo blu”, “mia vita verdeggiante”, “La mia felicità durava quanto un fiore di campo”, “raccoglievo negli occhi la mappa delle costellazioni”.
Questi versi, che rivelano la corrispondenza, lo stretto legame del corpo e delle cose con la natura, costituiscono un testo nel quale ‘figurano’ i 7 poemetti, essendo esso composto dai loro ‘frammenti’. L’esito è una ‘narrazione’ autobiografica che si fa canto universale, “liturgia cosmica”, e che perciò rende palese la comunione della nostra poetessa con il corpo mistico della Poesia. Questa unione, contrassegnata dall’alternanza di amore e dolore, è il ‘segreto’ che si annuncia nella silloge, tra le pieghe della scrittura, e che si manifesta nell’ultimo poemetto, nella dichiarazione a Dio della bellezza di tutto, della quale pure “riluce la morte, lo schianto, l’urto tra cielo e terra!”: quest’ultimo, espressione del dolore del mondo, che si risolve nell’esplosione della gioia purificatrice, la quale è, per l’Alaimo, consegnarsi al sacro “con chiarità, senza paura”, e abitarlo nell’abbandono consapevole di sé stessa.