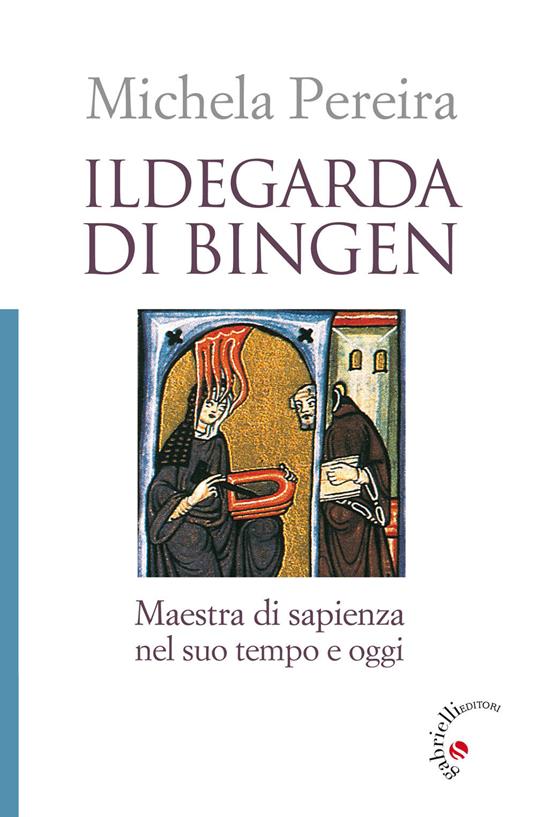“La dimensione dell’infinito nell’anfibio viaggio tra sogno e realtà di Giancarlo Stoccoro” di Guglielmo Peralta
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 11 Novembre 2022
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1268

“I sensi - afferma Gregory Bateson - tengono fuori il mondo”, il quale ci sfugge in quanto ne facciamo parte, ma che è possibile cogliere attraverso “l’ispirazione artistica[1]”, che Stoccoro preferisce chiamare col termine più poetico e appropriato di rȇverie, con il quale titola anche la prima delle quattro sezioni della silloge, dove le poesie sono tutte senza titolo. La rȇverie, che tiene insieme le sezioni rendendole fra di loro ‘comunicanti’ e che ‘tesse’ l’intera narrazione conferendole omogeneità e unità, non è il puro fantasticare, né l’ispirazione che richiede l’attesa ma è l’atto dello sguardo, ovvero, il sogno che consente d’immaginare il mondo, di ri-crearlo. L’occhio è la distanza che ci separa dal mondo. È lo sguardo a riportarlo dentro, nell’interiorità, dove in virtù del sogno, si apre l’altra vista: quella che è preclusa agli occhi, i quali non vedono oltre la ‘siepe’ altri spazi che non siano il cielo e le forme a noi note, chiuse nell’orizzonte ristretto dell’esistenza quotidiana, nella cornice del visibile ingannevole nella sua concretezza, che tuttavia lascia indovinare al di là di esso un’invisibile e immutabile bellezza, la quale è l’essenza e la provenienza della realtà delle cose e dei luoghi che le accolgono. Ed è questa bellezza che riduce la “distanza”, promette all’“occhio” il “cielo”, cioè una vista migliore, e mette il poeta in cammino nel bosco fitto della conoscenza superiore, “con passi d’ombra” ma fiducioso che i “sogni”, tra le interruzioni inevitabili e necessarie, possano “aprire il sentiero” verso quella luminosità improvvisa che Heidegger chiama la «radura» (Lichtung), la quale rivela a chi s’inoltra nel bosco di fitta vegetazione, tra gli «holzwege»,[2] una veduta più ampia e più bella, che, fuor di metafora, è l’orizzonte entro cui gli enti si concedono allo sguardo mostrando la loro intima natura.
“Anfibio è il buio / finché sigilla gli occhi / cerca la complicità del sogno”. E anfibio è il ‘viaggio’. Percorrere questa silloge è come camminare sul nastro di Möbius, difficilmente orientabile. Questo è una superficie con una sola faccia percorrendo la quale ci si ritrova ‘sotto’ il punto di partenza, da cui il ‘cammino’ può riprendere all’infinito. Allo stesso modo, il ‘viaggio’ del Nostro si snoda, senza soluzione di continuità, tra il sogno e la realtà, tra il buio e la luce, ovvero, tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’, che insieme costituiscono un percorso unico e circolare. Il sogno è il trait d’union fra la realtà e l’oltre, tra il visibile e l’invisibile. “Dove bui sono gli occhi / predica bene il sogno”. La ‘cecità’, il buio degli occhi sempre è rischiarato dal sogno dello sguardo, che illumina il sentiero. Si aprono così quegli “spazi” che il nostro poeta non nomina perché indefinibili. Essi sono le “distanze” frequentate dal linguaggio poetico, che, in questa silloge, è una tessitura sonora di allitterazioni, assonanze, consonanze, e procede, in stretta unione col pensiero analogico, per somiglianze e differenze, per metafore, similitudini e illuminazioni: istanti di grazia che ‘realizzano’ il contatto con l’Invisibile, con l’Infinito, operando una trasfigurazione semantica, la quale congeda il linguaggio ‘ordinario’, lo libera dall’ovvietà, dalla convenzione, dalla comprensione immediata sospendendo il pensiero logico dentro una selva di simboli, che non lasciano filtrare la luce razionale, la quale arretra all’incedere del canto. Solo “il dolore muove da un’alba antica / porta in dote geometrie lontane / rinuncia al canto delle labbra / cerca l’invenzione ultima del cielo” per inondarsi della luce della grazia. Ciò richiede la sospensione delle parole, affinché “non si spezzi l’ombra” e il canto sia affidato agli occhi, incapaci, tuttavia, di cogliere nell’ombra la luce promessa. E così vano è il tentativo di sconfinare oltre la ‘siepe’, qui rappresentata dalla “finestra muta”: metafora che esprime efficacemente l’impossibilità della ‘visione’. Soltanto “un solitario raggio di luce” balena nell’oscurità, inganna “l’occhio” consentendogli una fugace contemplazione e lo “dirige alla resa”. Questo raggio, perciò, non incide la coscienza, non entra in relazione con l’«io» profondo, lasciando chiusa “ogni finestra” che lo “intrappola” e non consente di portare in chiaro i sentimenti, le emozioni, né di cogliere, soprattutto, qualche lacerto d’infinito oltre la ‘siepe’. Lo sguardo, allora, supplisce a questa mancanza. Esso è l’altra “finestra” che consente il varco; è l’apertura tra il ‘dentro e il ‘fuori’ attraverso la quale lo sguardo “moltiplica lo spazio”, perché esso obbedisce (ob-audire), dà ascolto alla voce ‘bene-dicente’ per la quale accade la parola: quella più prossima alla fonte che le dà luce. “Ogni lingua lo sguardo chiama (…) più voci si scambiano la pelle” perché per mezzo di questo ‘sognatore’ le parole si spogliano del loro significato comune e assumono nuovi e molteplici significati; e sono, questi, le illuminazioni, le visioni, che abitano le parole, in piena cor-rispondenza. Le parole che il ‘sogno’ ridesta mutandone il senso, sono i ‘luoghi’ a noi familiari; sono la casa che abitiamo e dove dimora il nostro essere, il quale, se non ha altro luogo all’infuori di noi è perché esso «è» in noi e ci parla. E noi siamo il suo linguaggio. Allora “Se i luoghi diventeranno domestici”, non sarà più necessario “sfogliare il cielo” perché lo abiteremo nella Parola, che tradurrà tutto il silenzio raccolto in essa fin dall’origine, da quando eravamo con il mondo bambini. Fuori dallo sguardo c’è solo la memoria del tempo vissuto, della vita migliore, del nostro essere mito, giovani ‘dei’, e mortali inconsapevoli di quanto un giorno saremmo stati distanti da noi, dal nostro essere, dal tempo delle “favole”, dove era bello “sostare”, e tacere era virtù e meraviglia. Lo sguardo, solo al quale è concesso di sognare, volge là dove non c'è separazione, dove l'Assoluto è absolutus, sciolto dai lacci del linguaggio, e perciò mantiene il legame con la Parola. E questa mancata separazione è la distanza, la lontananza incolmabile, perché dell’origine non abbiamo memoria. A questa supplisce l’immaginazione creatrice che imita la Parola innalzando il linguaggio alla Poesia, la quale si annuncia nell’ombra delle parole, dove declina la luce dell'Infinito. Altra distanza è “il tempo cucito dalle parole” e cioè quello dell’infanzia, di cui il Nostro va alla ricerca unendo, mettendo insieme lacerti di ricordi che le parole restituiscono col velo della nostalgia e ammantati di struggente bellezza, perché toccati e ridestati dal sogno versato in poesia. E il sogno, che ama l’infinita distanza, chiama le parole a cucire pure quei frammenti di luce che lo sguardo intravede e sottrae all’oscurità per ri-comporre il poema del mondo. Ma l’ordito, dove pure il cielo tracima, è l’impossibile canto, la difficoltà dell’uomo di mettere radici, di essere padrone del proprio destino, anche quando da poeta “si finge” l’Infinito, perché il ‘dolce naufragio’ è solo l’illusione di approdare all’essere, di “colmare una distanza” - scrive Stoccoro - “per riabitare una parola come si faceva da piccoli ancora prima di comprenderne il senso o solo per ripeterla come un mantra”. Perché, nelle parole, anche se non cuciono il mondo, è il nostro essere e il nostro tempo. Ma è l’amore, che realizza l’intesa tra gli sguardi, a fugare le ombre, ad aprire una dimensione d’infinito, dove “le cose spogliate del loro nome” col quale le possediamo, liberate dalla schiavitù dell’uso, ci vengono incontro mostrando la loro intima natura. “C’è sempre una distanza / armata di nostalgia” che apre i luoghi dell’infanzia, che lascia crescere i sogni con i quali “gli occhi vestono la pagina”. Ma “nessuna opera sia adulta” - avverte Nanni Cagnone nei versetti posti in epigrafe - affinché l’anima resti bambina, l’innocenza sia salva, e il tempo resti fedele al mito concedendosi alle parole che ne cuciono i magici sentieri. Questi sentieri perduti e ritrovati sono “le inguaribili distanze”, che, “intrecciando radici”, non lasciano vuoti nella memoria, la quale si arricchisce della poesia dell’infanzia. Memoria poetica e poesia della memoria accompagnano il Nostro in questo lungo ‘monologo’ che, anche se non è una libera associazione di idee, pensieri, immagini, sentimenti, ricordi, somiglia a un flusso di coscienza, non essendoci soluzione di continuità tra le sezioni che compongono la silloge e tra un testo e l’altro; e perché vi prevale l’uso di stilemi creatori di mondi, quali: lo sguardo, il sogno, la rȇverie, per cui assistiamo a un processo di enunciazione in assenza di punteggiatura, il quale, anche se è formulato, soprattutto, in seconda persona, in quanto ha la sua origine e il suo sviluppo in interiore, è autocomunicativo, ed è perciò un’estensione dell’io monologante, che risulta così amplificato. Il monologo resta tale, sia quando il Poeta si rivolge a un ‘tu’, col quale mantiene una stretta relazione, sia quando ‘finge’ un dialogo tra due parti di sé: l'anima e il corpo. La prima è la leggerezza dello sguardo che contempla ‘fuori’, attraverso la finestra, e ‘dentro’, nello spazio interiore, e che gli consente di ‘viaggiare’, di evadere dalla ‘prigione’ di carne; il secondo è la fisicità, l’immobilità, la permanenza nel luogo, in cui nasce il desiderio di esprimere il proprio sentire, di scrivere “per colmare una distanza”, per trovare nelle parole la quiete, “il puro suono” del tempo perduto e “ricucito” e dare respiro alla stanza, alla casa. È fra le mura domestiche che Stoccoro inizia e compie questo viaggio, che ricorda quello descritto da Xavier de Maistre[3] nel suo romanzo “Viaggio intorno alla mia camera”. Come il de Maistre, egli è costretto a vivere da “prigioniero” nella stanza, ma a causa della pandemia di Covid, e non come invece accadde allo scrittore italiano di lingua francese, condannato agli arresti domiciliari per un duello. Come lui, Stoccoro fantastica, sogna, e si abbandona a vecchi ricordi, ma la sua ‘evasione’ avviene tramite la finestra, che gli consente di contemplare le “forme del cielo” e di “fingersi” l’Infinito. E così il pensiero, che ama la rêverie, vagando verso l’alto con lo sguardo, tocca la profondità nell’interiore spazio. La finestra, allora, è una metafora speculare perché attraverso di essa si stabilisce il contatto tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ che sono l’uno la proiezione dell’altro, e viceversa. La stanza, dunque, che per sineddoche rappresenta la casa, è il cuore pulsante del viaggio; essa respira attraverso la finestra, dalla quale riceve la luce e l’ideale esposizione a un oriente che è meta dello sguardo, e per cui l’intera casa assume un significato particolare, diverso, divenendo anch’essa metafora della ricerca e luogo dell’ubiquità, in cui il nostro poeta abita fisicamente dimorando con la mente e con l’anima altrove: là dove sono le sue radici e dove la Poesia lo chiama. Il viaggio, allora, non è come per il de Maistre un camminare in lungo e in largo e in diagonale per la casa divagando, narrando, filosofando, ma è un itinerario scelto, desiderato, volto alla ricerca, sia del tempo felice dell’infanzia, sia dell’origine, dell’essere senza tempo. La ‘casa’, perciò, è la meta. Domandarsi con Novalis «Dove stiamo dunque andando?», è darsi la risposta inequivocabile: «A casa, si va sempre verso casa». Tutti i sentieri tracciati dallo sguardo confluiscono nel Sentiero linguistico ed espressivo, dove il sogno lascia intravedere la radura. È per questo che Stoccoro può scrivere che “non esistono parole distanti / sul sentiero che porta a casa”. Perché «il linguaggio è la casa dell’essere», come Heidegger ha bene intuito. Ed è il sogno, quando le parole lo vestono di poesia, che consente di “officiare il proprio essere nel mondo”. E qui “lo sguardo ospite del cielo (…) traccia linee rette / per il cammino degli occhi”, che acquistano vista spirituale, “quando la vita incontra la bellezza”. Allora “gli occhi dimenticano la stazione del corpo”, promettono all’anima di viaggiare su passi sicuri, resi tali dalle orme di luce sul sentiero, perché il viaggio è della mente e del cuore, ed è un procedere in linea retta con la poesia e il suo linguaggio: compagni necessari e insostituibili. Ed è nelle parole che il nostro poeta ripone la sua fiducia nel proseguire. Ma, anche se “lo sguardo è la forma dell’orizzonte” (…) anche se “il cielo promette maggior fortuna / a chi si mette in viaggio / cucendosi addosso finestre grandi”, le parole gli lasciano “la bocca piena di consonanti”, incapace di pronunciare la parola piena, “non spezzata”, che “fa corpo con il silenzio”. E non basta il “corteo di sillabe” a comporre il ‘canto’, a cogliere “la verità (che) è nello spazio di chi cammina”. Sempre inevasa resta la “promessa d’infinito” e, tuttavia, non viene mai meno nel Poeta la ricerca dell’oltre, e incontenibile è il desiderio di “ricucire sguardi” che possano ‘bucare’ l’ombra quando “il tempo unito dalle parole / cuce la notte sul volto”. Lo sguardo, che fin dall’inizio abbiamo indicato come protagonista della silloge, sul finire dell’opera, nell’ultima sezione, assume la funzione di ‘educare’ l’occhio, affinché ciò che si ‘rivela’ «dentro», ciò che “al riparo dalla luce visitiamo in sogno” si traduca in “immagini per gli occhi / da appendere fuori dalla finestra”; affinché gli occhi siano capaci di ricevere la luce della bellezza dalle percezioni esterne e sappiano godere delle immagini tessute dalle parole e versate in poesia. “La prima lezione di sguardo / è la finitezza dell’occhio”, la cui visibilità non gli consente di andare oltre lo spazio ‘incorniciato’ dalla finestra. E di questo suo limite soffre la parola: quella inascoltata, serrata nel silenzio e fabbricata artigianalmente dalle “labbra”, e perciò priva d’inventiva, di originalità, di significanza. È la poiesis, il fare dello sguardo, che trae le parole dal nulla, dal silenzio dandogli “una voce”. Là, dove l’occhio non supera la superficie delle cose, è “il naufragio”, perché alla “distanza” ci si approssima solo salendo in profondità con lo sguardo, in virtù del quale “forme del cielo / nascono dalle labbra / L’ignoto attende l’alba /apparecchiare la terra”.
Ed ecco! Il difficile cammino, d’improvviso, sembra ‘segnare il passo’. Sospesa è la ricerca, l’attesa dell’alba; declina il sogno del mistero e l’ignoto muta la sua ‘natura’ ineffabile, perde tutto il suo fascino. Esso è l’invisibile nemico, che «ci» ha di colpo gettati nel “tempo stretto” della pandemia costringendoci a misurare la distanza, tenendoci separati e lontani dalle persone care, a restare “confinati nello sguardo”, a sospendere la vista dell’orizzonte divenuto “la culla del disincanto”. Grande è la sofferenza del nostro poeta per l’assenza forzata della sua donna, per la difficoltà di vederla. Egli rimpiange l’altra distanza, quella che non gli impediva d’incontrarla, che non era “questo camminare a modo / con la mascherina e poco sguardo / che si fa strada nelle fessure degli occhi”. La casa, ora, è il silenzio inaccogliente, asettico, arredato con “pareti bianche (…) Luoghi fuori campo“ infrequentabili, popolati di ricordi, di sogni colmi di futuro, del tempo che verrà, affollato “di gesti”, di “parole”, d’incontri, di “occhi / (che) cuciranno sguardi / sui corpi / inchiodati alla terra”. Il viaggio, allora, sarà questa voglia di vivere, di tornare ad essere padroni dello sguardo. Perché “nella vita dello sguardo / la pianura si avvicina alle case / le unisce come fa il giocatore / con un mazzo di carte”. E non c’è ‘giocatore’ più esperto del sognatore.
[1] G. Bateson, Verso un’ecologia della mente
[2] Holzwege è un’opera di M. Heidegger tradotta in italiano con Sentieri interrotti. Sono, questi, i sentieri nascosti dalla fitta vegetazione che rende difficile l’orientamento, il procedere nel bosco. Si tratta, ovviamente, di una metafora per indicare la difficoltà della conoscenza, di pervenire alla verità dell’essere, la quale richiede tanti percorsi di pensiero in quanto non esiste un’ unica indagine diretta alla conoscenza.
[3] De Maistre (Chambéry, 8 novembre 1763 - San Pietroburgo, 13 giugno 1852), è stato un militare, scrittore e pittore italiano sabaudo di lingua francese, suddito del Regno di Sardegna e generale dell'Impero russo durante le guerre napoleoniche.