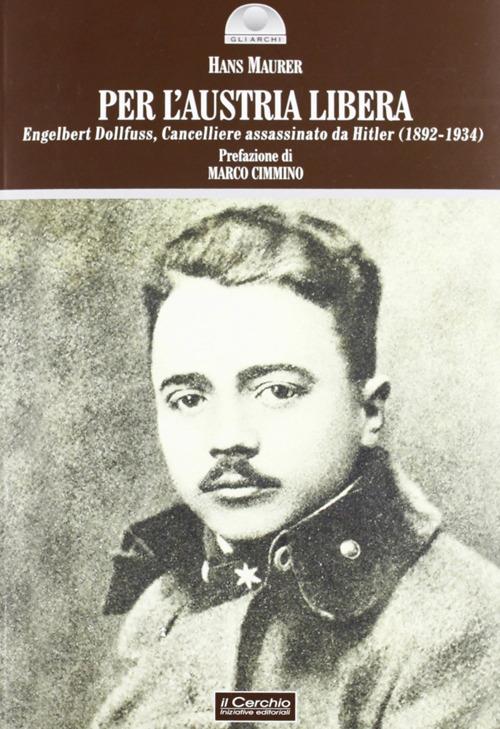“La forza purificatrice del dolore nella poetica di Giovanni Pascoli” lettura ed analisi di Giovanni Teresi
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 04 Novembre 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 3321
 La vita è male: la terra su cui viviamo è definita in “Dieci agosto”: “quest’atomo opaco del male”
La vita è male: la terra su cui viviamo è definita in “Dieci agosto”: “quest’atomo opaco del male”
Da che cosa deriva il male? Anzitutto deriva dalla paura, la quale a sua volta deriva dalla tenebra del mistero che ci avvolge tutti.
Nella poesia “La vertigine” il poeta immagina il globo terrestre lanciato a velocità spaventosa nello spazio cosmico con gli uomini attaccati al suolo con i piedi, pendenti in giù con la testa: una posizione delle più infelici, in moto verso mete che nessuno conosce.
Il “dubbio” strazia l’animo del poeta (il Carducci in “Idillio maremmano” parla del tarlo del pensiero che gli trafora il cervello): nella “Preghiera dell’eremita” egli fa dire al suo eremita: “A me dispensa (risparmia) il reo dolor che pensa” cioè il dolore del pensiero, ossia il dubbio.
Altra causa del dolore umano è la cattiveria degli uomini.
Il Pascoli subì un grave shock a causa della uccisione del padre e di altre numerose sciagure, che investirono la sua famiglia, in conseguenza di quel fatto. Visse la sua adolescenza e giovinezza nel periodo in cui il capitalismo opprimeva gli operai, e gli anarchici, in nome degli operai, compivano imprese terroristiche.
Egli stesso fu messo in carcere per aver scritto una poesia in onore dell’anarchico Passanante che aveva attentato alla vita di Umberto I nel 1879. Poi si staccò dall’anarchismo e aderì spiritualmente (non politicamente) ad un socialismo umanitario che attuasse la pace tra i popoli e la giustizia per gli oppressi.
Dapprima, è vero, s’illude di servire alla causa sua e di tanti altri infelici, iscrivendosi all’Internazionale, che per lui e per molte altre anime ingenue, rappresentava il sogno millenario di una palingenesi sociale, il mito antico e cristiano di una universale fratellanza. Ma il socialismo si rivelò ben presto per un movimento utilitario e di conquista, ed egli allora si ritrasse anche da questo ultimo legame con i partiti del tempo. Si aggiunga la triste esperienza del carcere lui , cui avevano ucciso il padre! si pensi alle ombre che popolarono quelle cupe giornate, alla sua solitudine all’indomani, alla povertà, alla fame, ai suoi propositi di suicidio, dal quale soltanto una voce, “e voce stanca, voce smarrita col tremito del batticuore”, quella della madre, lo distolse, e si comprenderà quanta forza di rinnovamento e di affinamento abbia avuto in un animo quale il suo dolore, quanto questo abbia contribuito a dargli quella impronta che è tutta sua e solo sua, come, macerandosi nel dolore e nel dolore cercando una ragione della propria esistenza, il Pascoli abbia avuto la rivelazione di se stesso e della sua poesia.
Nel suo poemetto “L’eremita”, così prega all’alba: “ Dio, no negare il sale alla mia mensa,/non negare il dolore alla mia vita!
E a sera: “ …. Signore, fa ch’io mi ricordi!/ Dio, fa che sogni! Nulla è più soave/ Dio, che la fine del dolor: ma molto duole obliarlo; ché gettare è grave/ il fior che solo odore quando è colto”.
Si sente che il Pascoli ha fatto del dolore una religione, che in esso riconosce il segno della sua nobiltà e la bellezza e la forza purificatrice.
Ma, non solo soltanto gli uomini soffrono, non soltanto essi meritano pietà. Soffre tutta la natura; soffrono tutti gli esseri. Sono partecipi della vita, e quindi anche del dolore. Quella sacra pietà “che l’uomo all’uom più deve”, ha da estendersi quindi anche a questi. Tale condizione d’animo lo portò ad essere il poeta del mite sentimento e della mite parola,l’ispirato cantore dei miseri, dei vecchi, dei fanciulli, dei fiori, degli uccelli, di tutte le cose umili,le quali chiudono in sé il destino delle grandi, ché in tutto si trova l’infinito, come nella conchiglia si sente il mare.
“L’EREMITA” – poemetto
Pregava all’alba il pallido eremita:
«Dio, non negare il sale alla mia mensa,
non negare il dolore alla mia vita.
Ma del dolore che quaggiù dispensa
la tua celeste provvidenza buona,
a me risparmia il reo dolor che pensa.
O, s’è destino, per di più mi dona,
con quel che pensa, anche il dolor che grida:
l’afa che opprime, il nuvolo che tuona;
pensier che strugga e folgore che uccida!»
E ripregava a mezzodì: «Rimane,
Dio, che tu lasci che il nemico muto
pur mandi a me le nudità sue vane.
Quando al vespro del mio dì combattuto
dilegueranno, io penserò che, vere,
le avrei non meno dileguar veduto.
Nel cuore sono due vanità nere
l’ombra del sogno e l’ombra della cosa;
ma questa è il buio a chi desìa vedere,
e quella il rezzo a chi stanco riposa».
A sera, disse: «Il servo, umile e grato,
ti benedice! Tu mi desti, o Dio,
l’aver provato e non aver peccato.
L’anima mia tu percotesti e il mio
corpo di tanto e tal dolor ch’è d’ogni
dolcezza assai più dolce ora l’oblìo.
Infelice cui l’occhio apresi ai sogni,
apresi nella grande ombra che tace,
sia che già tema, sia che sempre agogni!
Piansi, non piango: io dormirò: sia pace!»
E velò gli occhi il pallido eremita.
Ed ecco gli fluìa per i precordi
il dolce sonno della stanca vita;
quando riscosso (egli scendeva a fior di
grandi acque mute su labile nave)
gridò: «Signore, fa ch’io mi ricordi!
Dio, fa che sogni! Nulla è più soave,
Dio, che la fine del dolor; ma molto
duole obliarlo; ché gettare è grave
il fior che solo odora quando è colto».
(Giovanni Pascoli)