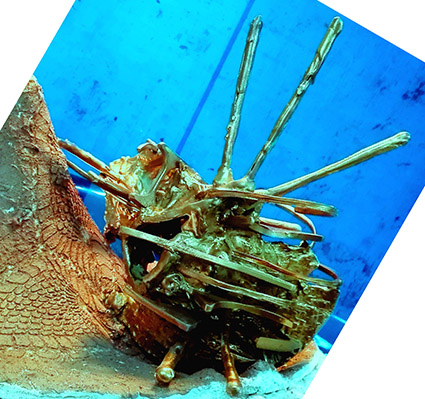Mario Inglese recensisce “L’airone celeste” di Tommaso Romano (Ed. All’Insegna dell’Ippogrifo)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 05 Marzo 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2122
 Con questa nuova raccolta di versi Tommaso Romano perviene a una tappa importante del suo lungo percorso creativo, una tappa che al contempo si configura come summa di una vicenda artistica e umana. Se è vero che, in una certa misura, non si scrive che un solo, unico libro, ciò sembra valere anche per questo autore, nel senso che essere fedeli a se stessi non vuol dire affatto ripetersi, quanto avere il coraggio di misurarsi costantemente con la ‘discordante concordanza’, per dirla con Paul Ricœur, della propria storia personale. Storia personale che è identità umana declinata secondo il lento ma implacabile scorrere del tempo, ma che è anche storia di luoghi, di una terra, di una società, con le sue evoluzioni – e involuzioni – etiche, politiche o antropologiche tout court.
Con questa nuova raccolta di versi Tommaso Romano perviene a una tappa importante del suo lungo percorso creativo, una tappa che al contempo si configura come summa di una vicenda artistica e umana. Se è vero che, in una certa misura, non si scrive che un solo, unico libro, ciò sembra valere anche per questo autore, nel senso che essere fedeli a se stessi non vuol dire affatto ripetersi, quanto avere il coraggio di misurarsi costantemente con la ‘discordante concordanza’, per dirla con Paul Ricœur, della propria storia personale. Storia personale che è identità umana declinata secondo il lento ma implacabile scorrere del tempo, ma che è anche storia di luoghi, di una terra, di una società, con le sue evoluzioni – e involuzioni – etiche, politiche o antropologiche tout court.
Per cercare le ragioni di questa unitarietà, che è di stile oltre che di sensibilità e urgenza del discorso mitopoietico, basta osservare tutta una serie di costanti o, se vogliamo, di variazioni su tema (è nota la passione dell’autore per la musica), che riguardano certi snodi fondamentali che contraddistinguono la scrittura di Romano. I titoli stessi delle numerose raccolte di versi o di alcuni poemetti sono assai indicativi di una dimensione che tracima dal qui e ora per investire una zona liminare, oserei dire trascendentale. Una dimensione dove non ci si limita a registrare il reale, per quello che questa parola possa voler dire, bensì le ‘intermittenze’ del cuore e del pensiero. Ecco dunque L’isola Diamascien, Eremo senza terra, L’anacoreta occulto, Futuro eventuale, Di/sperate parole, Nel mio Regno dei Cieli, L’illimite sorte, Esmesuranze, solo per fare alcuni esempi. È agevole, in questo modo, individuare singoli temi, spesso in opposizione binaria quali, ad esempio, presenza e assenza, assoluto e nulla, tedio e stupore, autenticità e inautenticità. Emerge in Romano una sensibilità che certamente si traduce in un’aristocrazia dello spirito, in coscienza di una dignità e di un’insopprimibile esigenza di elevazione che si scontra dialetticamente con la constatazione che il mondo (potremmo quasi dire la sfera sublunare contrapposta a un universo ben più ampio e impalpabile, di cui sono spia lessemi quali cieli, celeste, assoluto, Dei, Origine, Infinito, ecc.) ben poco coltiva i valori dello spirito, della sete di assoluto, della bellezza. Bellezza che, come scrive Keats, è verità. Ne consegue un comprensibilissimo fastidio verso tutto cio che è banale, volgare, verso il rumore della “metropoli / affolatta e afflitta” (cfr. “Flebile alito”, p. 46). Il sogno verso una dimensione altra cozza contro una sorta di terra desolata (“Il sogno regale nel sogno / si schianta nella terra arsa / in realtà dove non scorre fiume” (cfr. “Presenzassenza”, p. 76). Altrettanto eloquenti sono i seguenti versi: “Nel segmento del vuoto / altro e altrove / di parole inessenziali / c’è tutto il dover fuggire. // Non si placa lo sdegno / al banale, / altro e altrove / è il sopravvivere.” Cfr. “Altrove”, p. 33).
Il desiderio di verita è tanto più forte in quanto lo spettacolo del mondo inscena “tanti schiamazzi e diatribe / false opinioni, intrighi / di mero interesse calcolante” (cfr. “A compimento”, p. 77). Analogamente, il poeta non nasconde la propria avversione verso i triti rituali di una società colta impietosamente nella sua autoreferezialità: “Siamo sempre tutti premiati / e ci premiamo a vicenda / e non si capisce il perché / dato che allo stesso tavolo / sediamo forse amici o pseudotali, / vipere che fingono amicizia /e conoscenti a cui amicizia non si deve. / E sono tutti qui: / camaleonti, iene e sciacalli, / con pochi militi noti / alla buona invisibile scrittura” (cfr. “Stanco cerimoniale”, p. 56).
Importante è la poesia proemiale: l’attesa è condizione dell’esilio, è spes contra spem, ‘presenzassenza’ sul declivio del tempo, sul franare delle cose e della vita, è “una inespressa possibilità” (“Aspettiamo col tempo / che non aspetta / e cancella l’attesa / d’una stagione, di un’offerta / di una persona che ci porti / briciole di felicità serena. / Aspettiamo tempi migliori / e le pagine bianche da scrivere / aspettiamo la notte / per un sogno d’incontro / e l’alba che arrivi presto / per farla finita con il buio / nel timore di non svegliarsi”. Cfr. “Nel limitare del tempo”, p. 9)
Incrollabile resta la fede nel potere salvifico della Parola che, come il lógos primigenio, si sostanzia nell’atto creativo. La scrittura è lavoro di bulino, intarsio, mira alla Bellezza, perché al tempo stesso ne è inveramento (“dignità nell’incerto sentiero, / necessitata, minuta scrittura // in filigrana // per abbandonare, / di anima, / ogni angustia”, cfr. “Nessuna nuova all’angustia” p. 68).
La vita resta un esilio da una una terra mitica e reale allo stesso tempo, si rifugia in uno scrigno di bellezza, appagamento fugace tra le pareti di una stanza. È forse questa la stanza di Petrarca o di Leopardi, dove si consuma il distillarsi della poesia, dell’essenza del vivere e del patire, del desiderio di un più vasto orizzonte, paradossalmente postulato, di un altrove, di un oltre, al di là dei limiti posti dall’esistenza. Ancora una volta pensiamo a Leopardi. È lo spazio dove si depositano le concrezioni del tempo ma anche lo spazio sacro dove le cose amate, umili e nobili, sono assorti sacerdoti della bellezza. Vengono alla mente anche Gozzano e D’Annunzio, con la precisazione che non di pessimo gusto si tratta (“Piccole cose e non di pessimo gusto / perché è il mio cercare / che s’intarsia nel tutto / un porto e un rifugio per non far cadere / queste compagnie fedeli / in mani avide, infide, volgari. // [...] Non bruciate le carte / fu auspicio e grido / non bruciate questo mosaico / non smembratelo, non disperdetelo / è amato come perfezione possibile / s’accresce / come graal d’anima...” Cfr. ‘Intarsio nelle cose”, pp. 23-25). Si vive nell’horror vacui del tedio, della noia, nella certezza che forse si corteggia o si esorcizza sempre la morte, a cui non facciamo che erigere “cenotafi”, come si esprime Romano.
L’imperativo allora è quello di non disperdere le possibilità a noi concesse nel gorgo dell’eracliteo divenire, anche se il poeta resta conscio di vivere tempi di certo non propizi. Il “male a vivere” della madre inferma è anche “il male di vivere” di montaliana memoria (cfr. “Lieve delirio” p. 19). Il rischio dell’esistenza è anche la trappola dell’inautenticità, mentre lo sguardo rivolto a una natura primigenia, inviolata, è forse promessa di riscatto, barlume di autenticità. Ciò che appare superfluo ai più, spreco, lento accumulo procurato dal desiderio di attingere alla bellezza nelle sue varie manifestazioni, sembra schiudere un varco verso “grandi scoperte sublimi, felici” (cfr. “L’ordine sacro”, p. 40).
Il “silenzio ascetico” (cfr. “Per miserabili imposture”, p. 53) è lo spazio che lo spirito si conquista per respirare, meditare, creare, come l’aria e l’acqua sono elemento vitale per l’airone celeste, alla ricerca “di perfetta armonia / d’una bellezza, / in verità, / che t’appartiene” (cfr. “Libero airone”, p. 59). Il poeta si rivolge alla creatura, reale eppure mitica, come fa Lohengrin con il suo sublime cigno. Non è dunque casuale che questa poesia, come diverse altre nel libro di Romano, contenga un’epigrafe di Cristina Campo e più di una traccia della sua intensità spirituale tradotta in tenace fede nelle possibilità della parola poetica.
Non possiamo dunque che essere sinceramente grati al nostro poeta palermitano per aver tenuto alta nel corso di tanti lustri l’onerosa fiaccola della poesia, l’espressione letteraria più lontana da ogni logica utilitaristica di mercato ma forse la più adatta a dare vita a quel necessario, indissolubile connubio di parola, spirito e pensiero.