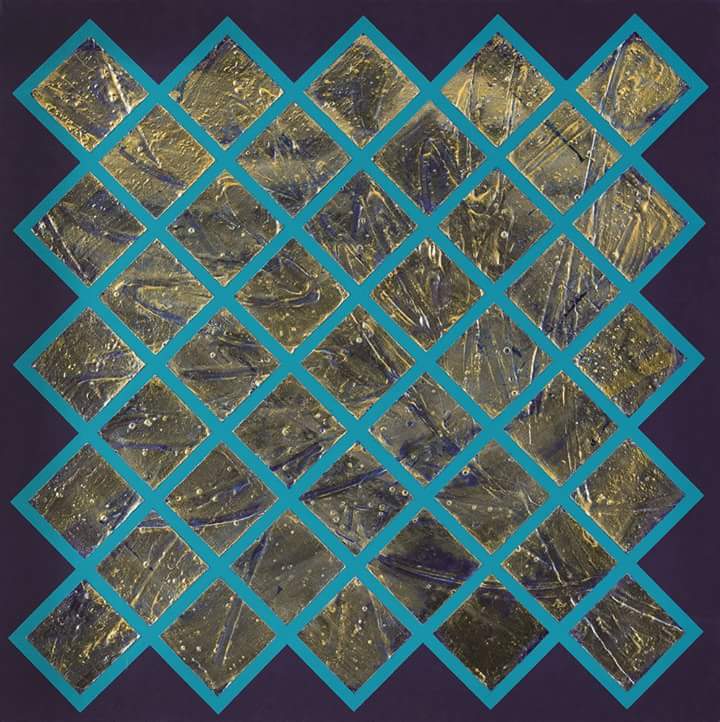Myriam De Luca, "L'invisibile nutrimento" (Ed. Thule) - di Lorenzo Spurio
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 11 Gennaio 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1644
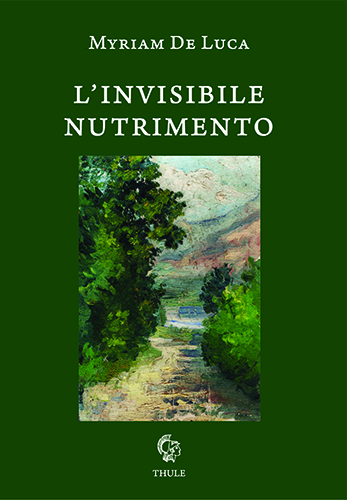 La poesia di Myriam De Luca
La poesia di Myriam De Luca
Myriam De Luca, poetessa, è nata e vive a Palermo. Per la poesia ha pubblicato le raccolte Esortazioni solitarie (Il Convivio, Castiglione di Sicilia, 2018) e L’invisibile nutrimento (Thule, Palermo, 2020) mentre per la narrativa il romanzo Via Paganini, 7 (Spazio Cultura Edizioni, 2018).
Desta una particolare attenzione, sin dall’inizio, la scelta meticolosa ed elegante dei titoli delle sue raccolte di versi. Nella prima di esse – di cui va senz’altro ricordata la prefazione di Sandra Vita Guddo – si legge di Esortazioni solitarie e in tale definizione credo che sia ben riassunto il significato stesso della poesia. Sebbene il suo etimo abbia a che vedere con un processo creativo, vale a dire con un’attitudine dell’uomo volta all’ottenimento di un qualcosa, il prodotto della creazione, ben sappiamo quanto la vera poesia non sia altro che la rivelazione di uno stato emotivo che promana dalle lettere in maniera sorgiva, istintiva, priva di filtri, sistemi di manipolazione o quant’altro. Basterebbero alcuni grandi geni della poesia italiana come Leopardi, ma anche il ligure Montale, a ricordarci come la poesia nasca da una serie variopinta di circostanze e condizioni particolarissime (soggettive s’intende, mai universali, sennò si tratterebbe di una scienza in qualche modo “esatta”) dove spesso si ritrova la solitudine del poeta. È una solitudine che non ha un’accezione istintivamente marcata con un segno negativo, tutt’altro, come pure Wislawa Syzmborska, Premio Nobel per la Letteratura nel 1996 ebbe a sostenere: silenzio e solitudine sono le variabili – se non imprescindibili – senz’altro cruciali e nevralgiche affinché il poeta possa sentirsi a suo agio e respirare con tranquillità, dar libero sfogo, senza condizionamenti, al fluire del suo sentimento interiore. La ragazza che, di spalle, è dipinta in copertina in un’opera della pittrice Cinzia Romano La Duca, mentre assiste a un meraviglioso tramonto, non è forse felice, completa, rassicurata e in pace con se stessa, pur essendo sola e lontana da ogni altra persona? Io credo di sì. Myriam De Luca ben mette in luce questa idea con la sua prima raccolta di versi dove l’aspetto dell’“isolamento” si associa a quello dello spazio creativo, dell’urgenza di ascolto interiore e di lontananza dal caos ma anche e soprattutto con una funzione “urlata” atta a incentivare un discorso perentorio, semmai dialogico, imperniato sull’esortazione. Ricorrendo all’etimo di quest’ultima parola, essa rimanda a un temperamento vigoroso di chi incoraggia, sostiene, perora, conforta, interviene in una causa e, più in generale, chi intima l’altro, inveisce, spinge a far fare, consigliando o inducendo a una scelta, a un comportamento. In ciò si evidenzia – come Sandra Vita Guddo espone nella prefazione – l’importante componente etico-civile della poesia di Myriam De Luca che meglio si localizza proprio in questa prima raccolta.
Le tematiche che riaffiorano nelle poesie di questa silloge – inframmezzate da pittoresche foto di Emiliano Milanesi – sono varie a cominciare da uno dei problemi endemici della terra di Sicilia, la mafia, a cui è indirizzata la poesia che apre il volume. Il sottotitolo contiene la dedica al magistrato Falcone, eroe della giustizia sociale. Qui leggiamo “Certo che ce ne sono volute / di stragi e di uomini morti / per svegliare il tacito torpore / di una terra che profuma / di mare e di lupare” (13), si percepisce in questa condanna intrisa di dolore e di fastidio accecante l’insegnamento dell’intellettuale Leonardo Sciascia che tanto scrisse sul fenomeno, tanto in forma di fiction che di giornalismo, da ricevere la definizione di mafiologo. Myriam De Luca con questo testo inclemente ben descrive il binario di sangue che l’organizzazione malavitosa ha prodotto e continua a mietere sotto gli emblemi di una moralità che – come dice – è “ingannevole” (13) e di una depravazione che è – sempre usando sue parole – “mascherata” (13). Si entra in questo libro in punta di piedi con la consapevolezza di trovarsi dinanzi alle fascinose coste siciliane e il dolce odore di zagare quali orpelli modernisti di una terra che per troppo ha vissuto nel dramma, vedendo impastare il sangue con i giorni, il tritolo con l’aria.
Attenzione viene posta su altri drammi contemporanei come l’esodo di profughi dalle coste del Maghreb e dall’Asia nel tumulto delle guerre verso la Vecchia Europa, bacino di ricchezze, sede di illuminanti e storiche università e culla di diffuse indifferenze, razzismo e di odi che s’alimentano nel disprezzo e nella bieca ignoranza. La poetessa parla di queste povere vite descrivendole come esseri fugaci, in balia di un vento che le trasporta: sono “vite sospese” (15) e il loro futuro è “agonizzante” (15). Molte di essi – come la cronaca ci ha insegnato – non raggiungono le nostre coste e, lasciata la propria terra in guerra e in stato di gran trambusto, non metteranno più piede sulla terraferma. La condizione degli immigrati e degli esuli, metamorfizzata dal gabbiano che lambisce coste e non abita in maniera stanziale nessuno spicchio di terra, si ritrova anche in una breve lirica dove il senso di spiazzamento e di disorientamento del singolo diviene emblema di una nave in avaria, in apparenza incapace a un possibile abbordaggio: “In questo braccio di mare / attracco l’anima esule” (41).
Da donna particolarmente sensibile al sociale non poteva mancare uno sguardo smagato dinanzi a uno dei più biechi fenomeni che addensano le cronache giornaliere, quello dei casi di femminicidio e di violenza domestica. In “La violenza non è mai amore”, dopo – immaginiamo – a un alterco scomposto ha fatto seguito l’adozione della forza e l’uomo ha dato sfoggio della sua ferina cattività la Nostra così scrive: “tu, gonfia e livida, / rimani stretta in quell’angolo / nella sconfitta di un amore malato” (58).
Ogni persona è testimone del suo tempo ed è giusto che rifletta sugli accadimenti sociali che, in quanto tali, riguardano tutti. Pur mettendo in scena nelle sue liriche alcune delle bassezze dell’uomo incivile, misogino e xenofobo, Myriam De Luca nelle sue esortazioni in versi non fa parte della schiera di coloro che condannano senza se e senza ma, di coloro che, asettici a vedute altrui, si barricano dietro ossuti proclami ideologici. La sua, infatti, non ha i tratti di una poetica che istilla la tragedia, enuclea l’assassinio e la turpitudine dell’uomo, per crearne un bozzetto, semmai fa riaffiorare l’esigenza del buono, la necessità d’ascolto, imprime l’urgenza di un ravvedimento e di una conversione dei cuori. Se non certa – come nessuno di noi, dopo tutto – in una futura età di bontà e di concordia, in termini assoluti e universali, è alquanto propensa e fautrice di un’idea di buono che va coltivato e promosso: “Il mondo sembra deserto / senza il profumo della speranza” (73). Nel dire questo la Poetessa simultaneamente è come se gettasse un piccolo seme nel campo infinito che è il mondo. Esso, pur alle intemperie, nascerà e darà i suoi frutti. Ma affinché l’intero campo sia produttivo e la malattia non infesti quella messe, in molti (tutti sarebbe mera utopia) dovranno fare qualcosa d’analogo: tanto con le parole che con il fare, ma sempre mossi da reale intenzione e partecipazione al contesto collettivo. Questo perché non posso pensare al mio unico bene se non vi è un bene corale. La società è scossa da folate che la sottopongono a “equilibri sospesi / sull’altalena della paura” (86) come si legge nella poesia “Il canto in mezzo al mare”. Tutto è corroso da un senso d’inatteso e di progressiva consunzione dove l’ipocrisia diffusa e l’incomunicabilità aggravano una situazione caotica e invivibile. “La sostanza della felicità” dice la Nostra “invade distese solitarie / lasciate in silenzi intatti” (87).
La città[1] è uno spazio rumoroso e indistinto[2], la Nostra la descrive dominata da un “dissacrante affanno” nella poesia “L’isola che non c’è” (27). Si preferisce guardare alla natura con particolare attenzione al mare che domina il contesto del capoluogo siciliano e al quale è dedicato una lirica dove la Nostra annota l’enigmatica presenza di “un gabbiano [che] strilla più di me” (29), finanche la rassicurante e sempre benevola presenza di erbe aromatiche: “Respiri il profumo del timo selvatico” (21) in “Sataredda”, medesimo aroma che aleggia in “L’isola che c’è” (27). Se la città è ambiente di confusione e di mancata concordia, ancor più lo è la politica che a differenza del bene pubblico quale impegno primario sembra demandare i suoi interventi ad altro e disattendere i bisogni collettivi; la Nostra parla di un “futuro incerto” (30) che è senz’altro quello in cui viviamo, nella “sterilità / del nostro tempo” (38) dove l’incertezza e il timore generalizzato non si stemperano nel mezzo di quei fitti “nuvoli di polvere” (30).
Tra i temi che più ricorrono vi sono quelli dell’ipocrisia nelle vesti della maschera, della bugia, della finzione, c’è anche il tema capostipite del silenzio e con esso la solitudine (tra di essi, spesso, s’impernia anche quello dell’inascolto, della distanza e dell’incomprensione[3]), il raccoglimento, la propensione alla riflessione, l’interrogazione intima, il passato difficile, l’anoressia (“Il pane ha la forma della paura / e la carne dei mostri”, 33), la lontananza e il saper attendere (“Da domani imparerò ad amare l’attesa / purché tu non tradisca / la nostra promessa urlata”, 37). Colpisce anche l’attenzione che vien posta sul difficile rapporto – divario ampio e impraticabile – tra il mondo reale e quello fatto di illusioni e di votate utopie: “Sotto lo sguardo di un Dio misterioso / si muove l’umanità / infestata da folle deliranti / a cui è concesso sfamarsi / di succinte illusioni / che chiamano realtà” (48) nella poesia “Cogito Ergo Sum”. Persa la misura del senso (e dunque della ragione) e venendo a mancare il briciolo dell’autocoscienza che consentirebbe di concretizzare il vissuto, la deriva in un periglioso e indistinto caos diviene una minaccia urgente. L’esigenza della verità, del narrato onesto, della supremazia del senso al gesto, della parola al silenzio è evidente: la poetessa procede nel suo percorso dove, seppure gli ostacoli sono presenti e le zone ombrose non mancano, mai viene meno la necessità di credere al senso ragionato, al sensibile e virtuoso: “Fiutai inganni e rifiutai compromessi” (52) scrive in “Verità”.
Dai contenuti meno civili appare l’altra raccolta poetica, L’invisibile nutrimento (2020) prefata mirabilmente dal professor Tommaso Romano che, nell’intento di avvicinarsi alla poesia della De Luca, sostiene che essa “cerca gnosticamente la luce” (7). Numerosi i versi qui raccolti che possono definirsi pregevoli e degni di attenzione ermeneutica. Si conserva quello stile proprio dell’autrice, pulito, accessibile, fatto di parole che scantonano ambiti desueti o terminologie tecniche, per andare all’essenza delle cose. La sua poesia – questo invisibile nutrimento – nella recente silloge fa risaltare ancor con più foga di quanto non apparisse a una prima lettura nella precedente raccolta il suo temperamento solare, la sua orgogliosa pace interiore, la capacità rara eppure così preziosa di sapersi rileggere nel trascorrere dei tempi, di dialogare con gli spazi, di osservare nelle profondità dell’uomo, di cogliere le potenzialità e gli elementi di rilancio dell’umana presenza. La condizione di isolamento vissuta giammai quale rassegnazione ma con felice accoglimento di uno spazio intimo si ritrova in “Fluttua l’anima” dove leggiamo: “Non è più offuscato il confine / che si apre limpido davanti alla luce. / Percorro la via solitaria del cambiamento / balsamo per le mie speranze / medicina per le mie incertezze. / Una beata tranquillità” (12).
Passato e presente s’interfacciano nelle due poesie (rispettivamente “La casa dell’infanzia” e “Futuro”) che alle pagine 16-17 si trovano “confinanti”, riflettendosi tra loro. Particolarmente suasivo e carico di delicatezza il ricordo: “Torno alla casa della mia infanzia / passa l’anima / […] / Radunati davanti a me i ricordi / aprono gli occhi con la tessa dolcezza. / […] / Li ritrovo tutti / nello stesso posto dove li ho lasciati” (16).
Molto suggestive alcune immagini che, in versi brevi e dall’immaginario non comune, contraddistinguono alcune liriche: “rubo forme al mondo” (da “Notte di foschia”, 20) e “Ascolto il linguaggio inedito / del cielo / l’indicibile saggezza / della sua sostanza” (da Essere”, 21) che testimoniano questo continuativo e recondito tentativo di dialogo con un’entità assoluta. Il cielo nelle veste di interrogante, di destinatario di appelli, ha per la Nostra una sostanza che è ben palpabile, una sorta di manto avvolgente che rassicura e permea dagli accadimenti degli uomini. È una poesia euritmica dove il sodalizio empatico che si crea è tra un non detto e la verbalità spesso stanca e stizzosa dell’ordinario, tra la (spesso) banale corporeità e un non visto, un assoluto onnipresente che sovrasta e al quale ci si appella. C’è concordia in questo dualismo metafisico nel quale la poetessa si inserisce quale presenza transeunte dotata di luce e di fede. Ecco perché anche l’inconcreto riesce ad avere una sua composizione materica, nei felici quanto imprevedibili riti metamorfici che l’uomo crea nella mente: “ho forato nuvole nere” sentenzia in chiusura della poesia “Dimentico tutto” (24) svelando l’esigenza di ridurre al minimo l’oscurità, di dileguarla, di raffinare il buono, finanche dalla corpuscolarità ariosa di una nube vagante.
Anche qui, seppur per brevi pennellate, si distinguono i tratti di una contemporaneità dove l’uomo non solo è disattento ma anche screanzato (“un mondo pieno di contraddizioni”, 15) ma anche vittima, tanto fisica che psicologica, delle sue stesse malefatte (“guardo il mondo / con un occhio aperto / e uno pestato, offeso, tumefatto”, 28) e al contempo responsabile per tanta iniquità e gesti di sopraffazione assai diffusi: “A passi leggeri cammino / sulla diversità complessa / dei suoi azzurri / sulla diversità difforme / delle forme / sulla diversità mutevole / delle ombre” (72-73). È una diversità che proviene da un mondo cangiante e mutevole, di forme e luci, ma è quella della marginalità e della discriminazione di sessi, religioni, etnie, di anziani, persone con handicap e tanto altro ancora.
Ritorna con nettezza anche l’universo semantico dell’ipocrisia e con esso dell’impostura, della devianza, del dubbio che logora, della menzogna e del tradimento, occasioni di disagio che possono minare la solidità e la concordia della coppia, distanziare persone, alimentare rancori e incomprensioni. In questo nuovo percorso poetico della Nostra si ritrovano anche i motivi della memoria, il ricorso a pillole del tempo andato, finanche la riflessione sulla labile condizione di felicità. Il gabbiano e l’immagine delle ali testimoniano ancora quella situazione in balia di vento ed onde, di sospensione e incertezza, di difficoltà di approdo e ancoraggio dinanzi ai marosi dell’esistenza. Del tempo passato risalta senz’altro la poesia “Adolescenza negata” che ha un retroterra di angoscia esistenziale per la difficoltà di quel periodo di cui si ha traccia, pur con l’artifizio della narrazione, nella protagonista del romanzo della De Luca. Nella poesia leggiamo: “è così diversa la me reale / […] / Vorrei accarezzarmi di più ogni tanto / e tornare sulle strade / della mia adolescenza / dove sono rimasta come un uccellino / dentro una scatola di cartone” (46).
Com’era accaduto per Esortazioni solitarie mi piace chiudere queste riflessioni sulla poesia della De Luca con un’immagine positiva, di forte energia e dotata della luminosità che la caratterizza quale persona sensibile e concreta, passionale e attenta al mondo: “Ho attraversato intensità / che senza il dolore / non avrei mai riconosciuto / Mi sono persa in parole / non capite / e ritrovata dentro il gioco / di una speranza / Ho amato le attese” (67). Dal tono lievemente evangelico questi versi consegnano al lettore un insegnamento di fede nell’altro e di resilienza, infondono autostima e, nella rinata consapevolezza che la “prova” e l’“ostacolo” spesso impone, danno forza a quel percorso intimo di congetture, riflessioni e sguardi lucidi sul mondo che si realizza, irrefrenabile e non visto, nel “rumore dei miei pensieri”.
Lorenzo Spurio
[1] Bella la poesia dedicata alla sua città pubblicata in L’invisibile nutrimento dove si parla di una terra ricca di sapienza e dotata di grande fascino: “Intrecci di geni contaminati / si mescolano / tra il vociare dei mercati / Sui selciati luccicanti / vende al sacro e al profano / la sua bellezza scalcinata” (18).
[2] Questa idea, unita all’esigenza di un ritorno alla natura è ben espressa anche nella poesia “Lontano dalla città” che fa parte della nuova raccolta L’invisibile nutrimento dove è possibile leggere: “Ho imparato a escludermi / dal fracasso del mondo / a cavalcare la sagoma / delle montagne” (58).
[3] Ad essa è dedicata l’omonima poesia dove possiamo leggere: “È debilitante l’incomprensione / con chi ama / […] / C’è un errore da qualche parte / un errore…” (43).