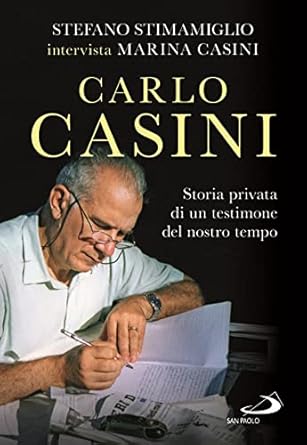XIV Capitolo - "La mia vita" di Antonio Saccà
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 03 Gennaio 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 855

L’ho già detto, amavamo la musica, io, mio fratello e mia sorella maggiore Caterina, mia sorella Ermanna non cantava parlava minimamente, già il respiro che la stancava, rimaneva seduta, priva di movimenti, i grandi occhi castani chiari, i capelli lievissimi che le carezzavano le guance, non mi stancherò di parlarne, di scriverne, di ricordarla. Caterina invece cantava da soprano ed anche mio fratello Francesco, da tenore. Io ero timidissimo con una passione perenne verso i cantanti del tempo, Achille Togliani, Nilla Pizzi, il Quartetto Cetra, Luciano Tajoli, Giorgio Consolini, ne cito soltanto taluni, con qualche incertezza sulle date, ascoltavo anche le canzoni di guerra e l’ultimissima esistenza del fascismo, canzoni belliche e canzoni anche di felicità per la vita in campagna, i due aspetti della politica di allora. In casa avevamo dei dischi pesantissimi da 78 giri, ricordo qualche titolo: “Bella, venditrice di banane gialle”, “Pellegrino che vieni a Roma da lontano” e poi, come accennavo, l’esaltazione della campagna: “Se vuoi goder la vita vieni quaggiù in campagna”. Quando nel 1943 finì la guerra in Sicilia apparvero quei cantanti che ho nominato. E la passione per quegli interpreti che durò fino ai miei 11-12 anni. Un pomeriggio, mentre ero sul letto in una giornata soleggiatissima, ascolto dalla radio suoni che non avevano nulla a che vedere con le canzoni, suoni continuativi senza parole, musica e soltanto musica, rimango impietrito per la novità, una musica che non avevo mai ascoltato, sembrava un fiume di suoni animatissimo di strumenti, un mare sconfinato di onde, un cielo universale di stelle, e soprattutto gettava una serenità felice di suoni armoniosi e motivi ondulati l’uno diverso dall’altro o che si riprendevano. Ascoltai con una immedesimazione enormemente accresciuta rispetto alle canzoncine, era una musica che entrava nel sangue, nelle vene, nei polmoni, nella mente, accresceva, brancolavo, cercavo di capire quel che succedeva, un’irradiazione, ansiosissimo di chi aveva messo al mondo quella meraviglia, e infine lo dissero, un brano: “La moldava” di una composizione più ampia Mà vlast “La mia Patria” di un autore straniero, Bedřich Smetana. Fu la prima conoscenza momentanea e fuggitiva di un mondo nascosto o a me sconosciuto. Quando fui adolescente quindicenne e mi iscrissi al Collegio Sant’Ignazio ebbi modo frequentissimo di recarmi nell’abitazione del mio compagno di studi Giuseppe Russotti, abitava a qualche palazzo da casa mia, il padre era un imprenditore, appaltatore si diceva, insieme al fratello arricchì immensamente con la ricostruzione del Paese. Avevano in casa tutte le comodità ed i mezzi più recenti e tra questi radio, grammofoni, dischi, in quanto la sorella di Giuseppe Russotti amava la musica classica. Un giorno Giuseppe che ovviemente chiamavo Pippo mise in ascolto un disco; appena il disco cominciò a girare ed il suono a farsi ascoltare, avvenne in modo accentuatissimo quel che era avvenuto anni prima nella mia stanzetta. Fu un incontro. Si trattava della Sesta Sinfonia “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, io non ne sapevo ma l’apertura d’inizio era come effettivamente vedere, sentire, vivere la natura del sole, del verde, la cantabilità del motivo, la felicità di esistere nel luogo dove si esisteva, come un passeggiare nella natura felici di essere vivi, ma non una felicità eccessiva come sarà nella Nona Sinfonia, non gioia ma felicità, erba, fiori, cielo, colline, fiumi, ma al di là di tutto questo che era fonte di ispirazione il piacere del suono . Non soltanto rimasi impressionatissimo ma percepii che la musica diceva qualcosa, che il suono, il motivo parlavano ossia un modo di esprimere senza parole ciò che la parola era inadeguata ad esprimere o in ogni caso non inferiore, tutt’altro, alla parola. La musica esprimeva, parlava, diceva, arricchiva. Successivamente, sempre dal mio amico e sempre ponendo in ascolto dei dischi, tutt’altra musica e questa musica era cantata, la parola in musica, una voce gradevolissima quella che si chiama “aria”. Sul disco vi era stampato un grammofono con altoparlante e un cane vicino, i dischi famosi dell’epoca :“La voce del padrone”. Appresi dopo che si trattava di un 'aria di Giacomo Puccini se ben ricordo cantata da Beniamino Gigli in modo così spontaneamente espresso che senza raggiungere la superiorità sonora del brano della Sesta Sinfonia però gradevolissima all’ascolto, più che armonia melodia. E qui torno a me stesso e può sembrare stravagante quel che scrivo: per tutta la vita futura ho insegnato e ho scritto ed ho amato insegnare ed ho amato scrivere, ma se dovessi rientrare in me stesso e dire chi effettivamente io potevo e dovevo essere affermo con certezza che era la musica la mia passione e insieme alla musica il canto. Lasciato senza controllo, per così dire, io canterei e suonerei e non farei altro, se mi abbandonavo a questa disposizione perdevo la parola, in un certo qual modo perdevo la mente, mi sorgeva soltanto musica, la mia mente era totalmente presa dalla musica, un dominio invadente, prepotente, insostenibile. Un fenomeno che hanno avuto altre persone, suppongo , ed è pericolosissimo, assorbe senza la parola, ripeto. Se mi abbandonavo alla musica per la mia mente esisteva solo la musica. Mi terrorizzai. E la mente per salvarsi compì un’evoluzione, spostò lievissimamente il cervello. Lo sentii e mi permise di frenare la prepotenza dell’afflusso musicale, non perdendolo se non come prepotenza. E mantenendo una situazione che è felicemente patologica, non so vivere senza musica. Scrivo, leggo, sempre accompagnato dalla musica, o fuori di me, o dentro di me. Spero che questo non significhi che ho sbagliato vita, che dovevo invece dedicarmi soltanto alla musica e al canto, sarei stato obbligato, schiavo. Comunque le cose sono andate come sono andate. Resta il fatto che la musica è una terapia, è un conforto all’amore della vita, ciascuno ovviamente ha il suo rimedio salutare, io ho la musica; se mi distacco dal piacere della musica vuol dire che non voglio continuare a vivere. Quando tanti anni dopo fui alla porta dell’aldilà appena ripresi coscienza dopo settimane di cecità mentale fu la musica che mi riportò nella terra dei vivi. In quegli anni in cui ciascuno forma sé stesso incontrai la musica ed incontrai anche i libri passando dall’era dei fumetti all’era dei romanzi.
Dei professori o degli insegnanti di scuole medie ed elementari mi rimane impresso ciò che ho scritto nei capitoli precedenti, aggiungo il Preside della scuola media, in quanto padre di uno studente compagno di classe che ritroverò anche dopo la scuola media. Ma è il liceo che entra nella mia vita come una scultura. L'ho detto, ero felice, contento per i docenti, ma soprattutto per i compagni. Non c'è momento socializzato che superi quello scolastico, lo paragonerei agli eserciti, specie in tempo di guerra, sotto certi aspetti ai carcerati, in ogni caso raggiunge l'estremo della vita in comune; l'università non ha la stessa intensità. Luoghi identici, giornalieri, vengono ripetuti e oltretutto e soprattutto la spontaneità fanciullesca, adolescenziale, che poi si perde anche se si raggiungono altre modalità. Nessun fastidio a svegliarmi presto, nessun fastidio ad andare a piedi per dieci, quindici minuti da casa mia al Ponte Americano fino a Piazza Cairoli. Mi veniva a prendere Giuseppe Russotti, che abitava in una palazzina più giù dalla mia. Raggiungevamo Piazza Cairoli e la chiesa di stile neogotico che si estendeva nel collegio Sant'Ignazio. Un ingresso lungo la piazza alberatissima, uccelli che cantavano credo anche di notte, un famosissimo, almeno per il luogo, ristoratore, Irrera, dove ci saremmo incontrati per anni. L’ingresso del collegio aveva scale biforcute, un primo piano con le aule e un piano superiore. Non so se ho buona memoria nel segnalare anche un piano ulteriore, non credo, al secondo piano vi era il rettorato, enorme stanzone, elegantissimo, pulitissimo, ordinatissimo, accostato ad una chiesetta minima, bianchissima, splendeva al sole i suoi marmi e le coperture trinate, usata specialmente a maggio per la devozione mariana. Le aule stavano al primo piano, giù invece dopo l'ingresso il cortile affiancato dalle arcate, lateralmente a destra degli stanzoni per stare insieme e giocare. Il gioco fondamentale era il ping pong. Le lezioni cominciavano alle 8.30, alle 11 vi era un'interruzione, un quarto d'ora per il Rosario e un quarto d'ora per la colazione che si svolgeva nel cortile. Io ero celebrato e invidiato, ma anche perseguitato e inseguito per le mie frittate d'uova, in quanto mia madre, che mi sapeva magro, mi vedeva magro, credeva di salvarmi con le uova e le banane; il che mi rendeva 'appetito' dai miei compagni, i quali si ritenevano miei creditori e si avvicinavano con moti furtivi strappando qualche pezzone. Era comunque un gioco vicendevole, io tiravo la mortadella di un altro, quello il salame, il formaggio, insomma ci divertivamo. Ma il il divertimento culminante avveniva durante il Rosario e la declaratoria delle qualità della Santa Vergine, una recitazione turpiloquiale, insinuavamo pessime qualità alla madre di Gesù, dandoci di gomito e contenendo a stento il riso, che serpeggiava comunque. Non eravamo né blasfemi né volgari, eravamo soltanto ragazzi e la serietà accentuata di qualche sacerdote non sempre ci convinceva. Il peggio comunque accadeva nel confessionale, dove attribuivamo peccati che non avevamo commesso, con l'incredulità dei sacerdoti che ci conoscevano. Il peggio del peggio quando attribuivamo i peccati ai compagni e li rendevamo punibili di tante preghiere che venivano amministrate con grande stupore dei (non) peccatori.Il Collegio S. Ignazio non ospitava gli studenti ma la vita associata era estesa e fitta sia nei rapporti tra studenti e docenti, sia nei rapporti tra gli studenti. Il fondamento di questi rapporti era il gioco che si riduceva alla pallavolo e al ping pong. Concludevamo le lezioni verso le ore 13:00 a meno che non fossimo puniti con una sosta di qualche ora, di qualche mezz’ora in un corridoio per qualche fastidio che avevamo suscitato, ritardi, chiasso. Tornavamo a casa, pranzavamo, talvolta ci riunivamo per studiare in gruppetti minimi, quindi l’immensa, amatissima restaurazione degli incontri al Collegio. Dove, appunto, giocavamo. Il ping pong era il passatempo eletto e nel tempo avevamo qualche abilità. Ferdinando Salleo si distingueva per una “bruciata” mancina che era impossibile frenare; Giuseppe Russotti rapidissimo nei movimenti e riusciva a respingere gli attacchi; io invece avevo un gioco di rimessa che finiva con il suscitare errore negli avversari. Gli incontri o singolari o due da un lato e due dall’altro, animatissimi ed animosissimi, proprio la vita, l’espansione della vitalità, l’adolescenza sana, in salute. Tra noi evidentemente vi erano delle amicizie più accentuate, i gesuiti avevano studenti di rango sociale sopra la media, quando non so in quale occasione ci recammo a visitare il Collegio dei salesiani, sempre a Messina, esisteva una caduta di rango tra i gesuiti e i salesiani. Compagni amici fummo pochi anche se non vi erano esclusioni e l’amicizia fu intensissima, dire fraterna è dire appropriatamente, Ferdinando Salleo, Giuseppe Russotti ed io. Vi erano anche compagni che non propriamente con la stessa quotidianità partecipavano al sodalizio, Luigi Cardillo, Stefano Reitano, Preitano, spero che i cognomi siano esatti. Ferdinando Salleo era un aristocratico, sia da parte di padre sia da parte di madre,
anche l’aspetto aristocratico, pelle rosea, un’aria di limpidezza, di lucentezza, di pulizia corporea irradiante, esiste un corpo aristocratico dopo generazioni di una vita distinta, privilegiata. Aveva gli occhi azzurri ed i capelli rossicci, di media altezza alquanto sopra la media, consistente di fisico, il padre più alto di lui e la madre invece piuttosto piccola, la madre era una d’Alcontres, famiglia aristocraticissima della Sicilia, e sorella della consorte di Gaetano Martino, ministro, rettore dell’Università, fisiologo. Ferdinando aveva relazioni di tale qualità, e diverrà per suo merito, sia chiaro, Ambasciatore d’Italia a Washington e a Mosca. Ne scriverò ancora, fu e resta l’amico più durevole della mia vita. Giuseppe Russotti sostituì letteralmente mio fratello. Ci vedevamo ogni momento che era possibile vederci, la mattina passava per andare insieme a scuola, tornavamo insieme dalla scuola, ci rivedevamo per tornare a scuola ed insieme la sera rientravamo a casa.
Eravamo amicissimi. I docenti del Collegio S. Ignazio li ricordo come se fossero statue viventi. Innanzitutto il professor Castorina, un docente anziano dalle orecchie elefantine che gli ciondolavano lungo le guance, occhiali, ed un volto malinconicissimo. Pare che avesse drammi familiari, un figlio mal sortito, forse demente, questo l’aveva fiaccato e reso buonissimo, tollerante, idoneo a sopportare più che a contrastare. Noi del dolore altrui non sapevamo il costo, gli suscitavamo una particolarissima situazione, al gesto di qualcuno avanzavamo i banchi che erano enormi fin sotto la cattedra, il professor Castorina di solito stava a leggere e ogni tanto sollevava gli occhi verso di noi e di botto si vedeva gli studenti prossimi ed allora gli sorgeva un sorriso mesto e dolce di sopportazione tra il divertito e l’afflitto, quasi a farci capire che egli comprendeva la nostra voglia di scherzare, di schernirlo forse, però in modo non cattivo né da parte nostra né da parte sua e paternamente ci assolveva. Una volta ci assegnò un tema sulla vita di Dante Alighieri riferendo una notazione di Nicolò Tommaseo, il quale affermava che Dante in qualche modo venne favorito dalle sue disgrazie, esilio, ecc, nel comporre il suo poema. Io scrivevo che nella vita ci sono tante e tali disgrazie che non v’era bisogno di disgrazie specifiche per ispirarsi, bastava la vita com’era per chiunque. Il professor Castorina apprezzò moltissimo questa considerazione e mi approvò con il sette. Anzi mi invitò a leggere in classe il compito. Io, come ho detto e ripeto, ero timidissimo e leggere in classe mi sembrava esibirmi, vantarmi, sicché lessi maldestramente, ancora una volta il professor Castorina capì il mio imbarazzo e gli venne un sorriso minimo così paterno e comprensivo che mostrava come il dolore che egli viveva lo aveva reso quella memorabile persona che ora ho voluto e sentito di ricordare. La perla dell’istituto come docente era Francesco Prestipino, quello che si dice comunemente un bell’uomo, alto, elegante, impettito, sicuro, bella voce, veniva considerato coltissimo e in realtà aveva una fluenza espositiva che si faceva seguire e attraeva. Questo professor Prestipino veniva sottolineato anche per un fatto esterno alla scuola, una sorella di tali esplosioni carnali da rendere eventuale uno scoppio degli abiti, i seni prepotentissimi, il fondoschiena esplosivo, i fianchi che forzavano l’abito, le gambe solidissime ed ogni movimento accentuava ora i seni, ora il fondoschiena, ora le gambe, in maniera così dinamica che da un momento all’altro pareva che qualcosa si lacerasse, che gli abiti non riuscivano a contenerla, di capelli scurissima e frondosa. Ebbene questa signorina era fidanzata col più malmesso maschio della specie, il volto deturpato da una bruciatura, il colorito sporco, una figura da nulla e poiché l’evento era troppo scoperto per non parlarne anche in classe, oltretutto col professor Prestipino avevamo rapporti cordiali spesso anche di pomeriggio, il Prestipino ci diceva che quest’uomo trattava malissimo la sorella la quale gli obbidiva ossequiandolo. Non so quanto fosse reale l’affermazione ma di sicuro quest’accoppiamento era sbalorditivo e costituiva ragione di umorismo tra di noi ma anche, devo dire, dello stesso professor Prestipino. Colui che segnava la scuola, l’istituto, era il docente di filosofia, Salvatore Scimè. Veniva dalla Sicilia interna, Racalbuto, ma sembrava venire dalla foresta. Uno scimpanzè o, meglio ancora, un gorilla di piccole proporzioni, aveva tutto del gorilla tranne i peli, un gorilla rasato ma la muscolatura era quella dei gorilla e se ne vedevano i rigonfi sotto l’abito talare. Era piccolo e noi spigavamo di altezza, egli ci afferrava le orecchie e ce le strizzava in giù e ripeteva una frase ossessiva, ” fatti santo”. Questo padre Scimè aveva aspirazioni culturali, teoriche e si proclamava agostiniano, il che per un gesuita antitetico. Vi era nell’istituto un altro docente di filosofia, padre Palermo, il quale invece coerentemente era tomista. Talvolta nel salone del Collegio, si battevano. Di questo Scimè ricordo la spiegazione del filosofo Hegel, egli accanto alla lavagna si mise a fare dei cerchi e dentro scrisse “idea, natura, spirito!” e chiuse il cerchio e nell’altro cerchio, “essere, non essere, divenire” e chiuse il cerchio. Avevamo come testo la storia della filosofia il cui autore era Barcellona, rammento questa frase: “lo spirocheta pallido gli mangiava il cervello”, si riferiva a Friedrich Nietsche. Più o meno, l’andamento degli studi filosofici. Questo padre Scimè aveva ambizioni di docente universitario e scrisse un libro per concorrere, senza riuscirvi, almeno nel periodo in cui io studiavo ai gesuiti. Alla catastrofe filosofica aggiungo l’esame di maturità per segnare la babilonia che uno studente può vivere. Il docente esterno che mi esaminava si era incapricciato nel sostenere che Giambattista Vico somigliava a Cartesio. E padre Scimè ne diceva giustamente scandalizzato. Quando fui esaminato il docente mi fece la domanda a chi io avrei assomigliato Giambattista Vico ed io spudoratamente dissi “a Renato Cartesio”. Il docente ne fu tanto confortato da pormi otto o nove nel voto di filosofia, padre Scimè mi guardava con rabbiosa insofferenza anche se era felice dell’evento. Quando ci recavamo a scuola camminavamo per il viale San Martino che con via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro è la strada più importante della città. A qualche centinaio di metri da casa mia andando con Giuseppe Russotti un mattino mi accorsi di uno sguardo, sollevai gli occhi ed era una fanciulla di gradevolissimo aspetto, bianca, limpida, capelli nerissimi, che mi guardava. Io la guardai e lei resse lo sguardo per tutto il momento del passaggio, lo stesso accadde al ritorno. Per tre anni ogni giorno io ero certo che sollevando lo sguardo avrei visto lo sguardo di quella ragazza e lei che ogni giorno io sarei passato a vedere il suo sguardo. Tre anni, tutto il liceo. Incredibilmente quando io fuggii da Messina e tornai dopo anni, qualche giorno passando per viale San Martino da solo e sollevando lo sguardo dove per tre anni avevo guardato, vi era la ragazza che (mi) guardava.