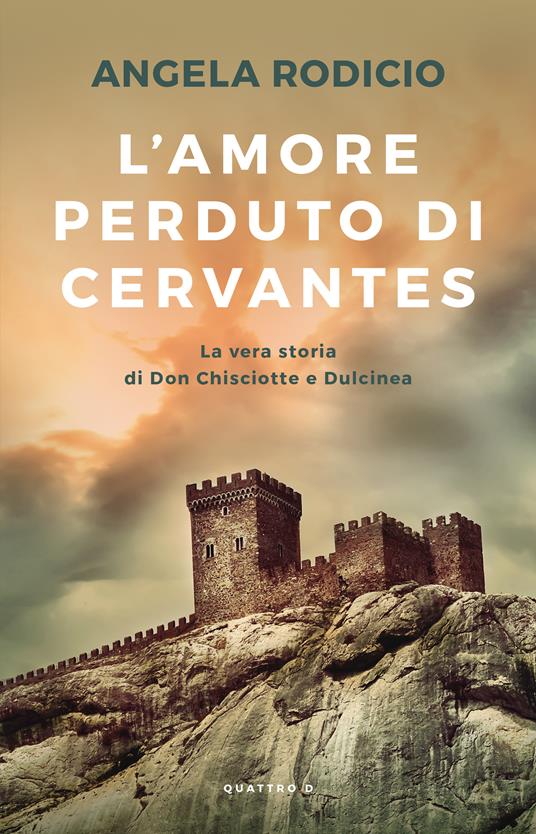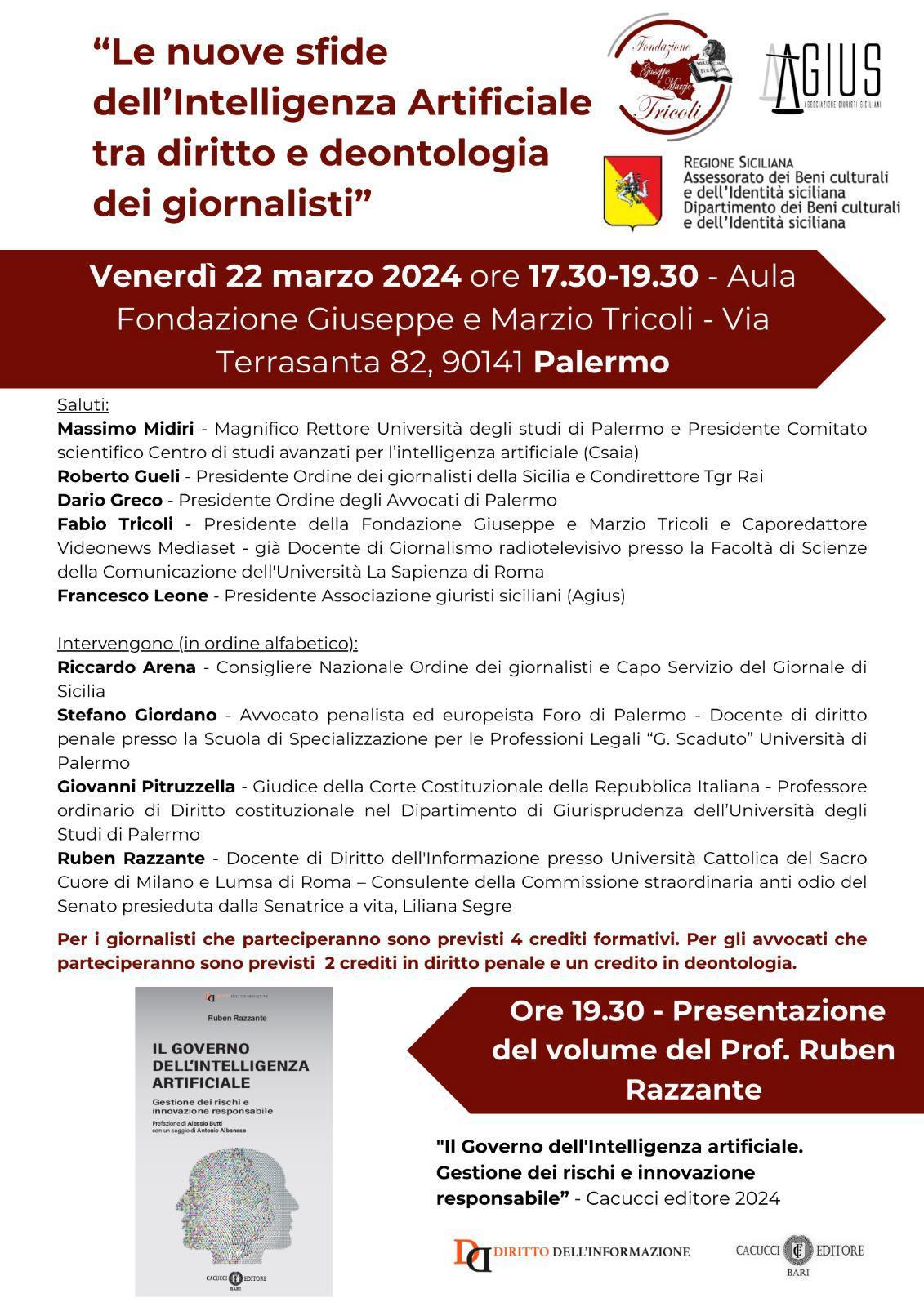Corrado Calabrò, "L’altro" (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 03 Dicembre 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2529
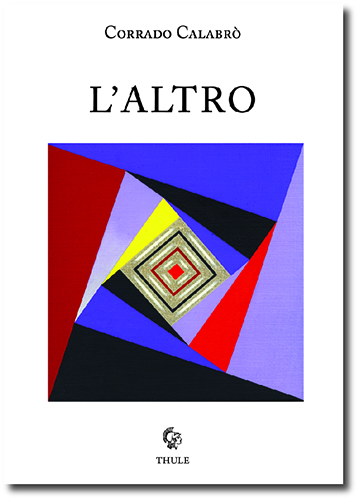 di Lorenzo Spurio
di Lorenzo Spurio
È uscita negli ultimi mesi una preziosa plaquette poetica di Corrado Calabrò che, appena un paio di anni fa, per Mondadori, ha pubblicato in un corposo volume una selezione di un cinquantennio di far poesia (Quinta dimensione, il titolo, opera presentata a Torino e a Roma nella magica location del Tempio di Adriano, ampiamente recensito, commentato con entusiasmo e plauso su riviste e in altri contesti). La nuova opera – in veste editoriale egregia e raffinata al contempo che si apre con un’opera di Enzo Tardia dal titolo “Equilibrio”, si compone di venticinque poesie per un totale di quaranta pagine in formato ridotto, facilmente consultabile e pratico.
Non prefazioni, commenti critici, note di lettura, elementi para-testuali; il lettore è immediatamente catapultato all’interno del breve eppure assai notevole sentiero che Calabrò – poeta di lungo corso con vari riconoscimenti di livello internazionale – ci propone. Vi troviamo alcune poesie già note perché apparse in precedenti raccolte – mi riferisco a quelle che riportano la data di 2000 o 2002 – e in particolare un estratto del geniale poemetto Roaming (che ho avuto modo di commentare in precedenza) e del quale anche il critico Fabia Baldi ha fornito una lettura attenta e perspicace in L’altrove nella poetica di Calabrò (Aracne, 2019), un voluminoso saggio sull’opera di Calabrò.
Vi sono poi vari testi recentissimi, scritti negli ultimi anni (il più recente è di appena qualche mese fa, settembre 2020) dove distintamente s’imprimono in maniera visiva alcune immagini come preponderanti. Il tema cardine è sempre quello dell’amore – della donna che accompagna l’uomo, scorta e ricercata di nascosto, amata, ma anche percepita distante e, in quanto tale, viva in un sentimento d’assenza («una dolenzia intermittente /mi fa sentire che qualcuno manca», 23); c’è anche il passato – nella figura della madre, sempre molto importante – e di momenti vissuti in un tempo che ormai appare così distante. L’elemento dominante è senz’altro l’acqua: quella del mare dell’infanzia, della passione delle pesca, della cultura marittima della regione natale ma anche nella forma di una pioggia ricorrente e martellante, fastidiosa e impertinente che, nella Capitale, dove Calabrò vive da molti anni, ritorna con puntualità a caratterizzare la dimensione metereologica (e umorale) di vari testi ivi proposti.
Pur nella forma breve della plaquette, si ritrovano con piacevolezza e un pizzico di stupore i temi fondanti e peculiari della poetica del Nostro, così distintiva e suasiva, che lo fa uno dei poeti più insigni del nostro panorama letterario odierno. A tutto questo – comprese le citazioni e i riferimenti a un universo in senso scientista che affascina da sempre Calabrò poeta dell’astrofisica – si aggiungono alcuni elementi quali l’immancabile influenza dell’ansia generalizzata dei tempi attuali dovuti alla pandemia in atto (in “Doppio cieco” sono presenti termini relativi ai lemmi di vaccino e immunità, così tanto comuni in questi giorni), le considerazioni sulla terza età e finanche vagheggiamenti che riguardano un futuro possibile che coinvolge la dipartita del reale (poesia “Se mai un giorno morrò” scritta nel 2000 ma anche la poesia “20 marzo” scritta, appunto, a marzo di quest’anno).
Nel corso delle liriche qui contenute (tra cui un haiku) non possono non richiamare l’attenzione i continui riferimenti che ricalcano un’idea di ciclicità del vivere, gli aspetti che trattano di un fluire, di un cambiamento che si compie nella maturazione; ciò avviene nella circostanza di un raffronto attento che s’instaura tra l’identità corporale e il sé della coscienza. C’è – nella pregevole plaquette edita da Thule di Palermo del prof. Tommaso Romano – una predisposizione all’ascolto verso un’alterità (il titolo del libro parla appunto de L’altro) che non è tanto da vedersi in uno scambio io-tu (sebbene, come si è detto, il rapporto amoroso, dunque tra gli amanti, sia centrale e importantissimo), piuttosto tra sé, tra le componenti del proprio recondito. Non sono, infatti, casuali – come mai nulla è nella poetica elegante e forbita del Nostro – l’immagine della cover di cui si diceva dove, un contorsionismo di quadrati con partiture di triangoli di vari colori dissonanti, crea un senso di vertigine e di spaesamento generale. Sembra di essere introiettati con forza all’interno – come risucchiati – e quasi contemporaneamente venirne sbalzati fuori – come una spirale che attanaglia e non si sa dove conduce. L’immagine, più affine a un cubofuturismo che a un cubismo puro, richiama quella frantumazione dell’identità e quel dinamismo che, proprio nel continuo divenire, ne descrive un movimento spasmodico che attrae e crea ripulsa.
Nella prima parte della plaquette vi sono liriche che si concretizzano attorno all’immagine-emblema-simbolo-metafora dello specchio che, nella letteratura di tutti i tempi, ha sempre rivestito grande importanza con i notissimi esiti tanto nella narrativa dell’autocoscienza, psicanalitica e la filmografia allucinata e distopica. Riporto, a tal riguardo, due estratti significativi di questa indagine io-altro dove l’elemento dello specchio, che da una parte dovrebbe fornire immagine perfetta e speculare del reale, non manca di creare fastidio, insicurezza finanche stordimento: «M’incontro appena sveglio nello specchio / ed allibisco / dinanzi a un altro volto che mi guarda. // Alieno, intruso, eppure lui mi guarda / in faccia con un’aria di sospetto. // Oh Dio! / E se foss’io un altro da me stesso?!» (7). Nella poesia “Dentro lo specchio” si legge: «C’era qualcosa / nel modo in cui sgusciavi / per cui sentii che non t’avrei raggiunta. / Ti guardavo, bloccato nello specchio, / e non cercavo neanche di capire. / Un uomo è incapsulato nel suo ruolo / come uno è chiuso dentro l’ascensore: / si guarda nello specchio solo a solo / e preme inutilmente sul bottone. / Né un attore può uscire dalla parte / finché non cala, alla fine, la tela / La donna può perché è un altro animale» (11). Non si dimentichi – pure – di un nonsense che aleggia, in chiusura dell’agevole volume, su una determinata lirica.
Già l’esergo – con una chiosa di Bertrand Russel – c’inserisce in questo universo fatto di doppi, di immagini e trasparenze, sembianze, ombre e duplicati quando, appunto, ci si riferisce a una supposta «somiglianza ai nostri [scopi]». L’aeriformità della citazione non è scevra da una capacità di sintesi invidiabile che in Calabrò si esemplifica spesso con la scelta arguta e specialissima di contenuti: se non esiste (o non dovrebbe esistere un’aristocrazia poetica, per lo meno non nel senso che l’etimo ci fornisce) credo che possa esistere quella delle citazioni. È un’arte originalissima e meditata, un affinamento progressivo delle grandi conoscenze acquisite, che in pochi riescono a porre con la giusta evidenza e valenza in apertura ai propri testi. Va in questa direzione la citazione del fisico americano premio Nobel nel 1979 Steven Weinberg («Più l’universo sembra comprensibile, più appare privo di scopo») anteposta al noto poemetto Roaming qui riproposto in forma di estratto. Si è detto – e ho contribuito io stesso con forza a rimarcarlo in vari scritti – che Calabrò è con viva probabilità il poeta che nell’attualità più ha saputo interfacciarsi con la scienza, tanto la quantistica che l’astrofisica e questo è rivelato anche dall’utilizzo di un determinato lessico, dalle chiose puntuali, assertive, frutto d’indagini, circospezioni della scienza. Calabrò – al quale l’Unione Astronomica Internazionale ha attribuito il suo nome a un asteroide scoperto nel 2018 – conduce il lettore, con un linguismo parco e al contempo variegato, seducente ed evocativo, non restio a esterofilismi e a soluzioni formali innovative, una conversazione che è poetica ma al contempo ontologica – dunque filosofica -, esistenziale, dunque umana, finanche scientifica, empirica, di continua interrogazione, raffronto, interfacciamento e perlustrazione. È un domandare che evita la retorica e l’astruso, la foschia di un linguaggio che potrebbe farsi ossuto ed ellittico e che, al contrario, incide nella profondità il cuore delle argomentazioni fatte, lette, che lo animano, lo coinvolgono. Le parole “universo”, “altro”, “stelle”, “luna”, - come già rivelato altrove – rappresentano quel lastricato prediletto dove i versi si costruiscono tra nebulose e polvere in un campo infinito che l’uomo – come fece Dante, Leopardi e a seguire tutta la tradizione amorosa e malinconica della poesia vera – ammicca all’insù meravigliato.