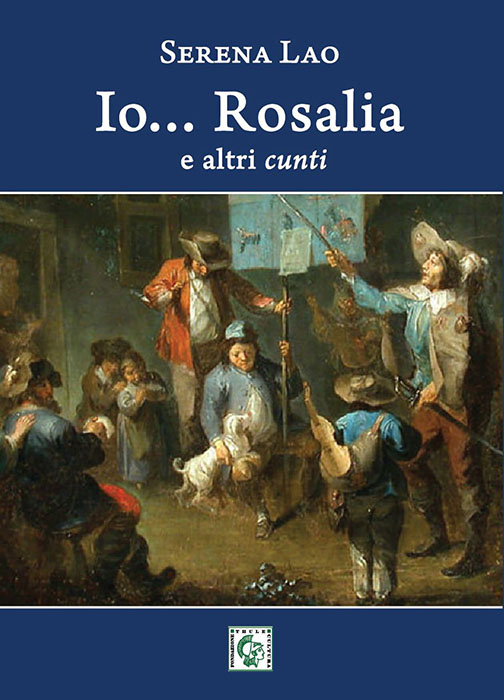“Cuspidi maiolicate, la gioia del poco” di Ciro Lomonte
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 16 Ottobre 2025
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 560

Fra le case editrici encomiabili per il coraggio con cui affrontano l’emorragia di vendite delle versioni cartacee dei libri si annoverano le Edizioni Caracol, guidate da Monica Craparo, specializzate in pubblicazioni di nicchia, apprezzate in modo speciale da ingegneri e architetti. Sono architetti e dottori di ricerca in Storia dell’Architettura che, dal 2004, hanno dato vita a una casa editrice che riflette le loro passioni e i loro interessi: l’architettura, l’arte e la storia della Sicilia. È significativo che il loro sguardo non si limiti all’isola: la Sicilia, da sempre humus fertilissimo di civiltà, li ispira ad ampliare costantemente il loro orizzonte culturale. Da qualche anno il loro sguardo è rivolto anche ai più piccoli con l’intento di far germogliare fin da bambini l’amore per l’arte attraverso la conoscenza di storie e monumenti. La parola Caracol è di origine spagnola e significa “chiocciola”. Il termine viene usato anche in ambito architettonico per indicare le scale elicoidali in pietra a vista presenti in numerosi edifici medievali, rinascimentali, floreali.
 Uno degli ultimi travagli editoriali è stato Cuspidi maiolicate nel paesaggio siciliano. Storia, tecnica e arte, pubblicato con il contributo della Fondazione Sicana (Sicilbanca). L’opera è frutto di ben ventidue anni di ricerca rigorosa di Giovanni Fatta (già professore ordinario di Architettura Tecnica dell’Università di Palermo) e Calogero Vinci (professore associato di Architettura Tecnica dell’Università di Palermo). L’indagine ha prodotto un’antologia sorprendente dal punto di vista scientifico e appassionante per il fascino ammaliante dei manufatti catalogati. Sabato 11 ottobre il volume è stato presentato nell’elegante Palazzo Pantelleria Varvaro (piazza Giovanni Meli 5, Palermo). È stata la quarta presentazione a Palermo, mentre si moltiplicano quelle nelle cittadine siciliane che vantano con comprensibile orgoglio la presenza di una o più di queste vivaci terminazioni dei campanili. Sono stati gli stessi autori a presentare il saggio, mentre come moderatore è intervenuto l’arch. Cesare Capitti. L’incontro fa parte del ciclo culturale Fermentu Littirariu, organizzato da Siciliani Liberi, in particolare dall’arch. Amelia Cassataro. Quella dell’11 ottobre è stata l’occasione per riscoprire un patrimonio artigianale e simbolico che punteggia il paesaggio isolano: le cuspidi maiolicate, elementi architettonici che, con le loro geometrie e i loro colori, raccontano secoli di storia, tradizione costruttiva e devozione religiosa. La pubblicazione di Cuspidi maiolicate nel paesaggio siciliano arriva in un momento in cui cresce l’attenzione verso i beni culturali “minori”, le arti decorative applicate, quella sapienza artigianale che a volte sfugge allo sguardo frettoloso e avido di immagini ma che custodisce e rivela l’anima di un popolo. Non è un caso che le domande alla fine della presentazione siano state parecchie e abbiano occupato un tempo maggiore della presentazione stessa. Si notava che i partecipanti sarebbero rimasti volentieri più a lungo.
Uno degli ultimi travagli editoriali è stato Cuspidi maiolicate nel paesaggio siciliano. Storia, tecnica e arte, pubblicato con il contributo della Fondazione Sicana (Sicilbanca). L’opera è frutto di ben ventidue anni di ricerca rigorosa di Giovanni Fatta (già professore ordinario di Architettura Tecnica dell’Università di Palermo) e Calogero Vinci (professore associato di Architettura Tecnica dell’Università di Palermo). L’indagine ha prodotto un’antologia sorprendente dal punto di vista scientifico e appassionante per il fascino ammaliante dei manufatti catalogati. Sabato 11 ottobre il volume è stato presentato nell’elegante Palazzo Pantelleria Varvaro (piazza Giovanni Meli 5, Palermo). È stata la quarta presentazione a Palermo, mentre si moltiplicano quelle nelle cittadine siciliane che vantano con comprensibile orgoglio la presenza di una o più di queste vivaci terminazioni dei campanili. Sono stati gli stessi autori a presentare il saggio, mentre come moderatore è intervenuto l’arch. Cesare Capitti. L’incontro fa parte del ciclo culturale Fermentu Littirariu, organizzato da Siciliani Liberi, in particolare dall’arch. Amelia Cassataro. Quella dell’11 ottobre è stata l’occasione per riscoprire un patrimonio artigianale e simbolico che punteggia il paesaggio isolano: le cuspidi maiolicate, elementi architettonici che, con le loro geometrie e i loro colori, raccontano secoli di storia, tradizione costruttiva e devozione religiosa. La pubblicazione di Cuspidi maiolicate nel paesaggio siciliano arriva in un momento in cui cresce l’attenzione verso i beni culturali “minori”, le arti decorative applicate, quella sapienza artigianale che a volte sfugge allo sguardo frettoloso e avido di immagini ma che custodisce e rivela l’anima di un popolo. Non è un caso che le domande alla fine della presentazione siano state parecchie e abbiano occupato un tempo maggiore della presentazione stessa. Si notava che i partecipanti sarebbero rimasti volentieri più a lungo.
Il volume, con le sue densissime 227 pagine, conduce i lettori in un affascinante viaggio visivo in luoghi della Sicilia che meritano di essere riscoperti. È un’opera aperta, non solo perché gli autori continuano le loro indagini sull’argomento, ma anche perché in fondo sono più le domande poste che le risposte date. Perché la Sicilia ha l’esclusiva di questa soluzione, strutturale e decorativa al tempo stesso? Al di fuori dell’Isola le soluzioni simili si contano sulle punta delle dita. Come si sono formati gli artigiani che hanno realizzato le cuspidi maiolicate? Qualcuno ha fornito loro i disegni? Come si è arrivati a definire le sagome delle cosiddette burnie, i singoli cunei di terracotta maiolicata? Con quali centine e impalcature venivano collocati? Di fatto gli storici locali e gli archivi hanno fornito agli autori elementi per la datazione e per la verifica dei costi delle singole cuspidi, ma il resto è ancora da scoprire.

Un dato su tutti è particolarmente significativo. Le cuspidi maiolicate non si trovano nelle città maggiori siciliane, soprattutto quelle sulla costa. Qui sono preferite le terminazioni in conci di pietra da taglio, più costosa, proveniente da cave di qualità, che comportava maggiori spese di trasporto. Ci sono anche rivestimenti di maiolica, ma sono finiture più che elementi strutturali. Si potrebbe ipotizzare pertanto che la scarsezza di risorse abbia fatto aguzzare l’ingegno di committenti e maestranze. Bisognava ottenere un bel risultato a costi ridotti. Se così fosse, si tratterebbe di un’ulteriore conferma di un elemento tipico dell’identità siciliana: fare tesoro del poco che si ha. Questo avviene per esempio nelle pietanze povere (oggi assurte al rango di prelibatezze sfiziose), come la pasta di castagne, la cuccia, ’u pani c’a meusa, 'i stigghiola, ’i sardi a beccaficu, ’a pasta palina e così via dicendo. Anche i capolavori in stucco dei Ferraro e dei Serpotta nascono dall’esigenza di usare materiali più economici del marmo. Il poco è diverso dal meno (less is more è il famoso motto del maestro del razionalismo architettonico Ludwig Mies van der Rohe, il meno è il più). Non si tratta di algido minimalismo. Il poco viene trasfigurato dalla sapienza siciliana in una bellezza ed in una bontà che riempiono di gioia. Questo si nota anche nelle esuberanti cromie, che – guarda caso – fino all’Ottocento erano molto misurate, molto diverse dai chiassosi colori più o meno puri dell’Opera dei Pupi e dei quadri di Guttuso. Oltretutto le maestranze impegnate nelle opere architettoniche erano molto più preparate di quelle necessarie per l’edilizia in calcestruzzo armato. Quelle erano sottoposte ad un duro apprendistato che andava dalla menza cucchiara al capo mastro (che doveva dimostrare di essere capace di fare il cuci e scuci dei conci) e perciò erano capaci di realizzare robuste voltine con mattoni a foglia o scale elicoidali in pietra, in cui la sezione aurea stava alla base della stereotomia. Altri tempi, si dirà. Eppure in Sicilia non tutto è perduto.