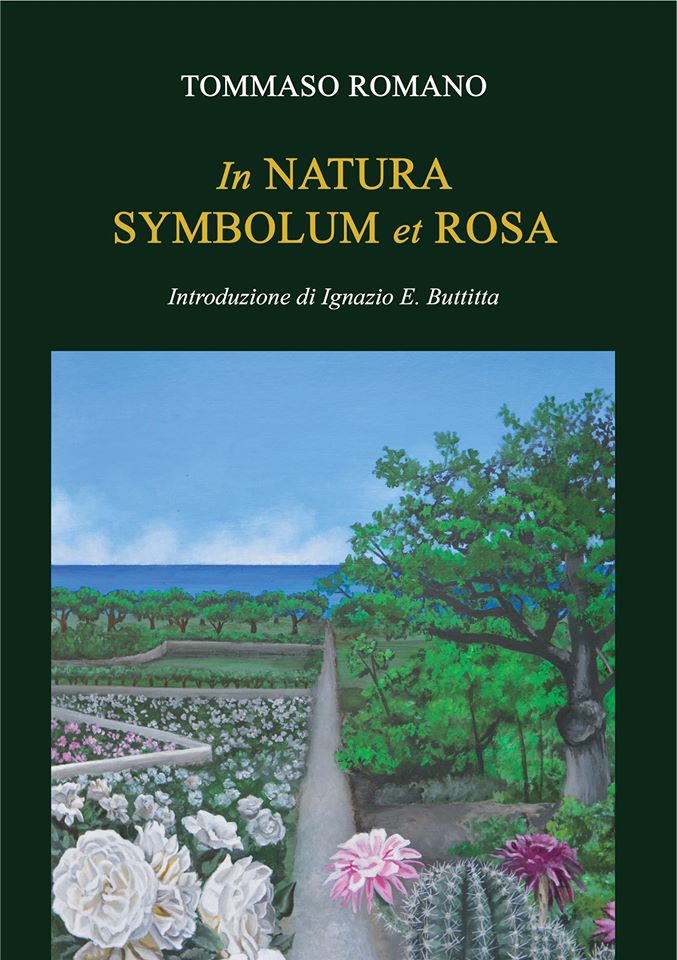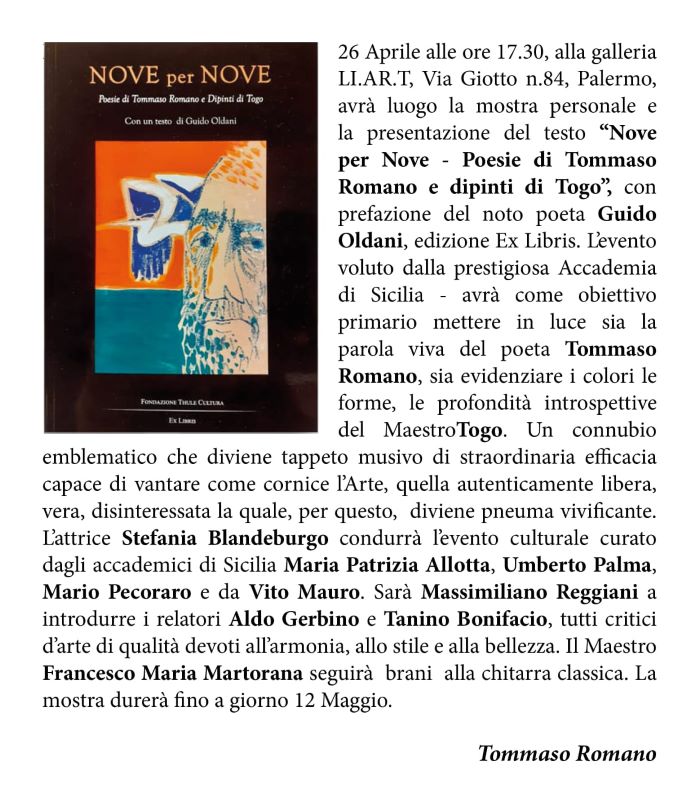Giuseppina Li Cauli, Leda Melluso, “Storie albanesi di Sicilia, conversazione con un arbëreshë” (ed. Istituto Poligrafico Europeo) – di Gaetano Celauro
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 13 Novembre 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 613
 Un racconto a quattro mani quello delle due autrici, già allieva e maestra che a distanza di anni si sono riunite per scrivere questo interessante volume che si propone di tracciare la storia di una comunità in maniera fluente e accattivante.
Un racconto a quattro mani quello delle due autrici, già allieva e maestra che a distanza di anni si sono riunite per scrivere questo interessante volume che si propone di tracciare la storia di una comunità in maniera fluente e accattivante.
Giuseppina Li Cauli è originaria di Piana degli Albanesi, vive a Palermo dove svolge l’attività di avvocato civilista. Come arbëreshë di Sicilia si interessa della storia e del costume del suo popolo.
Leda Melluso è nata ad Arezzo, ma da anni vive a Palermo, dove ha insegnato letteratura italiana e latina nei licei. È autrice di testi per la scuola media superiore e di numerosi saggi sulla storia della Sicilia.
Inizio modulo
Si viaggia nel tempo, ed in luoghi diversi, in quanto l’insediamento in Sicilia di Albanesi, è avvenuta in tempi diversi e mutate e dissimili sono state le circostanze che hanno indotto un nutrito gruppo di persone ad abbandonare la loro terra natia.
La forma narrativa adoperata, scevra da tecnicismi o colte e sovente superflue citazioni e annotazioni, è quella della semplice intervista con cui Leda Melluso interroga e sprona la sua interlocutrice di origini arbëreshë, Giuseppina Li Cauli, a narrare delle origini, della storia, delle tradizioni e delle usanze della sua terra natia. E questo sulla scorta dei ricordi anche dei suoi avi, dei suoi familiari più anziani che hanno memoria di quello che è successo a partire dall’invasione dell’Impero Ottomano.
Nella prefazione curata attentamente da Rino Messina, si evidenzia come nel volume si riportino episodi della c.d. “Grande Storia” come la strage di Portella della Ginestra ma anche episodi minori ed anche quelli della vita di ogni giorno, quella della quotidianità. Si parla della povera popolana di Scurati che viene murata viva per ingraziarsi il favore della divinità ma anche della prima strada rotabile da Piana degli Albanesi per Palermo e della notevole e fattiva partecipazione delle donne albanesi ai Fasci Siciliani del 1893 come pure alle varie altre rivolte. Ma quello che traspare e affiora sempre è l’amore e l’attaccamento alle proprie origini da parte dell’interlocutrice.
Nell’introduzione, si chiarisce al meglio come non si è voluto fare un saggio storico, sociologico o antropologico ma si è voluto punto riportare in modo chiaro e scorrevole, il contenuto di una conversazione su cinque secoli di Storia di un popolo che ha saputo mantenere la propria identità pur integrandosi con una cultura diversa.
Gli “Albanesi” di Sicilia, sono da annoverare come un altro popolo, una ulteriore preziosa cultura che ha arricchito anch’essa l’unicum di grande crogiuolo di civilizzazioni presente in questa terra dove è iniziata una Storia alla quale se ne sono aggiunte tante altre.
Tutti i popoli che hanno attraverso questa terra hanno lasciato traccia, quantunque dominatori. ma ci sono stati anche popoli che sono arrivati in questa terra non per dominare ma per trovare rifugio e tra questi proprio la comunità albanese, gli arbëreshë. Questi sono venuti ad inserirsi in una comunità dove hanno portato le loro famiglie con l’intenzione precisa di vivere un rapporto simbiotico, mantenendo però una forte loro identità con gli autoctoni e la Sicilia ha preservato queste realtà e questi gruppi.
Complessa antica la storia di queste comunità in cui spiccano le figure di grandi personaggi come Giorgio Castriota Skanderberg, un eccelso condottiero che portò questa comunità in Sicilia cercando di stanziarsi in un proprio territorio. Questa gente ha voluto conservare le proprie tradizioni, le proprie radici principalmente nella lingua, nei riti, nel vestiario e nel quotidiano, non rompendo mai quel cordone ombelicale che li lega alla loro terra di origine.
Queste isole alloglotte che hanno mantenuto una propria natura linguistica, ad un certo punto si sono aperte anche agli altri e in queste terre si parla pure l’italiano. E questo perché la comunità ha avuto bisogno di venire fuori dal perimetro della propria appartenenza per entrare in rapporto dialogico con gli atri. La comunicazione non ha però intaccato i convincimenti profondi di una comunità al cui interno nelle diverse realtà territoriali, ognuno ha poi
seguito una sua strada ma non perdendosi nell’anonimato del villaggio globale, non disperdendo il proprio patrimonio culturale
L’uso del costume in determinati periodi dell’anno, non è solamente un abito per coprirsi ma è un elemento significante il simbolo di un’identità mai abbandonata.
La comunità albanese è stata considerata unitaria, un corpo comune ma ciò è avvenuto attraverso dei passaggi travagliati, come nel caso di Palazzo Adriano nel 1521 allorché il sovrano decise di ritirare tutti gli accordi che aveva prima fatto con i Palazzesi in termini di autonomia, libertà che aveva prima loro riconosciuti.
Un aspetto di rilievo delle comunità albanesi era che al loro interno non vi erano dei principi, baroni ma vi erano all’interno dei rappresentanti eletti che di volta in volta si recavano a discutere.
Un altro momento importante è quando nel 1571 a Palazzo Adriano, in quello che diventerà il circolo Skandeberg, si riunirono tutti i rappresentanti delle comunità albanesi e decisero di inviare un contingente di 500 soldati in occasione della battaglia di Lepanto.
Se è pur vero che quella degli albanesi è una storia di integrazione, è anche vero che questi sono stati una spina nel fianco al potere locale dei baroni che temevano per le proprie prerogative. Questo è un elemento costante che si ripeté poi nel periodo dei Fasci Siciliani di fine Ottocento e poi ancora nel c.d. “Biennio rosso”. Nel periodo dei Fasci del 1893, fu massiccia la presenza delle donne e vi era un circolo la cui presidentessa era Maria Cammarata con iscritte 600 donne che partivano a piedi da Piana per arrivare a Palermo per partecipare alle manifestazioni.
Quella degli Albanesi di Sicilia è una storia di grande fierezza e orgoglio. Gli Albanesi di Sicilia, discendono da valorosi guerrieri, quali Capitani e soldati di ventura che prima di tutti gli altri scesero in Sicilia specie a Mazara del Vallo per poi emigrare all’interno per timore dei Turchi. A quell’epoca risale la fondazione di Palazzo Adriano, Contessa Entellina, Mezzojuso, Successivamente nel 1488 arrivò il resto della comunità ma quei soldati continuarono il “mestiere delle armi” quando si presentava la bisogna, alternandolo nei momenti di quiete alla coltivazione dei campi.
Quella degli albanesi non è solo una storia di riti, usi e costumi che li identificano, pur essendo importanti, ma è anche e soprattutto una storia di orgoglio e di fierezza, di ingiustizie subite e di anelito continuo alla giustizia sociale che li ha contraddistinto.
Il libro prezioso ed esauriente per le notizie, dati e testimonianze, alcune di di prima mano ed inedite, è corredato di una ricca bibliografia ed in un capitolo riporta i nomi di origini albanese che ancora oggi sono presenti nei territori dove dimora la popolazione albanese.(gc)