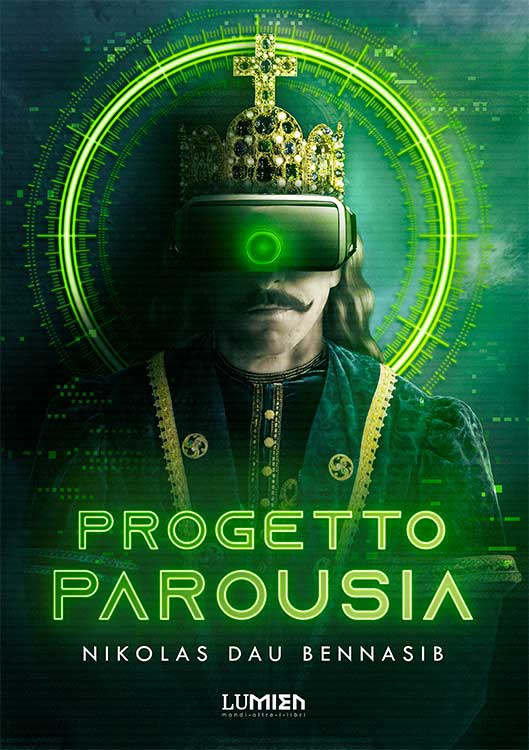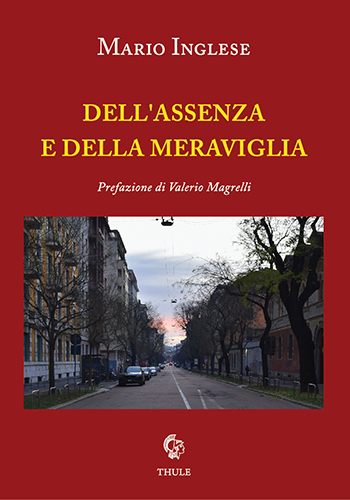“Canti a Prometeo” di Gino Pantaleone, secondo Tommaso Romano
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 04 Giugno 2019
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1730
 Io non farò una relazione. Farò solo un breve intervento perché ritengo che, come leggerete nel silenzio e nella meditazione delle vostre case, questo poemetto, questi canti hanno una unità quasi inscindibile e debbono essere intesi come delle stazioni di un percorso che è insieme modernissimo e classico e che ha il primato della parola come fonte di Verità, ma anche di ricerca e conoscenza attraverso la Poesia che diventa anche illuminazione.
Io non farò una relazione. Farò solo un breve intervento perché ritengo che, come leggerete nel silenzio e nella meditazione delle vostre case, questo poemetto, questi canti hanno una unità quasi inscindibile e debbono essere intesi come delle stazioni di un percorso che è insieme modernissimo e classico e che ha il primato della parola come fonte di Verità, ma anche di ricerca e conoscenza attraverso la Poesia che diventa anche illuminazione.
Questa illuminazione è data anche da una intensa musicalità e riprende con forza quella tradizione classica, non solo del sonetto, ma di tutte quelle immagini che le parole riescono ad evocare quando non sono stridore, quando non sono cacofonie, quando non sono parole di libertà. In questo senso pensiero e canto si incontrano in una unità anche prodigiosa che raramente si trova nei frammenti.
All’Insegna dell’Ippogrifo è parte della “Fondazione Thule” e lavora già da molti anni in testi particolari. E questo è un testo particolare perché è fuori dai canoni ed è fuori da certa consuetudine, da una certa Poesia che è spesso o espressione di intimismo fine a sé stesso o peggio di denunzia che avrebbe altri termini di esecuzione e di manifestazione.
In questo senso la lezione eterna del mito che si rivela nel quotidiano riporta la Poesia, paradossalmente, al suo statuto originario, non solo per il titolo e non solo per il protagonista che fa parte di questa visione ampia del mito. Prometeo è pregno di questa “vita oltre la vita” che è quella di sciogliere le catene che sono le catene del contingente. Quello che fa in fondo Pantaleone è proprio questo. E’ quello di cercare l’essenza, quello di cercare la parola con un significato “altro”, con un significato più nobile e quindi la ripresa di una versificazione non fine a sé stessa, che ha anche una sua intensa musicalità che non accompagna il testo ma è il testo insieme.
Quando l’opera è un tutt’uno è Arte, è Bellezza!
E questo è il tentativo riuscito di Pantaleone la musicalità, l’altezza del pensiero senza entrare in diatribe dialettiche, con una profondità che poi si relaziona con ogni soggetto e con ogni dimensione dell’umano.
In questo senso, anche lo sforzo di riprendere il filo di una grande tradizione che abbiamo abbandonato, quella, cioè, di mettere insieme gli elementi che possono connotare anche una profondità di pensiero ma anche una profondità di sentire.
Questi “canti” quindi, proprio perché si chiamano “canti”, entrano in questa specificità, in questo cuore della Poesia. Il canto che entra al di là del significato come un tutt’uno.
Dicevo pocanzi, componimenti come “stazioni” di un’unica architettura virtuosa, che è, nello stesso momento, lirica e, per usare un termine di Petrarca, un “dilivrarmi”, rispetto alla quotidianità, alle contingenze. E’ un po’ lo sciogliere quelle catene a cui il simbolo di Prometeo si riferisce.
Tutto questo lo sentiremo quando, leggendo questi sonetti autonomamente, faremo una riflessione con noi stessi, perché in questo caso non c’è una raccolta di Poesie, non ci sono testi disomogenei nella struttura e significati per cui bisogna trovare il filo di Arianna, no! Qui c’è una unità, un’architettura composita ma armonica.
E qui torna il canto, e qui torna la Poesia, perché l’armonia è una delle più difficili conquiste della Poesia, quella cioè di trovare un filo che ti possa mettere in relazione con tutto il testo. Cosa può avvenire nelle raccolte di Poesia? Che ci sono delle Poesie molto belle ma poi ci sono delle cadute verticali perché spesso non si ha la forza autocritica magari di scegliere.
Qui invece no. Non ci sono delle cadute. Qui c’è un continuum che diventa un unicum ed ecco perché “i canti” diventano “il canto” nel senso di unità. E tutto questo, secondo me, leggendo, sentendo, ascoltando la musica si percepirà, senza spirito critico, con invito alla lettura, fondamentale per capire l’operazione bella, intelligente e anche variegata nel suo registro d’interesse (Pantaleone è anche un saggista, un uomo di profondi interessi culturali, musicali). In questo caso Pantaleone raggiunge con la Poesia così integrata un vertice difficilmente raggiungibile.
Qui, invece, c’è unità della visione della Poesia e c’è la Poesia come unità e quindi c’è la “Poesia”.