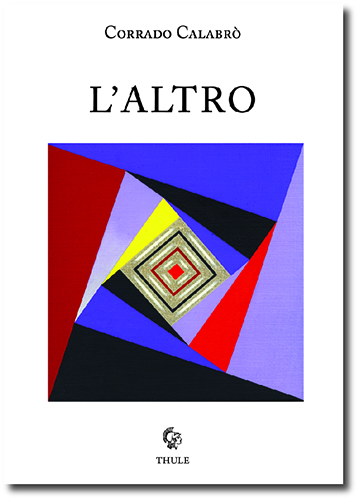“Quando i “monsù” erano di casa…” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 05 Febbraio 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 973
 Un repertorio di “delizie” è il libro L’ultimo dei monsù (2023) di Fabrizia Lanza, dove i molti “sapori” approntati per i nobili Tasca Lanza d’Almerita dal monsù di casa, Mario Lo Menzo originario di Mistretta (ME), fanno da guida entro un mondo di ricordi di famiglia che si allarga a vivace aneddotica storica e sapido ritratto di costumi. Un excursus gastronomico che risale fino al tardo Settecento per tornare poi alla Palermo dell’alta ristorazione, affermatavisi dagli anni Cinquanta del ‘900 ad opera degli chef “emigrati” dai palazzi nobiliari dopo la seconda guerra mondiale, quale Francesco Paolo Cascino. Formatosi nelle cucine del duca di Orleans, il Cascino fonderà nel 1958 il primo Istituto Alberghiero della città, che sfornerà generazioni di giovani imbrillantinati con toque e pantaloni a quadretti che preparano menu altisonanti e, nei bar, squadre di camerieri con giacchette bianche e guantini immacolati che scivolano tra i tavoli protetti dalle tende stese sui finestroni. Il libro, in linea con l’attuale attività di gastronoma dell’autrice, ex storica dell’arte, impegnata a consolidare la scuola di cucina creata nel 1987 dalla madre Anna Tasca Lanza nella tenuta di Regaleali, dà soprattutto voce e consistenza alla “nostalgia” di un contesto socio-ambientale allontanato da sé da una Lanza diciottenne in fuga dalla propria terra d’origine, e recuperato oggi con un forte e diverso radicamento affettivo-culturale. Costruito su ricordi personali, ricerche attente di archivio, fonti storiche e documentarie di vario tipo fra cui antichi ricettari ottocenteschi, il racconto focalizza la cucina aristocratica “alta e opulenta” di Mario, ma non trascura anche quella “campagnola” siciliana in un intreccio antico di gusti tipico del meticciato culinario isolano fra ascendenze spagnole francesi arabe, per non spingerci più lontano.
Un repertorio di “delizie” è il libro L’ultimo dei monsù (2023) di Fabrizia Lanza, dove i molti “sapori” approntati per i nobili Tasca Lanza d’Almerita dal monsù di casa, Mario Lo Menzo originario di Mistretta (ME), fanno da guida entro un mondo di ricordi di famiglia che si allarga a vivace aneddotica storica e sapido ritratto di costumi. Un excursus gastronomico che risale fino al tardo Settecento per tornare poi alla Palermo dell’alta ristorazione, affermatavisi dagli anni Cinquanta del ‘900 ad opera degli chef “emigrati” dai palazzi nobiliari dopo la seconda guerra mondiale, quale Francesco Paolo Cascino. Formatosi nelle cucine del duca di Orleans, il Cascino fonderà nel 1958 il primo Istituto Alberghiero della città, che sfornerà generazioni di giovani imbrillantinati con toque e pantaloni a quadretti che preparano menu altisonanti e, nei bar, squadre di camerieri con giacchette bianche e guantini immacolati che scivolano tra i tavoli protetti dalle tende stese sui finestroni. Il libro, in linea con l’attuale attività di gastronoma dell’autrice, ex storica dell’arte, impegnata a consolidare la scuola di cucina creata nel 1987 dalla madre Anna Tasca Lanza nella tenuta di Regaleali, dà soprattutto voce e consistenza alla “nostalgia” di un contesto socio-ambientale allontanato da sé da una Lanza diciottenne in fuga dalla propria terra d’origine, e recuperato oggi con un forte e diverso radicamento affettivo-culturale. Costruito su ricordi personali, ricerche attente di archivio, fonti storiche e documentarie di vario tipo fra cui antichi ricettari ottocenteschi, il racconto focalizza la cucina aristocratica “alta e opulenta” di Mario, ma non trascura anche quella “campagnola” siciliana in un intreccio antico di gusti tipico del meticciato culinario isolano fra ascendenze spagnole francesi arabe, per non spingerci più lontano.
Mario, il maggiore dei cinque fratelli Lo Menzo, arriva nel 1954 a 18 anni, con appena la quinta elementare, in una Palermo piuttosto lurida e disordinata, affollata di lambrette e carretti carichi di limoni e patate, dove ancora si incontrava per strada il contadino con la mucca da mungere, per vendere il latte di porta in porta, il venditore di ghiaccio e quello di sfincioni. Viene assunto Mario come lavapiatti su garanzia (tutta gente di montagna, brave persone e ottimi lavoratori) dell’amministratore mistrettese del feudo di Regaleali dei nobili Tasca, anch’essi originari di Mistretta, i quali avevano già un burbero cuoco di casa, Giovannino Messina. Di lui, negli anni, Mario sarà attento a carpire tutti i segreti, subentrandogli solo dopo il 1961 e divenendo il re/mito, imponente nella divisa con l’alta toque bianca, ma bonario e solare nel sorriso, delle cucine della villa di Camastra, dallo splendido giardino tropicale e lago con i cigni, della casa del mare a Mondello, e di “Case Vecchie” a Regaleali, dove la famiglia si trasferiva per la mietitura e la vendemmia. L’affettuoso ricordo di Mario porta la Lanza non solo a indugiare sulla descrizione del paese di Mistretta, alto 900 metri -dice- con una bella villa comunale sciccosamente chiamata alla svizzera lo chalet, paese originariamente di boscaioli, carbonai, pastori, casari, che annoverava nel 1954 un tribunale, dei giudici, una prigione, il liceo classico, bellissimi palazzi (oggi in vendita) fra cui il palazzetto Tasca (oggi municipio) con piano nobile affrescato e una bella balconata affacciata sulla valle e verso il mare lontano, ma che aveva già conosciuto, per la crisi della coltivazione del grano e della manutenzione dei boschi, ondate migratorie verso l’America e l’Australia. Si sofferma anche l’autrice sul suo incontro con Bettina, sorella di Mario e unica superstite della famiglia, che offrirà a Fabrizia e a sua zia Costanza, entrambe in visita al paese, un pranzo con penne al ragù di carne di manzo locale macinata -diverso da quello più rusticano di pecora a prezzi grossi che, precisa Bettina, faceva sua madre e non aveva eguali-, uova sode ripiene di tonno e del loro tuorlo amalgamato con la senape (ricetta -puntualizza Bettina- di Mario), carciofini spenti nell’acqua e aceto e conditi con olio e origano, e a chiusura i famosi gioielli di pasta reale di Mistretta, minuscole cornucopie di frutti e fiori, segni propiziatori -osserva la Lanza- di raccolti futuri nonché prodotto di una ritualità femminile dove l’anima del paese siciliano viene fuori in tutta la sua grandezza. “Gioielli” a cui si aggiunge l’evocazione compiaciuta nella memoria dei “savoiardi di Mistretta” (ricordandone dall’infanzia l’autrice come se fosse ieri l’esatta consistenza e il profumo) che Mario portava ogni mese per la prima colazione del nonno, il nobile Giuseppe, e “ritrovati” nel panificio di fronte al municipio. Dei cibi caratteristici di Mario che hanno deliziato tre generazioni di Tasca, Fabrizia ricorda, fra gli altri, il suo piatto preferito da bambina al ritorno da scuola: i ghineffi in brodo (palline di riso fritte con consommé ambrato chiaro); la troneggiante brioche piena di formaggi del principe di Galles preparata per Carlo d’Inghilterra ospite dei nonni, Giuseppe appunto e Franca Tasca; l’anatra in salsa suprema (salsa che era un amalgama di burro farina panna tuorli d’uovo e fondo bianco di pollame) che veniva servita con una corona di pane fritto coperto da una purea di cavolicelli besciamellosi; il menu nel 1984 per le nozze d’oro dei nonni, che con tipica terminologia francese, esibiva come hors-d’oeuvre i frittini dell’aperitivo, seguiti da pasta con le sarde e anelletti alla siciliana, e come entremets il tradizionale, nobiliare, pasticcio di caccia rivestito dalle piume rosso brunite del fagiano, i cestini di pasta intrecciata con i medaglioni di pâté di fegatini di pollo cinti da begonie intinte nella paraffina (cibo manufatto bello da vedere… da ammirare e non più solo da mangiare), e il prosciutto all’ananas, con finale gelatina di agrumi. Il piatto della fagiana, con le decorativo-monumentali piume lunghissime della coda, messaggio -sottolinea la Lanza- sublimininale, quanto anacronistico, di signorilità feudale, e un magnifico timballo di pasta saranno esibiti da Mario anche in una serata del Maurizio Costanzo Show, e avrà negli anni pure Mario, prima di morire di diabete nel 2008 e uscire di scena in punta di piedi, la sua fetta di gloria mediatica fra interviste, premi delle associazioni di categoria, e articoli che lo citavano come l’ultimo monsù* di casa aristocratica.
Quanto al pasticcio di caccia l’autrice spiega che Mario preparava prima il pâté di fegatini ampiamente condito e setacciato sino a formare un denso purè, poi lavorava la “caccia” (lepri, beccacce, colombacci…) cucinata animale per animale, ridotta a pezzi e amalgamata con il tartufo nero, definito da Alexandre Dumas la polpa degli dei, il sancta sanctorum dei gastronomi, ricoprendo infine il tutto di gelatina piquant, cioè acetosa, pungente al naso e che non aveva nulla a che vedere con il pepe e il peperoncino, e -come gastronoma- non tralascia di annotare che l’arte dello chef sta nel rigore e complessità delle procedure: il nettare, dividere, lessare, pestare, setacciare, mescolare, sgrassare, bollire, ridurre e poi ancora scorzare, affettare e friggere, domando la materia e dando forma all’informe. Racconta inoltre del pasticcio di caccia alla Périgord menzionato in una lista di spesa per un ricevimento a casa Tasca del 24 febbraio del 1881, ricevimento che prevedeva l’immancabile consommé d’apertura, il pasticcio di caccia e fra gli altri servizi: galantine, prosciutto, pesci guarniti, arrosto, e un dessert a base di pasticceria milé, cioè varia, dolce e salata, fredda e calda, con brioscioni, gelatine, biancomangiare e tartufi alla Sciampagna. Di Mario Fabrizia evidenzia pure la tecnica paziente con cui preparava la glas, che -afferma- è sovrana nel mondo delle salse, un concentrato quintessenziale di sapore… e esalazione estrema di un pezzo di carne. Mario rosolava il pezzo di carne (lacerto di coscia o di spalla) in una casseruola di alluminio, coprendolo di listarelle di cipolle non molto sottili, lo sfumava con il vino, lo ricopriva di brodo lasciandolo cuocere ore e ore a fuoco lento, finché la carne non era cotta e le cipolle disfatte. Pureate le cipolle, filtrava la salsa attraverso setacci finissimi, la legava con la farina e la conservava in frigo dentro un barattolo di vetro, usandola poi un po’ su tutto, come faceva con il parmigiano e il prezzemolo. Con intensa emozione vengono ricordate dall’autrice le sere estive sulla terrazza di Mondello dei nonni, al culmine dell’estate agostana, quando sole e sale impregnano i tuoi vestiti e diventano la tua pelle che di notte si tende come un tamburo, allorché Mario approntava la pasta con l’uovo fresco di cernia, il vitello tonnato, il gelo di mellone, un rubino incoronato di gelsomini e granella di pistacchio, cui il nonno mischiava frammenti di cioccolato. La cucina di Mario aveva una doppia anima, quella regale, più ufficiale e di parata, vedi in taluni pranzi le cotolette di agnello alla Villeroy, la galantina di pollo, l’anatra in salsa suprema, i vol-au vent, che per nonna Franca soddisfacevano praticità e decoro, e quella più confortevole, più intima, fatta di brodi, monachiglie, risi legati. Nello specifico, di sera il piatto cardine -dice Fabrizia- della mia infanzia era una minestra di brodo e riso legato da rossi d’uovo, latte e la solita abbondanza di parmigiano, o in alternativa le monachiglie, minuscole polpettine di carne (petto di pollo o di cappone) cotte in brodo di pollo, peraltro già presenti -come documentano gli archivi- in casa Moncada e casa Trabia nel primo Ottocento. Con le “dolcezze” del latte fritto (nel solito abbondare di uova farina burro) e dei profiteroles, dolci che erano i cavalli di battaglia di Mario, convivevano pure cose umili e preziose della “campagna”, quali i “granelli” (palle di toro) che piacevano al nonno e facevano ammiccare a tavola maliziosamente i bambini, la pasta alla finanziera (quando si macellavano a Regaleali le galline), le teste di capretto fritte, le fave a cunigghiu (lessate con aglio e cipolla e servite con olio evo, pepe e crostini di pane), alfa e omega -dice la Lanza- del mio lessico familiare.
Il fatto è che le radici della fastosa e variegata cucina di Mario (e Giovannino) e il “gusto” dei Tasca affondano lontano nel tempo, nelle abitudini alimentari degli antichi principi di Butera e Trabia, fra cui i genitori di Beatrice Lanza Branciforte, sposa nel 1840 di Lucio Mastrogiovanni Tasca, donna colta e cosmopolita lei, che viaggiava in Europa e tornava con i menu francesi del Secondo Impero, latifondista “illuminato” e “agricoltore riformista” lui, che trasformò in floride aziende agricole gli ettari di terre di Camastra e Regaleali, passate poi al figlio Giuseppe, deputato e senatore del Regno d’Italia morto nel 1917, che vi riceveva i regnanti d’Europa di passaggio a Palermo, come già avevano fatto i genitori, generosi ospiti nel 1881, nella villa ai Porrazzi (non più esistente oggi), pure di Wagner e della sua famiglia, un Wagner che aveva dovuto lasciare l’hôtel delle Palme perché con le sue sonate notturne disturbava i clienti. Non mancano nell’excursus storico, che incrocia la Francia rivoluzionaria e poi dell’alta borghesia, i moti risorgimentali italiani e l’Unità, il rigoglio/splendore, anche urbanistico, della Palermo dei Florio e quella mondana del II dopoguerra dei whisky, cocktail e seltz, e del ristorante Extrabar Olympia di Piazza Politeama, non mancano -dicevo- pure: i viaggiatori del ‘700 del Gran Tour per i quali la cucina siciliana era un misto di gusto francese (fricassé fricandò ragù) e spagnolo (l’olla potrida); i granelli, il caciocavallo e le frattaglie di tonno lavorate a ficazzi (sosizzuni a forma di fico) o carrubbelli (a forma di bacca di carruba) cari al settecentesco principe di Trabia; la fabbrica di burro e mozzarella voluta nel parco della Favorita da Ferdinando IV esule in Sicilia nel 1799 e nel 1806, e le innumerevoli portate dei suoi pranzi (36 pietanze per il primo servizio, 32 per il secondo) imitate nello sfarzo dall’aristocrazia, un Ferdinando IV che -annota la Lanza- aveva i piedi nella cultura dei granelli e la testa in quella dei vol-au vent, così come la moglie Maria Carollina, sorella di Maria Antonietta, amava i crauti (tedeschi) e introdusse i croissant (francesi). E ancora, i favolosi ricevimenti di palazzo Butera (1799, 1814), esibizione e intreccio anch’essi di cibi (maccheroni incaciati, chineff di carne di pollo in brodo di tartaruga, pasticci di caccia, olive, peperoni, sottaceti, petites pâtés, pesce alla matalotta, rifreddi, gelati, caffè…) ma pure superbo scintillio, nell’immensa galleria illuminata da centinaia di candele, di bicchieri di cristallo, piatti d’oro e d’argento e riflessi di sete, damaschi, gioielli; la morte nel 1859 di Ferdinando II per l’indigestione di una trionfale caponata di pesce consumata a colazione (!) e in sottofondo la fronda antiborbonica e garibaldina di due fratelli e di un nipote di Beatrice; i Diari infine della stessa che se descrivono, fra molto altro, i bagni di Beatrice, unici allora (e interamente vestita) nel mare di Palermo alla Colonnella o all’Acquasanta, e riportano dei suoi viaggi in vapore e in treno, in Italia e all’estero, tappe, musei, monumenti, chiese, gallerie ferroviarie, stabilimenti termali e “l‘incanto” delle vie di Vienna e Parigi illuminate dai lampioni a gas, registrano anche i “menu” delle sue serate e la novità del placement (il posto segnato a tavola in contrasto con l’arrembaggio dei banchetti settecenteschi). Menu dagli anni ‘80 alla Carême-Escoffier, cioè destinati a nobiltà, imprenditori, benestanti, e divenuti ormai espressione dell’alta cucina internazionale: asperges de Bordeaux al posto delle bietole, il croque en bouche di Câreme, al posto dei cannoli, caro a nonna Franca, servito pure nella variante cioccolatosa à la Bourquenay creata da un altro famoso chef di secondo Ottocento, Urban Dubois, “cucina” arrivata fino ad oggi. Tutti flash quelli della Lanza su un mondo e un casato, i Tasca, di cui le ricette di Mario seppero protrarre fino alle soglie del duemila il prestigio “elegante”, prestigio tuttavia mai indifferente al cibo locale, come i dolci dei fratelli Nuccio di corso Calatafimi a Palermo, a base di arancia, mandarino, cedro candito, o zucca candita quali i canali (a forma di tegole) e i capelli d’angelo, candelotti coperti di glassa zuccherina, altro benedetto (sic!) e assai caro ricordo questi ultimi (i candelotti) d’infanzia dell’autrice, ma ora non più prodotti dai Nuccio. Le cose -conclude l’autrice- sono, poi spariscono, poi si evocano attraverso parole, gesti, storie. Qui attraverso la “figura cerniera” di Mario, dai capelli corvini e il sorriso sempre dolce e vasto.
*Il termine monsù -spiega Fabrizia Lanza- sembra derivi da Monsieur, titolo dato, secondo una attendibile tradizione, al cuoco francese di Gioacchino Murat (Monsieur Robert) e divenuto, in napoletano, monsù, e ancora prima attribuito al cuoco personale, nell’esilio di Palermo, di Maria Carolina (moglie di Ferdinando IV) e capo della Real Cocina, tal Giuseppe Lazzaro, detto familiarmente mosiù Peppino.