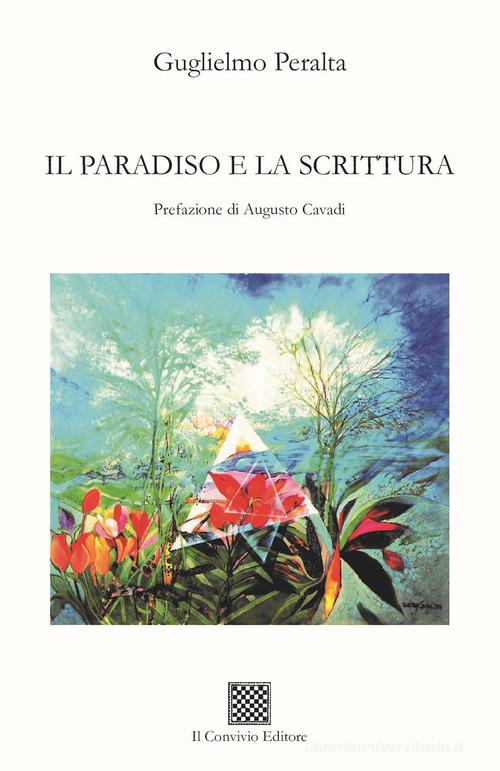Saggio critico di Giuseppe La Russa a "Poesie 2002 - 2021" di Amalia De Luca (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 16 Settembre 2021
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1508
 È il 2002 quando, dopo aver cumulato e reso proprio ogni residuo esperienziale, Amalia De Luca esordisce con la raccolta Radere Litora. La data è certamente significativa, perché siamo all’inizio di quel millennio che segna la fine, invece, di un secolo come il ‘900 che sotto diversi aspetti è stato un periodo folto e denso di avvenimenti e di motivi. Amalia De Luca sembra aver immagazzinato ogni lascito di quel secolo, ha assistito al suo fieri da attenta osservatrice e all’alba del nuovo millennio ha finalmente pubblicato i suoi testi che di quell’otium – inteso come osservazione attiva – sono il sapiente e ragionato frutto.
È il 2002 quando, dopo aver cumulato e reso proprio ogni residuo esperienziale, Amalia De Luca esordisce con la raccolta Radere Litora. La data è certamente significativa, perché siamo all’inizio di quel millennio che segna la fine, invece, di un secolo come il ‘900 che sotto diversi aspetti è stato un periodo folto e denso di avvenimenti e di motivi. Amalia De Luca sembra aver immagazzinato ogni lascito di quel secolo, ha assistito al suo fieri da attenta osservatrice e all’alba del nuovo millennio ha finalmente pubblicato i suoi testi che di quell’otium – inteso come osservazione attiva – sono il sapiente e ragionato frutto.Procediamo con ordine, prima di scandagliare i motivi e le tematiche più forti presenti nell’opera della poetessa palermitana. Perché quel richiamo al secolo novecentesco? Come ben sappiamo si tratta di una stagione per certi versi rivoluzionaria e che ha visto avvicendarsi regimi totalitari, due guerre mondiali, uno stato di profonda tensione fino alla caduta del muro di Berlino. A livello scientifico i quanti di Planck, l’indeterminazione di Heisenberg, la relatività di Einstein e la certezza dell’infinità dell’universo hanno sconvolto una determinata visione del mondo improntata al positivismo e alla certezza sensibile. L’esistenzialismo, in filosofia, ci ha detto di una condizione dell’uomo diversa da quella dei secoli precedenti, essendo esso fagocitato da una realtà che sembra apparire dietro un insormontabile muro, ci ha raccontato della nausea, della noia che il mondo può provocare. La letteratura ha poi scolpito questa dilacerazione e questa dissonanza con le voci di Moravia, di Svevo, di Camus, Sartre, si è impressa attraverso il relativismo pirandelliano, ci ha raccontato questa disarmonia con i versi di Montale; è il secolo della civiltà industriale e del trionfo della città, dell’onnipotenza della ricchezza cui fa da contraltare la perdita, da parte del poeta, della sua tradizionale “sacralità”, la sua esperienza della folla, di essere esso stesso folla, come affermato e messo in evidenza in un illuminante brano di Walter Benjamin all’interno del saggio Angelus novus. Essa, ossia la folla, porta ad un senso di estraneità, di alienazione cui l’intellettuale novecentesco va necessariamente e fatalmente incontro.
Ora, la poesia di Amalia De Luca risente fortemente e prepotentemente di queste temperie storica, sociologica e artistica: l’autrice attraverso i suoi versi prova ad inserirsi all’interno di una tradizione provando a rinnovarla dal di dentro, oppure a superarla e/o a travalicarla, sia nelle tematiche che nelle forme. Forti sono, a tal proposito, i richiami letterari: senza dubbio il più presente – e più volte richiamato – è proprio Eugenio Montale, le cui immagini ricorrono continue e impetuose, a partire dagli accostamenti marini presenti già nei titoli della raccolta, Radere litora e Conchas legere, vicini per certi aspetti agli Ossi di seppia del poeta ligure di cui una sezione, Mediterraneo, richiama il mare ancor più da vicino. Vedremo che il richiamo all’elemento marino risulta in Amalia De Luca una delle tematiche più forti e presenti: al momento basti dire che la parola ‘mare’ conta oltre le settanta occorrenze.
Dicevamo del ‘900, secolo inteso come liquidità, come terreno impervio e del trionfo del relativo, dell’incertezza e della mancanza di punti di riferimento stabili ed immutati. La poesia di Amalia De Luca può certamente inserirsi nel solco di questa tradizione italiana ed europea, poetica ed esistenziale; tradizione verso la quale, si diceva, l’autrice guarda con onnivoro interesse nel tentativo di “attraversarla” e di carpirne ogni anfratto tematico e formale. Questa vicinanza al secolo viene rilevata nell’introduzione alla raccolta Radere Litora da Pietro Mazzamuto che, in apertura, mette subito in evidenza questa sorta di continuità con la filosofia e la percezione del mondo nel secolo appena trascorso: «La silloge che abbiamo l’onore di presentare, come suo connotato di fondo, è attraversata da una palese articolata sofferenza, che rimanda alla condizione di tutto l’uomo contemporaneo, se appare chiaro l’itinerario storico della poetessa, che sembra indicarne nella seconda guerra mondiale il terminus a quo (vedi la lirica ANNO 1943) e se appare altrettanto chiaro che esso sia tutt’uno con l’itinerario tematico e fantastico del libro». Sulla stessa linea un interessante spunto di Piero Vassallo che riportiamo e che cercheremo di analizzare: «A me sembra che la sua poesia esprima, con la maestria di chi versa parole fuse nell’oro dei Greci, dunque con la rara potenza della poiesis, la tragedia del vivere umano, “la vita che se ne va per sentieri non tuoi”. La tragedia della vita che si aliena nel destino. La sua poesia, dunque, se mi è lecito esprimermi così, è parente del senso tragico dei greci, un “senso” che si proietta naturalmente sullo scenario delle ambiguità contemporanee».
Ciò che dunque viene posto in risalto è una coscienza, da parte dell’autrice, di uno “scollamento” da parte dell’uomo nei confronti della realtà, una sorta di alienazione che ha però un principio ben definibile, secondo Mazzamuto, ossia il 1943, anno densissimo all’interno del secondo conflitto mondiale, momento dei bombardamenti sul suolo italiano vissuti da una poetessa ancora bambina. Riportiamo, a proposito, il testo in questione, per evidenziare anche delle strutture formali di un certo rilievo.
ANNO 1943
Rombo
cupo minaccioso
pesanti
nuvole d’acciaio
tonfi di corpi
nel mare profondo
non oltre la linea
dell’orizzonte
e lampi di tempesta;
non paura
ma gocce tremanti
di lacrime di stelle
caddero
sul tuo cuore
di bambina:
era la guerra
Da un punto di vista formale è evidente il lavoro cui la poetessa sottopone la parola poetica nello sforzo di isolamento che compie.
Diverse parole coincidono con il verso e la cadenza che ne consegue è estremamente serrata, veloce, martellante, quasi a voler riproporre nel ritmo la rapidità della guerra, il suo essere fulminea, imprevedibile, impetuosa, soprattutto agli occhi di una bambina. La coincidenza tra verso e parola, inoltre, carica al massimo il valore semantico di ogni singolo lemma e ne accresce la valenza simbolica: emblematico è l’isolamento di quel “caddero”, termine dalla evidente e fortissima pulsione semantica e il cui passato remoto, tempo finito, rimanda alla difficoltà di una prospettiva di speranza.
Una tale modulazione è dunque un’operazione – che vedremo troverà altri riscontri – volta all’affrancamento della parola poetica dalla deriva storico – esistenziale novecentesca: sembrerebbe quasi che il verbum della poesia viva una sorta di atemporalità rispetto alla condizione stessa dell’uomo, azione questa assimilabile a quanto fece Ungaretti di cui possiamo far propria una bella immagine. Il poeta di Alessandria d’Egitto, nella ricerca della parola originaria, si esprime in questo modo, affermando come la sua poesia – e forse il ruolo della poesia tout court – sia tentativo di rimettere in funzione i meccanismi della parola stessa, per assicurarne la durata: «fu un rattaccare i frantumi dell’orologio per provare di intenderne il congegno, per provare di rifargli segnare il tempo». La parola è sentita da Amalia De Luca come corpo vivo, che dunque cambia, muta forma; viene dunque avvertita nella sua durata e durevolezza e viene avvertita di certo come baluardo capace di “raccattare i frantumi”.
Si leggano a proposito i seguenti versi, tratti dalla raccolta Conchas legere, della poesia L’umana misura:
[…] La parola non vuole
la verità di una speranza dimezzata,
la congiunzione volgare,
non risvegli dolorosi
né la finitezza imposta
alla umana misura delle cose [...]
Si tratta quasi di una dichiarazione di poetica volta a scorporare la forza fecondatrice della parola dalle situazioni e contingenze di un secolo che pretende la poesia parte di quella massa e quella folla in cui anche il fatto poetico rischia di diventare voce indistinta e indefinibile, senza identità. In questo lacerto di testo, invece, Amalia De Luca vuole indicare come la poesia stessa non possa scendere a compromessi, come sia essa certezza di un riferimento nel relativismo del secolo. Ma proprio questo aspetto, che meglio adesso andremo a scandagliare, ci porta ancor più dentro la produzione di Amalia De Luca. Come giustamente ha indicato Antonino De Rosalia, «il pessimismo della De Luca non è totale, si aprono in esso squarci di ottimismo, ora moderato ora più accentuato, in buona misura propiziati dall’intervento della sua cultura». Sono infatti diverse le occorrenze in cui la parola poetica viene esaltata come sigillo di verità: si può leggere, infatti, «la magia della parola è nascondimento disvelato, urlo di negazione e di ricreazione», «la parola ti trafigge col fuoco della verità» e nel testo Vela trasparente si può leggere come la verità della parola sia, insieme alla perfezione dell’appartenenza, alla forza sovrumana dell’amore e alla fede nello spirito universale, il mistero dell’esistere; «una poesia fatta di ritmi di silenzi, evidenzia Pierfranco Bruni: L’unica voce che si ascolta è quella dell’anima che diventa non esperienza ma profezia. La parola – profezia è un labirinto in cui le immagini toccano il cosmo. Ovvero l’universo e l’universalità».
Ecco, proprio su questi ultimi aspetti possiamo costruire il nostro percorso di studio sulla poesia di Amalia De Luca che ci appare davvero come una ricerca di questa «perfezione dell’appartenenza»: come e se la poetessa ci arrivi, quali siano gli strumenti adottati, quali i passaggi poetico – esistenziali che ci raccontano di questo itinerario artistico e spirituale.
Che Amalia De Luca possa inserirsi a pieno titolo nell’orizzonte culturale novecentesco ce lo dicono diverse sue liriche che di quella crisi storico – esistenziale già evidenziata ne sono portatrici. Come Pietro Mazzamuto bene evidenzia, già in apertura delle liriche si può riscontrare questo tratto. In Il foglio bianco, infatti, si può leggere
Bambina
ti prenderei la mano
ti chiederei:
mi vuoi bene?
Ma sul foglio bianco
bagnato dalla pioggia
lacerato dalle contraddizioni
scarabocchi negli occhi
perduta l’innocenza.
Vano sperare
in un mattino d’inverno
cercando l’azzurro
al di là dei rami secchi
in scatole di metallo.
Nessuno, con le labbra serrate,
dice il dolore di esistere.
In questa sezione di Radere Litora, Saepes, che reca le liriche più recentemente scritte, è evidente e conclamata la stonatura e disarmonia esistenziale alla quale, avevamo visto, possiamo attribuire una data bene precisa di inizio, ossia il 1943, così come l’autrice stessa ci invita a notare. D’altra parte il primo verso, “bambina”, isola ancora una volta un termine che nella rotta poetica della De Luca assume valore precipuo: l’autrice ci invita, infatti, a guardare il quotidiano con lo sguardo dilacerato di quella bambina costretta ad osservare quell’evento che è la guerra e che porta in sé l’idea stessa di discordia, di disarmonia. Elemento formale chiave presente in questa lirica e nella sezione – ma che accompagna la De Luca nel corso della sua intera produzione – è il forte utilizzo dell’enjambents che segna profondamente il ritmo e l’andatura della versificazione; allo stesso modo l’architettura fonica, contrassegnata da forti allitterazioni in –r e da suoni perlopiù aspri, risente della stessa idea e del tentativo di comunicare al lettore lo “scarabocchio” negli occhi della bambina stessa. Il foglio bianco, ossia quella pagina della vita che risulta ancora da inventare e da scrivere, è già segnato dalla contraddizione e dalla consapevolezza di una stridente dialettica all’interno del mondo: è ciò che porta alla perdita dell’innocenza. Sembra riecheggiare un testo di Salvatore Quasimodo, Imitazione della gioia, che negli ultimi versi così recita: «perduta ho ogni cosa innocente, / anche in questa voce, superstite/ a imitare la gioia». Appare quasi impossibile, o vana, la mimesi della gioia: l’apparato semantico stesso del testo ci informa di questa impotenza. Le labbra sono infatti serrate, il foglio è “lacerato”, i rami sono secchi e il momento positivo nel testo è affidato ad un condizionale (“Ti prenderei la mano”) e a una domanda che sembra irrisolta. Il finale del testo suggella questa riflessione con l’ultimo verso in cui campeggia lucido e amaro il “dolore di esistere”.
Egualmente denso un altro testo, il secondo della raccolta, Fragilità:
Imperioso
questo sentire
ti rende fragile
commiserabile;
trascinamento
fascinazione
incantesimo.
È la nostalgia
il riconoscimento reale
l’incontro necessario.
Colpisce proprio la lucida analisi di una condizione umana che deve necessariamente fare i conti con la propria debolezza, con il proprio essere transeunte. L’impalcatura dei versi rende ancor più evidente l’enucleazione di una singola parola e la sua coincidenza con il verso. Il testo segue una lirica, Nuovo dualismo, su cui appunteremo ancora l’attenzione: le due poesie sembrano dialogare tra di loro e “questo sentire” – così efficacemente richiamato dall’utilizzo del deittico – sembra quasi richiamare quanto detto nel testo precedente. Nella prima poesia della raccolta, infatti, si racconta di quella “perfezione dell’appartenenza” che stiamo tentando di rintracciare nel percorso di Amalia De Luca: «l’appartenenza consapevole al non essere dell’essere» e «l’assurdo incommensurabile del finito nell’infinito» costruiscono i limiti temporali e spaziali di quella che Tommaso Romano ha definito «una sorta di cosmogonia carezzata nella purezza della parola che ricerca l’essenza della Verità».
Ora, questa compenetrazione così forte e per certi versi “assurda” del finito nell’infinito, questa dicotomia così ontologicamente evidente e il sentirsi parte infinitesimale di una sorta di contraddizione e antitesi che rappresenta la base della vita è ciò che dà la misura della fragilità. Ciò che è fragile è destinato a consumarsi, a rompersi e certamente a morire, ma è in questo termine che che dà il titolo alla lirica che può sciogliersi l’itinerario esperienziale di Amalia De Luca. Attenta studiosa del latino e del greco non può aver utilizzato casualmente questo termine: la parola ‘fragile’ è della stessa radice di fragmentum, a sua volta da frangere, rompere. É certamente vero che l’uomo è destinato, nella sua fragilità, a rompersi, a finire, ma è proprio nell’essere frammento che si misura il miracolo dell’appartenenza all’Essere immutabile e infinito: l’uomo è infatti un coccio, una frazione, una goccia nel mare magnum dell’esistenza, ma è, esiste, appartiene: è questa consapevolezza, questo ‘sentire’, direbbe la De Luca, che costituisce il miracolo, è questa percezione che produce trascinamento, fascinazione, incantesimo, termini che evidentemente la poetessa non poteva non isolare nel singolo verso. L’uomo è il quanto di Plank che abbiamo citato in apertura: la parte più piccola, è vero, ma comunque parte della materia/mater e dunque porzione, scheggia dell’esistenza. Forse già qui, in una sezione dell’opera di Amalia De Luca che ci appare inizialmente senza risvolti positivi, si può celare il tentativo di superamento di questo apparente nichilismo esistenziale. Consapevolezza del limite, ma anche percezione di una innata in–erenza dell’uomo nel cosmo; è questo probabilmente il modo in cui Amalia De Luca vuole “scavare” la tradizione – anche e soprattutto attraverso l’uso dello strumento poetico stesso – come bene messo in evidenza da Salvo Zarcone: «ne scaturisce un forte senso della finitezza, dell’invalicabilità, del mistero e dell’oltre ma anche una rara capacità di penetrazione, di comprensione e di scoperta di un senso nelle cose che si costruisce come verità altra e parallela che soltanto la poesia può ritrovare e sa rappresentare». Ma nessun discorso può suggellare questa riflessione della De Luca meglio di un suo testo che a proposito ci appare illuminante: Sine nomine, appartenente a Carmina Pervia:
Obbligato il cammino
degli umani necessario il precipitare
tra le ombre
nell’altalena delle stagioni
nell’attesa che s’avveri
la speranza;
siamo semi nella terra
destinati a nuovi fiori:
la materia
del pianeta muto
alterna e rinnova
per noi la vita.
Diventa impossibile non chiamare in causa, adesso, quel testo/poemetto di Mario Luzi intitolato per l’appunto Seme, elemento vegetale che Amalia De Luca assimila alla natura umana; risulta assolutamente interessante come il testo di Luzi sembra essere ripreso oltre che nel tema anche nell’andamento che appare didascalico/informativo, tendenza che viene fuori dall’utilizzo del verbo indicativo, il tempo della certezza. L’uomo è per la De Luca il seme: l’uomo è terra (Varrone associava il latino homo con il termine humus) generatrice, piccolo frammento ma di infinita potenza, per citare il testo di Mario Luzi. E così come nel testo del poeta toscano l’uomo e il seme, nella loro fragilità e nella loro finitezza, possono dare nuovo nascimento, anzi proprio in virtù di esse.
Ma il testo Nuovo dualismo, che già abbiamo citato, ci può venire incontro per altre e corpose questioni che investono la poesia della De Luca. Siamo, come detto, in apertura della raccolta Radere Litora, all’inizio dunque di un itinerario poetico e vitale al contempo. Attraverso questo viaggio sapienziale Amalia De Luca si vuole allacciare al percorso letterario, italiano ed europeo, che racconta del rapporto tra l’uomo e le cose così come tracciato nel secolo scorso. Ora, il titolo di questa prima lirica potrebbe richiamare ad un testo chiave della nostra letteratura, Dualismo di Arrigo Boito, ascrivibile a quel movimento noto come Scapigliatura che della crisi poetica e vitale fu certo anticipatore. Probabilmente della poetica scapigliata in Amalia De Luca se ci sono echi essi appaiono comunque lontani, ma due aspetti interessanti possiamo mettere in evidenza: il primo è già insito nel titolo del brano di Arrigo Boito e richiama al carattere “doppio” del poeta, farfalla e verme immondo, angelo e demone, luce ed ombra: è la condizione moderna del poeta e dell’intellettuale capace di sentire il mondo più di ogni altro essere umano, ma così troppo fagocitato dal mondo stesso che è spesso vile, fango, putrido. Nella poesia della De Luca il “doppio” lo si può riscontrare nell’impianto dialettico che attraversa tutta la silloge poetica come messo ancora in evidenza da Pietro Mazzamuto nell’introduzione alla silloge: «tale filosofia, di tipo dialettico, in virtù del suo impianto esistenzialistico, non si irrigidisce e non rimane nella sua superiore aristocratica dimensione, ma s’incarna, diviene tutt’uno con l’intero ritmo tematico ed espressivo della scrittura». Sullo stesso piano interpretativo il già citato Antonino De Rosalia che bene evidenzia questo tratto della poesia di Amalia De Luca: «agisce dunque, in questo vasto e variegato mondo poetico, un costante intrecciarsi di opposizioni più o meno marcate, riflesso di quei contrasti di cui è fatta la vita dell’uomo e che la nostra poetessa vive intensamente e configura in forme ben definite, abbastanza agevolmente fruibili dai lettori, soprattutto in virtù del suo linguaggio, sempre adeguato ai vari livelli del “contenuto”, non involuto né sperimentalistico neanche quando il tono si innalza, e che da quei contrasti, nonché dal loro possibile comporsi, mutua una impostazione spesso dualistica sempre dialettica, resa evidente dall’intervento degli ossimori e, per converso, dalle calibrate eppure spontanee sinestesie».
La discordia degli elementi, per così dire, è alla base della riflessione della poetessa e il dualismo potrebbe proprio riferirsi a questo, e il poeta sarebbe lo specchio entro cui questa opposizione è inscritta: lo scrittore, technites della parola intesa come verità, riflette già nella sua natura l’opposizione insita nel mondo. E a maggior ragione questo accade nel secolo della crisi, in cui la magnificenza della poesia viene se non negata messa in un angolo a scapito del trionfo della folla e della civiltà industriale.
Ma ciò che è interessante notare è che come Dualismo di Boito sia un testo che programmaticamente apre per certi versi l’idea della crisi attraverso un percorso che, passando dai crepuscolari arriverà certamente a Montale, Nuovo Dualismo apre l’iter filosofico, poetico, esistenziale di Amalia De Luca, come se questa condizione dell’uomo/poeta sia il fondamento da cui partire. Ma ancora un aspetto può farci mettere in correlazione le due poesie, l’anelito all’infinito. Nella poesia di Amalia De Luca la ricerca di infinito è spesso conclamata, quasi fosse una «tentazione», e spesso associata alla visione del mare, su cui torneremo. Il desiderio di infinito nasce proprio e in misura maggiore quando esso viene negato «sulla strada sbarrata da siepi irti di spini», così come nella poesia scapigliata di Boito viene urlato: «Dio ci aiuti, o Giovanni, egli ci diede/stretto l’orizzonte e sterminate le ali». Il mondo attorno, polveroso e commerciale, è il panorama entro cui si inscrive la poesia nel Novecento, ma le ali del poeta rimangono sempre sterminate, capaci di essere infinite. Si tratta di un testo che urla il desiderio, la brama di esserci e di non spegnere nel cuore il fuoco della vita. Tutto questo, in toni ora dimessi ora più eclatanti, è presente anche nella Nostra poetessa che parla di «desiderio disperato di vita e d’amore» e che potremmo ricollegare a quella “perfezione dell’appartenenza”, alla ricerca della stessa, che è il leit motiv del nostro studio.
Ma adesso proviamo a trovare uno degli elementi chiave attraverso cui la De Luca si avvicina al miracolo dell’appartenenza, alla percezione di essere, come quel seme di cui sopra, parte di un tutto. Ma partiamo dalla negazione di essa, che spesso troviamo anche nella De Luca, facendo nostre alcune parole di Eugenio Montale, autore che la nostra poetessa chiama spesso in causa, con citazioni più o meno evidenti, ma a volte assolutamente lampanti. Montale nel 1951 scriveva: «L’argomento della mia poesia (e credo di ogni possibile poesia) è la condizione umana in sé considerata; non questo o quello avvenimento storico. Ciò non significa estraniarsi da quanto avviene nel mondo; significa solo coscienza, e volontà, di non scambiare l’essenziale col transitorio. Non sono stato indifferente a quanto è accaduto negli ultimi trent’anni; ma non posso dire che se i fatti fossero stati diversi anche la mia poesia avrebbe avuto un volto totalmente diverso. Un artista porta in sé un particolare atteggiamento di fronte alla vita e una certa attitudine formale a interpretarla secondo schemi che gli sono propri. Avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia».
Questo è il Montale che troviamo nel corso della sua intera produzione e si tratta di una condizione che in Amalia De Luca possiamo riscontrare in diversi testi in cui sembra negata proprio la possibilità di una via da seguire. Così si può leggere di una continua “lacerazione” esistenziale di cui il brusio di insetti ne costituisce il correlativo oggettivo:
Una lacerazione rinnovata
da un brusio d’insetti
affamati di lordura
non è garrulo volo
di uccelli a primavera,
non è allegria di campane:
preclusa è la via
sbarrata da ceppi
sottratti al fuoco dell’amore.
Ma come accade spesso in Montale, soprattutto in Ossi di seppia, delle epifanie sono possibili e spesso si associano all’idea del mare che può divenire il luogo dell’adesione panica per l’uomo poeta che nella polvere del secolo sembra escluso dalla natura. Come ben sappiamo la poetica di Montale, soprattutto in questa prima raccolta, rappresenta un “attraversamento”, sia tematico che formale di D’Annunzio, autore che aveva invece affermato a gran voce la sua adesione piena e totale con il tutto, con quella natura, intesa come eterno fieri, da cui il poeta novecentesco sembra escluso. Ecco, Amalia De Luca sembra voler seguire le orme del Montale di Ossi di seppia, provando ad estremizzare proprio i lati più fervidamente positivi. Il mare e in genere l’elemento acqua assumono in Amalia De Luca questo ruolo che contrasta con la lacerazione e la disarmonia sia del secolo che della condizione umana tout court.
Uno dei testi più “montaliani” ci appare goccia dopo goccia, che qui riportiamo:
Goccia dopo goccia
distillano lacrime
i tuoi occhi
che non hanno colto
in un rivolo
in un lago
in un fiume impetuoso
senso e valore del tempo
accecati da lampi
di desiderio disperato
di vita e d’amore.
Ora invano la luce
della verità
spinge a ritroso
ma è senza eco
questa tua voce
chitarra scordata
il tuo canto.
Il testo ci appare vicino alla lirica del poeta ligure per una serie di motivi. Formali innanzitutto, se seguiamo quanto di Montale scrive Giorgio Zampa nell’introduzione alla raccolta di tutte le sue poesie, quando afferma che il linguaggio che incontriamo è contrassegnato dalla secchezza delle formule che, nella loro concisione, rischiano a volte l’oscurità. Un aspetto che già abbiamo ravvisato nella poesia di Amalia De Luca che tende spesso ad isolare versi brevi, monosillabi addirittura: sembra quasi, per l’appunto, che ogni verso generi una sorta di sentenza, una formula. Ritorna l’eco del cuore montaliano come strumento scordato, ritorna anche nella De Luca quel simbolismo negativo che è tipico del poeta ligure e che nella poetessa palermitana troviamo espresso nel quasi omonimo testo dal titolo Non chiedermi.
Questo richiamo a Montale è assolutamente evidente e lo stridore con il mondo è forte e sentito, ma del poeta ligure la De Luca vuole accogliere anche il momento epifanico, dicevamo, che può essere nel mare, nell’elemento liquido in genere e nella forza dell’amore (pensiamo anche al ruolo della donna salvifica in Montale). Il desiderio di vita e d’amore è espresso ed è certamente non casuale che i due termini, vita e amore, vengano affiancati nello stesso verso in una sorta di chiara e lampante dittologia sinonimica che vuole rapire estaticamente il lettore; e non è un caso che l’unico segno di interpunzione si trovi proprio al termine di questo verso, come ad indicare che i due termini siano un punto fermo e stabile nella dilacerazione temporale espressa.
Ma il testo che vogliamo portare ad esempio del nostro discorso è Repagula, termine latino che indica il chiavistello, una sbarra, una chiusura, ma che potrebbe rimandare anche all’apertura dello stesso. Lo indichiamo, infatti, proprio come la chiave del nostro percorso:
Sull’asfalto bagnato
piove piove
il muro antico si spoglia
il manto verde nel fango
è calpestato da tutti;
la pioggia lava
riconnette le pietre
offese dalle intemperie;
ora il muro asciutto
deterso e solido
attende la nuova primavera:
foglie e foglie
sempre più verdi
che gli ridiano
lo splendore d’un tempo.
In questo testo può trovare esito quanto dicevamo: ossia che Amalia De Luca ha accolto una tradizione che almeno da fine ‘800 è giunta fino a Montale e ha tentato, senza negarla ma inglobandola, di rinnovarla attraverso il suo sentire. Un sentire che con sé porta echi diversi, in cui possiamo leggervi la voglia di eterno di Emily Dickinson, la ricerca della parola perfetta di Cristina Campo, nel tentativo di renderla luogo di bellezza: echi che divengono, come espresso da Oliver Friggieri, sensibilità «di stampo universale, esistenziale, intesa come dialogo affettuoso con una figura ideale e anche come riflessione sull’essere quotidiano in sé poi già tradotto in paradigma di una realtà in sé sempre speciale, irripetibile, unica sotto tutti i profili. Così il quotidiano diventa poetico, un microcosmo completo».
Tutto ciò avviene in questa poesia dove scorgiamo il muro di Montale, segno di dissonanza, emblema della “chitarra scordata”, correlativo di un secolo che sa di lordura ed estraneità. Ma nella pioggia le pietre possono ri–connettersi con il mondo, il muro dopo l’incontro con l’elemento naturale, forse inaspettato, può attendere nuova primavera, nuova rinascita, nuovo confronto di verità; come avveniva in Montale, l’incontro epifanico con l’elemento naturale può apparire inaspettato, dicevamo, forse casuale, ma non per questo meno latore di autenticità e pienezza vitale, ultimo esito della ricerca della poesia di Amalia De Luca e, forse, di ogni poesia.
Che l’acqua, soprattutto quella marina, sia elemento di autenticità panica, viene espresso da Amalia De Luca stessa nella nota che scrive in seguito alla pubblicazione della sua prima raccolta, quando così si esprime: «questa breve nota è motivata dal desiderio di spiegare il mio lungo silenzio. In effetti scrivo da sempre, da quando bambina indirizzavo lunghe lettere a mio padre che era militare durante la seconda guerra mondiale o quando raccontavo al mare che non mi stancavo mai di guardare».
Il mare è personaggio fidato cui rivolgersi, è, nella poesia Mongerbino, immagine di infinito, tanto che il suo nome originale può anche essere taciuto.
Sulle sponde dell’infinito
amanti di pietra
sostate
breve, additando ai passanti,
il cammino dell’amore
Il mare diventa, in Ustica, elemento che può fungere da concordia degli elementi, da raffigurazione concreta e immediata di quella “perfezione dell’appartenenza” tanto agognata:
Non più
separazione e dolore,
albe e tramonti
nell’isola antica.
Nella dilatazione dell’anima
la folgorazione d’infinito
l’eternità dell’essere.
Nel divino silenzio
la consapevolezza
della contraddizione:
il sole s’inabissa
all’orizzonte
le ombre grigie della sera
scivolano
sul blu cobalto del mare.
Il termine ‘mare’ che conclude la lirica suggella in modo perentorio un percorso che è quasi di formazione. La contraddizione è della natura umana, ma è nella consapevolezza di essa che quella fragilità di cui abbiamo parlato precedentemente può divenire sinonimo di presenza, di legame, di adesione. L’architettura poetica del testo, ancora una volta, ci informa del piano semantico delle parole se notiamo come ‘anima’, ‘infinito’ e ‘essere’ vengano posti in tre versi consecutivi e sempre alla fine, come a dialogare tra di loro, come a co–rispondersi e legarsi in un unico significato esistenziale.
La ricerca di una co–rispondenza tra anima e natura è elemento chiave presente nell’intera raccolta della De Luca, ma che viene forse maggiormente fuori nelle ultime liriche, quelle da leggersi in senso più mitico/simbolico o allegorico se non addirittura in chiave metafisica. Vi si legge sempre questa continua tendenza nella ricerca di una identità che, come abbiamo visto, la lordura dei tempi sembra negare; continuiamo ad assistere ad un «viaggio tormentato», possiamo ancora scorgere momenti di apatia vitale, di impossibilità di «avvertire dolore o desiderio», questi ultimi emozioni e sentimenti che possono dare la misura dell’essere vivi. Ma, come nelle raccolte e nelle liriche più antiche, vi è sempre la ricerca di uno spiraglio di luce, di un «varco» che verrà pian piano sempre più assumendo la forma di un “oltre” inteso in senso temporale, spaziale o, dicevamo, addirittura metafisico.
‘Oltre’ da intendersi, dunque, sotto diverse accezioni, diversi aspetti e differenti punti di vista: non è certamente un caso il titolo Policromie dell’oltre, nella cui prefazione Salvatore Lo Bue mette in luce alcune caratteristiche che la De Luca rinnova, mantenendone viva la forza, nella sua poesia. In particolare evidenzia quel legame ricercato con la Natura che abbiamo messo in evidenza nel nostro lavoro e che si esplica nell’immagine del mare infinito: «Inestricabile, in questo viaggio in trenta stazioni, il rapporto tra Anima e Natura: l’una si riflette nell’altra in una misteriosa relazione che attinge le radici nel mistero stesso della vita». Ma lo studioso palermitano non può non far notare come ancora una volta sia nella parola la ricerca di assoluto, perché è essa che simboleggia la vittoria sulla finitezza umana; e l’oltre che Lo Bue disvela nella poesia della De Luca appartiene alla poesia stessa, “mondo” in cui può confluire questa compenetrazione tra natura e vita: «L’infinito dell’anima assume le forme della distesa stellata del cielo, dell’oceano, del silenzio, anche se scogli rocciosi e macigni gravosi pesano sul cuore. Ma la poesia è sempre oltre il dolore, oltre la storia della vita, oltre il tormento, oltre il tempo, oltre le stesse parole».
La poesia diventa, così, recupero di quell’innocenza che anche attraverso le parole di Quasimodo abbiamo associato alla “imitazione della gioia”, alla piena riscoperta del sé. Innocenza che ci riporta indietro, ai ricordi, agli anni della giovinezza vissuti sempre nostalgicamente e come “luogo” primigenio, archetipico da recuperare. Aspetto che può venir fuori – perché esplicitamente richiamato – in Carmina pervia, il cui sottotitolo recita Olim et nunc, ‘un tempo e adesso’, termini quasi diatribici e che Giuseppe Bagnasco bene interpreta: «la poetessa lo fa partendo da quell’OLIM, un periodo fatto di ricordi giovanili e d’amori dove, come sempre, in un delirio d’onnipotenza, la gioventù si crede immortale e capace di raggiungere quell’orizzonte dei sogni dove può “gettare la rete” dei suoi progetti. Il tutto in contrapposizione a quel NUNC dove alberga la delusione e il dolore d’esistere e dove si fa assillante la percezione della fine del proprio tempo. Una sensazione che però viene mitigata dall’emergere di quell’attesa che, al di là di quell’oppressivo orizzonte, dia asilo a quell’ “Oltre” salvifico e un senso compiuto al cammino umano». E il recupero del passato avviene non soltanto a livello esperienziale, ma anche e soprattutto mitico. Il ricorso alla mitologia appare proprio un porto sicuro di innocenza, di sguardo virgineo, puro e per questo più profondo sulle cose. Il mito diventa, nella poesia della De Luca, «un luogo dell’anima», scrive Sandro Gros–Pietro, «una rappresentazione edenica fuori del tempo in cui si placano le polveri della quotidianità e le tensioni dell’effimero, ed agli occhi si appalesano le visioni che saziano o quanto meno che sospendono le arsure interne, i rovelli clandestini, gli enigmi irrisolvibili; un luogo dell’evocazione della memoria, declinazioni di nostalgie domestiche e famigliari del poeta che si innestano nel tempo indeterminato, sempre uguale a se stesso, della cosmica famiglia dell’umanità, un unico modo di sentire e comune a tutte le genti di tutti i tempi, che è una delle più grandi astrazioni di assoluto mai contemplate in quell’isola d’Utopia che ci occupa il cuore e la mente».
Ricerca dell’oltre, dunque, che pian piano prende forma e che si sostanzia in quella linea di Kàrmàn che dà il titolo ad una raccolta dai corposi e folti significati, se pensiamo che scientificamente stiamo parlando della demarcazione tra atmosfera terrestre e spazio esterno, ma che nella nota al libro viene definita “attesa del transito all’altra vita”. L’oltre dunque si scioglie e si sostanzia, come dicevamo, nel metafisico. Una raccolta per certi aspetti diversa rispetto alle precedenti, forse più onirica, che prova ad addentrarsi nel sogno e nell’inconscio, in un ordine temporale che è più della mente che non del corpo. Lo spazio entro cui la poetessa si muove sembra quasi intangibile, anche se a dire il vero non mancano tanti e diversi spunti più concreti, per così dire. Ma l’atmosfera generale è più improntata al vago e al volutamente incerto o errabondo. Si legga questa lirica, l’ottava della raccolta. Si noti che le poesie non recano titolo, strategia che assicura un carattere ancora più indefinito e che inoltre accresce la dialogicità tra un testo e l’altro.
È luce che abbaglia
improvviso
il pensiero in fuga
di un sogno d’amore.
Tacito
non sosta nello spazio
di una speranza
inviolata.
Fugge incredulo
nel buio fitto della notte
legato e bendato
l’anelito del cuore.
Lo stile si fa ancora più diafano, se vogliamo, i termini utilizzati rimandano ad entità eteree o astratte: luce, fuga, sogno, amore, speranza, buio, anelito. Anche Salvatore Zarcone evidenzia come l’intera produzione di Amalia De Luca sia «una poesia rarefatta in cui domina sostanzialmente uno spazio che potremmo definire metafisico, quasi uno spazio liminare, una sorta di soglia con il mistero, con l’aldilà». E questo aspetto nella suddetta raccolta, Oltre la linea di Kàrmàn, è assolutamente evidente e preponderante e funge quasi da sintesi esistenziale in questa ricerca del sé che è un po’ il fil rouge dell’intero sistema filosofico della De Luca. La linea di Kàrmàn è, come dicevamo, una cerniera, un limite tra terrestre e spazio esterno: in questa silloge funge da specchio di quella dialettica vitale che abbiamo messo in luce, forse da spazio catalizzatore, da tramite e porta verso l’assoluto. Assoluto, da intendersi ancora una volta etimologicamente, come ab–solutus, sciolto da vincoli e legami. In questo ultimo termine può sciogliersi il significato del testo sopra proposto, dove l’anelito del cuore è ancora “legato”, per l’appunto, non pronto a spiccare il volo come «farfalla estranea alla fiamma». Ma la piena libertà è probabilmente, come spesso accade e come abbiamo avuto modo di mettere in luce, nella consapevolezza del proprio carattere finito: il tempo e lo spazio si possono misurare, agostinianamente, nel sé profondo ed è in questo abisso interiore che può avvenire l’epifania dell’incontro con la Natura naturans, con l’oltre, con il cosmo, con il divino, come avviene in un brano tratto proprio da Policromie dell’oltre, in cui così si può leggere:
Ora nel guscio d’una lumaca
nel silenzio della natura
che dorme e tace io vivo;
solo la dolce armonia
dell’universo
culla i miei pensieri
quando i petali
dischiusi di una rosa
ricoprono il mio corpo
umidi di rugiada. […]
Il primo verso sembra richiamare il guscio di noce di W. Shakespeare: «potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e tuttavia ritenermi re di uno spazio infinito». Lo spazio attorno è stretto, angosciante, ma la “nuova” avvedutezza della De Luca, nella ricerca del suo oltre, è che la libertà panica abita all’interno del sé. Lo spazio della modernità, così tipicamente novecentesco e che abbiamo indicato come il motore della riflessione, viene ribaltato di significato con una antanaclasi semantica roboante atta ad affermare la grandezza dell’anima, altro termine che etimologicamente richiama al vento e alla libertà. La linea di Kàrmàn diviene così spazio da oltre–passare con e in virtù della propria anima e, come sempre, in virtù della voce poetica. Solo così l’oltre può divenire non solo sognato, ma addirittura può assumere concretezza e come scrive e si chiede Pierfranco Bruni nella prefazione a Carmina pervia, «Siamo infiniti o siamo nell’alba del limite? Restiamo gli eredi di un limite che conosciamo come oltre». Scegliamo così questo testo come culmine:
Se una voce
buca il mio silenzio
splende improvvisa
la gioia di vivere
la tenerezza
invade il cuore
la serenità
si posa sui miei ricordi.
La voce che sento
alimenta tutti i miei sogni
la speranza
pervade il mio spirito
il sogno
s’impadronisce d’ogni forma
vivente.
Acquista senso la vita
e l’oltre diventa certezza.
La perfezione non sta dunque nella certezza della propria forza, ma proprio nella persuasione del proprio carattere finito o de–finito, dei nostri confini e limiti, della consapevolezza di trovarsi nel guscio di una lumaca. Se la vita dell’uomo è assimilabile a quella di un fiume (si veda la poesia Panorama), è nel suo scorrere la vera essenza, nonostante «pietre e dirupi», nonostante «gli ostacoli che trascina a valle».
Come quel fiume Amalia De Luca ha trasportato con sé, a valle della sua vita, ogni singolo attimo di dolore e ogni frammento di gioia, ha reso propria la disarmonia con il mondo fino a rendere quella dissonanza essenza stessa e prova concreta del suo essere e stare in questo mondo. Come quel fiume, ha raccolto mesi e anni di sguardi, ha toccato mani e sorrisi, ha asciugato lacrime e ascoltato palpitazioni con una certezza, che alla fine di quel suo scorrere, abbandonando tutto, si potrà versare, panicamente, autenticamente, nell’infinito del mare, oltre il proprio limite, oltre la propria natura, oltre lo spazio e il tempo finiti. Oltre.