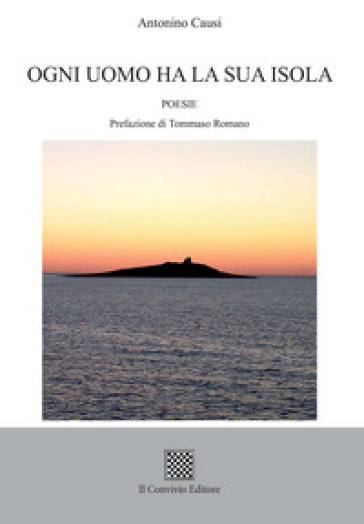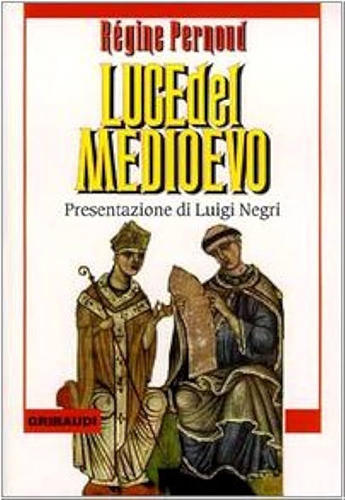“Antonino Uccello e le voci dal carcere” di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 08 Aprile 2023
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1314
 Circa un secolo fa (1922) nasceva da umile famiglia a Canicattini Bagni (SR) Antonino Uccello. Maestro elementare e etnoantropologo per passione, Uccello spese i suoi giorni (Sentivo -dice- di salvare parte delle nostre reliquie, della nostra vita, parte del patrimonio della nostra civiltà) per raccogliere, conservare, tramandare quante più testimonianze poteva del mondo popolare e contadino siciliano, concentrando i suoi sforzi nella realizzazione della Casa-Museo di Palazzolo Acreide inaugurata nel 1971. Elaborò anche studi documentari e sillogi poetiche della cultura popolare: dal 1959, quando pubblicò Canti del Val di Noto (raccolti fra il 1945 e il 1959), al 1980 anno di stampa del suo libro postumo Cultura casearia in Sicilia. Nel 1961 per il centenario dell’Unità d‘Italia era uscita la raccolta Risorgimento e società nei canti popolari siciliani, un Risorgimento visto dal basso fra grandi attese e grandi delusioni, seguita nel 1965 da un altro studio: Carcere e mafia nei canti popolari siciliani. Nel volume Le pietre di Pantalica (1988) Vincenzo Consolo, nel capitolo La casa di Icaro, con esplicito riferimento sia al titolo del memoriale postumo dello stesso Uccello, sia al simbolo della Casa-Museo, un uomo-uccello dalle ali aperte, lo definisce cantore e predatore di memorie, di reliquie di un mondo trapassato di fatica e di dolore, vero, umano, per il quale -sottolinea Consolo- Uccello non nutriva nostalgia, ma desiderio, speranza di riscatto. Tale desiderio/speranza di riscatto nel libro del 1965 si coglie più che nel contenuto specifico di qualche canto di carcerato, nelle osservazioni sparse che lo studioso viene facendo su singole figure di suoi “informatori”, relazionati al loro ambiente di appartenenza, e sui contesti paesani, in cui effettuò le sue registrazioni. La raccolta Carcere e mafia…è costruita infatti non solo su Canti di carcerati dell’800 tramandati da Vigo, Salomone Marino, Pitrè, Corrado Avolio, Serafino Amabile Guastella, ma anche su quelli raccolti, soprattutto fra il 1960 e il 1963, dallo stesso Uccello, col supporto tecnico-logistico del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare dell’Accademia di Santa Cecilia, nei territori di Partinico, Balestrate, Montelepre, Roccamena, Riesi, Canicattì, Enna, Delia, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e nel penitenziario di Noto (SR), e su Canti registrati nel 1954 dal CNSMP a Palma di Montechiaro (Agrigento), a Naro (Agrigento), a Giarratana (Ragusa), a Sortino (Siracusa). Secondo un percorso cronologico e una distribuzione territoriale -come si vede- che consente di cogliere diffusione e persistenza di tematiche, ma anche trasformazioni e sfilacciamenti dei contenuti, sempre più ripetitivi alla fine e accozzati per inerzia (talora senza interna coerenza) già alle soglie degli anni ’60, in concomitanza col mutamento dei costumi, con l’abbandono delle campagne (le difficoltà ad esempio di alcuni informatori a ricordare i testi, dato che non si cantavano più) e per l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa (Radio, Televisione) che venivano erodendo l’ancestrale condivisa memoria collettiva. I Canti, in qualche zona detti rô carcirateddu, con un vezzeggiativo -precisa Uccello- che esprime[va] la solidale pietà del popolo verso i reclusi, gli erano dettati o cantati da carcerati e ex-carcerati che li avevano appresi in prigione, oppure da informatori che li avevano sentiti cantare o dalla ciurma dei braccianti durante i lavori agricoli (mietitura, semina, potatura, raccolta delle olive, mandorle, agrumi), o dai carrettieri, nei tempi passati sempre in viaggio da un paese all’altro o in sosta di notte nei fondaci. “Informatori” a volte erano gli stessi carrettieri (u jazzu [giaciglio] miu -dice uno- era ammienzu ô stratuni [stradale]), e pure le donne, che li avevano cantati a loro volta nei campi lavorando, o li avevano uditi intonare anche dai muratori nel loro quartiere. Una trasmissione orale fitta, continua, che si colorava di cadenze e timbri diversificati -informa Uccello- a seconda che i canti venissero eseguiti â vicariota (alla maniera del carcere), â carrittera (alla maniera dei carrettieri), â campagnola (come i contadini), â bacchittiota (alternando e incrociando le voci: uno facendo l’attacco col primo distico, altri l’accordo coro, un altro il secondo distico, e via dicendo…). Durante le registrazioni alcuni però si rifiutavano di cantare e si limitavano a dettare, cambiando talora qualche particolare per diffidenza, per paura… sebbene i testi selezionati e riportati dallo studioso non appaiano compromettenti e abbiano risvolti politici piuttosto radi. Quanto ad alcuni dei paesi sopra elencati, Uccello citando la documentazione di Danilo Dolci circa le zone a maggiore densità di banditismo e illegalità, rimarca l’analfabetismo diffuso o il bassissimo livello di scolarizzazione, con bambini sfruttati già a 5/6 anni, l’incuria delle amministrazioni locali per la manutenzione (scalinate di immondizia), il controllo mafioso, la crisi delle zolfare e delle piccole rendite contadine, con conseguente emigrazione in Belgio, Venezuela, Canada, Usa, o verso le città del Nord Italia, o verso l’area industriale di Priolo/Melilli. Indicativo del disagio e della rabbia delle classi popolari si rivela l’episodio di un giovane venticinquenne, totalmente renitente a collaborare con l’autore, il quale raccontava di essere stato costretto a rubare fin da bambino verdure e legumi per la fame, e di essere stato arrestato (in quegli anni ’60!) per avere sgozzato per sfregio delle galline, pulendosi poi le mani insanguinate con il certificato elettorale. Umori simili, espressione della situazione economica e sociale degli anni del secondo dopoguerra e del disappunto per le promesse fatte al popolo dai politici e disattese dopo il voto del 1948, e anche per le vane inchieste parlamentari sulla mafia, trapelano da qualche testo scritto da alcuni carcerati rinchiusi a Noto, o dal distico di un informatore di Riesi, dettati tutti a Uccello per così dire “a denti stretti”, tipo: u populu vutau soddisfattu,/ cridennu… d’aviri assicuratu lu so piattu/… Ma si cc’è statu quacchi saccu chinu,/ lu populu l’ha vistu di luntanu./ Ccu-cciarli e mbrogli iru a lu putiri:/ semu rridotti tutti a lu suffriri… con annessa denuncia per l’incapacità/non-volontà di scendere alla radice dei problemi: La cammira delli Dibbutati si pripara/ per livari la mafia ura ppi ura:/ cerca di sparagnarli (risparmiare i miserabili) di la lupara/ pi-ppurtarli n-calera, in-zipurtura (nella sepoltura)…o per l’inefficienza/corruzione di certa giustizia: Staiu viniennu di Cartanissetta,/ vaiu diciennu cca la liggi è-ttorta. Nei Canti tuttavia antologizzati da Uccello prevalgono gli aspetti psicologici della dura condizione dei carcerati, e gli elementi storico-sociali restano sullo sfondo o affiorano a flash intermittenti. Aprono il libro alcune ottave date al Vigo da Francesco De Felice, da lui raccolte a metà Ottocento nella Cittadella di Messina, dove erano reclusi insieme delinquenti comuni e patrioti della rivoluzione del 1848. Uno di loro vorrebbe liberare dalla comune sventura politica se stesso e la madre, e si conforta al pensiero che la riscossa finale è vicina: Lu to nimicu, ch’è nimicu a mia/ trema di scantu ca vicina è l’ura, e lui non vorrebbe essere nella pelle di quello. Chiede anche alla madre, con forte nostalgia della propria casa, di non essere “abbandonato”: Quannu vennu li festi principali (Natale e Pasqua),/ matruzza, ricurdativi di mia. Un altro invece canta la monotonia dei giorni in quella fossa tinibrusa e ria:/ comu passa l’està, passa l’invernu e maledice il sole alto nel cielo, la luna e tutti gli elementi naturali e il loro creatore, dicendo che la sua gran pena è superiore a quella dei dannati nell’inferno. Un altro ancora ironizza, invece, sulla Vicaria nova (l’Ucciardone) chiusa da un bastione: Scì, quant’è bedda la vicarìa nova!.../ li finistreddi ca dunanu fora,/ ammenzu li surdati e li cannuna. / Cu’ la vidi di fora s’innamura/ ma cu c’è dintra perdi la palora. Protesta che torna anche in canti riferiti da Pitrè e da Vigo: Tempu di stati ci coci lu suli,/ tempu di ‘nvernu nun si cci po’ stari, vicarìa dove nei primi tempi per mancanza di impianto idrico, i detenuti arraggia[vanu] di siti e chiedevano acqua alla madre: Lu manciari a la casa mi faciti,/ ccu me fratuzzu nicu lu mannati,/ na quartaredda d’acqua ci mittiti… I luoghi descritti sono cupi: grate interne e esterne, celle buie, umide, o sotterranee come gli antichi, famigerati dammusi (Ch’è friddu stu dammusu! E’ comu un gniazzu [covile] ca acqua spanni di tutti li mura), e da un testo all’altro, che veniva portato e cantato da un carcere all’altro, a emblema di una condizione che era generale e immobile, si ripetono i versi (spesso fra loro intercambiabili) sulle terribili prigioni di Favignana e di Bagnara (dove non si vedono né suli né luna, non si odono né roggiu [orologio] né campana, ma solo scrusciu ri catina), di Sciacca e di Noto (ccu trasi câ palora, nesci mutu, oppure li vai [guai] li trova) e sulla peggiore di tutti: San Vito (Agrigento) nfernu addumatu, cani arraggiatu. E la predestinazione al carcere per il reo vero o presunto suonava come sarcastico avviso sul cartello affisso al carcere di Palermo: curri quantu vuoi ca ccà t’aspiettu. Nell’animo del condannato si agitano nostalgie, ricordi, invocazioni, autocompianto (l’amaru, lu sbinturatu, cunigghieddu preso al laccio), autoironia, odio, accuse a se stesso o agli altri, minacce (pioggia di pallottole, lampo di scupetta…) e arrogante braveggiare mafioso. E si può seguire l’evoluzione degli istituti giuridici nel tempo nel relazionarsi dei detenuti prima con i centarmi (gendarmi), il capitano di giustizia, la Ccillenza titolata, poi con li carrabbuneri, lu bbriateri, lu custuri (il questore)….ma fissi restano i termini sbirru e nfami (sbirrazzu, nfamazzu, nfamuni) per bollare il delatore/spia e ogni rappresentante dello Stato (guardia, giudice). Un carcerato catanese chiuso a Favignana da 11 anni più che dei quartieri suoi della Rotonda e del Tindaro (me spassu e sbiju) ha nostalgia della festa di S. Agata; il poeta popolare Giuseppe Bonafede carcerato innocente per l’astio di un deputato locale pensa ai figli e con intensità poetica paragona il suo cuore che svolazza fra le sbarre della cella a una passaredda cui hanno rubato il nido e lo cerca campagna campagna la cura all’aria e l’aluzzi a lu ventu. Domina nei testi il ricordo della madre (cara matri, mamma, mammuzza mia) alla quale si chiede la benedizione, o la preghiera (forsi pri vui pirdunassiru a mia), e il carcerato ora soffre perché ha vanificato affetto e sacrifici della madre che sarebbe stato meglio avesse abortito, ora si autoaccusa (testa traritura, testa maliditta) per non averla ascoltata e la vede piangere e invocarlo (figliu pirdutu/ nun la pigliari no, ssa mala via… figliu pirdutu di la casa mia), ora invece la accusa, perché non lo ha saputo educare (si-ffrinautu a mmìa/ eu nti stu carciri ’un ci finìa) e vorrebbe darle na vasatedda/morso. Formula stereotipa ricorrente è invece l’invito all’Angelo di Dio, che con le ali può rompere le porte, a consegnare alla matri la lettera del figlio che cci rici ca nun scrivi a-nnudda parti/ pirchì lu prisirenti -viene spiegato- mi cunnanna a-mmorti. Quanto alla donna amata, il carcerato sfoga con lei le pene intime e fisiche, o le dice che non la dimenticherà; talora sogna che quella con le sue manuzzi apra le porte del carcere, o mentre con le lacrime attassa (avvelena) le pietre della cella, le canta il suo amore: bella, talìu cuomu si’ cumposta,/ squaglia la carni mia cuomu la cira,/ lu to curuzzu senza fuocu adduma, innalzandosi qualche autore a volte a immagini tragiche e toccanti per l’intensità del dolore e del desiderio, quali: cc’eni na ronna nna la tramuntana/ la testa si la runa mura mura, oppure: l’urtimu abbrazzu è chistu di la morti:/ e siddu ungniornu ti viegnu a disiu/ votati (voltati): sugnu l’ummira (sono l’ombra) ca puorti. Ma per l’amanti che ha tradito il suo uomo recluso ci sono solo rabbia, odio violento, accusa (tinta carogna, nun è vapparìa) e promessa di vendetta (il coltello, friscu ammulatu/ c’appena nèsciu cci àggiu a-ffà u tabbutu [la bara]). Uno invece chiama i diavoli, che abitano nelle viscere dell’Etna, a partecipare a una singolare jurnata lavorativa per vuscari na bona manciata: devono i diavoli portare incudine e martello, e dare colpi a beddu a beddu (piano piano) senza fari nissuna rimurata, per aprire le porte d’u Casteddu (il carcere di Noto) e fare uscire -dice- l’amanti mia ca è carzarata. Altre volte è la donna che agisce. O prega: Matri Sant’Anna mia, vecchia putenti,/ Turiddu è nnucenti, e-ll’aviti âiutà; o soffre, perché con il suo uomo carcerato parrari ccu la bbucca nun putimu/ e-mmancu fari nzinca ccu la manu, ma quando si rivedranno, è pronta a emigrare con lui; o fieramente trionfa dell’avere ucciso il traditore e recuperato l’onore: Muori, e-mmuristi, nfami e-ttrarituri!/ Ora ca tu ha murutu/ m’arricupuru l’anuri. Signuri e-mmarasciallu… tiniti a rivoltella/ e amuninni m-micarìa (in vicarìa). Non manca l’ironia amara di carcerati e carcerate sul cibo: Poviri carcirati/ ccu-cciciri e ppatati/ li panzi sû aggiggiati (vuote), ma ancora più acre è l’autoironia: la sentinella sta alle costole del detenuto come gli uccelli trampolieri; sua mammuzza sono catene e carcerieri, suo patruzzu il pretore, fratuzzi i carabinieri, amici le grate, cumpari San-Giuvanni il questore che pianta chiodi al condannato. E con più malizia e arguzia uno dice che i carcerieri, per farlo uscire, vorrebbero una statua d’oru del suo peso più un altro quintale, oru che non possiedono né il re né tutti gli argentieri della sua Acireale e un altro, vedendo già schierate truppe e cavalleria per giustiziarlo, commenta che va alla forca cu tanta assistenza! Uccello fornisce esempi anche del tipico linguaggio e costume mafiosi: l’omertà (nun dati cuntu si siti chiamati/ faciti li locchi e li sturduti); il: “tira manu!”, che era la formula dello sfidante nel fronteggiarsi col coltello (a tirata); il “fari vientu” o no, espressione gergale per dire “il confessare” o no al giudice la verità; l’autovantarsi del mafioso: che farà suonare li campani a-mmuortu, o che è un’erba che ntuossica a-ttutti… e-ccu m’agghiutti li fazzu affucari, oppure, nessuno può fargli dispetto (speci), perché -minaccia- di ghiummu ci la pigghiu la misura. Costanti, dominanti e violenti sono poi l’odio, il disprezzo e le fantasie vendicative contro lo sbirrro e l’infame. Nfami è il giudice cui il carcerato non confesserà mai la verità, neanche a colpi di coltello; nfami è la spia che se arriva alla Vicarìa sarà sottoposta dai traditi al cascittuni (la testa ingiù nella cassetta-cesso) o sarà, fuori dal carcere, tagghiatu (sfregiato) a corpa di rasola (rasoio). Lo sbirro è disprezzato. Non è omu, né lupu, equivalente di omu, ma cani pirfettu (appunto “guardia”) e pure da assassinato fa vomitare: Chiddi che si liccaru lu piattu/ dissiru: mamma mia, cca mi rriettu. Uno sbirro/Stato curnutu così persecutorio e oppressivo da andare ad arrestare pure il diavolo nel fuoco dell’inferno: Talìa ch’ardiri stu sbirru curnutu,/ ca si porta un diavulu attaccatu. Molti proclamano vanamente la loro innocenza e formule ricorrenti sono: carciarateddu sugnu… senza fari un centesimu ri ddannu, oppure con icasticità epigrammatica: autri fa dannu, iu cianciu lu piccatu,/ autru ha la curpa, iu la pinitenza! Cosi come ricorrente di bocca in bocca, con carica consolatoria, era la storia vecchia di secoli, pare dal ‘500 circa ma riciclata, con adattamenti, come sempre attuale, del carcerato abile verseggiatore-improvvisatore liberato per questa abilità da sua Eccellenza (duca, conte, giudice…) in visita alle carceri con la moglie: ci rassivu licienza quantu passa,/ pi l’amuri c’aviti a la Duchissa. Se il delinquente abituale fa l’elogio del carcere: casa filici, pararisu, villiggiatura, perché vi trova li frati e l’amici,/ dinari, bon manciari e allegra paci, mentre fuori deve misurarsi con i nemici e se non lavora -dice- moru di miciaci (fame), gli innocenti si sentono invece tremare le reni al suono di chiavi e catene (chi lo “suona” è lu macillaiu ri la carni umana) e, con efficace effetto onomatopeico, per i colpi di mazzuolo delle guardie a ogni avvimmaria sui ferri delle finestre: ferri bbattuti e finestri nsirrati. E in qualche testo c’è la cruda riflessione che il carcere non “corregge” (castìa), insegna anzi con il suo tristo ambiente a delinquere: lu carziri è violu chi vi invia (che instrada)/ chi vi ’nsigna li strati e li purteddi (gli agguati), realtà espressa metaforicamente anche attraverso l’invito ai giudici nfamuna che studiano “la legge” a cercare l’inferno fra i “vecchi carcerati”, sfogliando a una a una le pagine del carcere, pagine di dolore e di scuola del male: truvati deci giuvini assittati,/ ddrà ‘mmienzu cc’è lu masciu di la scola;/ di foglia a foglia lu libbru vutati:/ lu ‘mpiernu (l’inferno) nti li carzari si trova. Perciò la felicità del carcerato che finalmente ne esce, sentendosi rivivere comu na rosa nata all’uortu (orto), è dovuta non solo alla gioia di tornare al paese, ma anche all’essersi finalmente lasciato alle spalle quel luogo d‘amici sbirruna e trarimintusi. Un contesto avvelenato, dove l’aria è satura soprattutto di rabbia e furore di vendetta non solo -come già visto- verso lo sbirro che arresta, spregiativamente, naschiannu comu un cani e rovistando (scaliannu) pure lu fumeri (concime) fina a lu muzzuneddu (brocca rotta) ccu lu sali, ma soprattutto verso quegli amici che hanno tradito e che al momento dell’arresto hanno addirittura festeggiato: si cunzaru la tavula e-mmanciaru/ comu avissiru truvatu lu trisoru, ma il condannato, se camperà e uscirà, sarà per loro come un sirpenti ammilinatu, e se sbaglierà il colpo -grida un recluso- mi tagghiu lu vrazzu,/ iu stissu mi cunnannu mpisu (alla forca) allura! Una disperazione umana e sociale -come si vede- senza redenzione. Ma solo allora? O per tanti “esclusi” anche oggi? Una realtà quella delle carceri, che continua a interrogare la società, e di cui negli anni Sessanta, quanto alla Sicilia, Antonino Uccello volle e seppe vergare un ricco e inquietante documento storico e poetico.
Circa un secolo fa (1922) nasceva da umile famiglia a Canicattini Bagni (SR) Antonino Uccello. Maestro elementare e etnoantropologo per passione, Uccello spese i suoi giorni (Sentivo -dice- di salvare parte delle nostre reliquie, della nostra vita, parte del patrimonio della nostra civiltà) per raccogliere, conservare, tramandare quante più testimonianze poteva del mondo popolare e contadino siciliano, concentrando i suoi sforzi nella realizzazione della Casa-Museo di Palazzolo Acreide inaugurata nel 1971. Elaborò anche studi documentari e sillogi poetiche della cultura popolare: dal 1959, quando pubblicò Canti del Val di Noto (raccolti fra il 1945 e il 1959), al 1980 anno di stampa del suo libro postumo Cultura casearia in Sicilia. Nel 1961 per il centenario dell’Unità d‘Italia era uscita la raccolta Risorgimento e società nei canti popolari siciliani, un Risorgimento visto dal basso fra grandi attese e grandi delusioni, seguita nel 1965 da un altro studio: Carcere e mafia nei canti popolari siciliani. Nel volume Le pietre di Pantalica (1988) Vincenzo Consolo, nel capitolo La casa di Icaro, con esplicito riferimento sia al titolo del memoriale postumo dello stesso Uccello, sia al simbolo della Casa-Museo, un uomo-uccello dalle ali aperte, lo definisce cantore e predatore di memorie, di reliquie di un mondo trapassato di fatica e di dolore, vero, umano, per il quale -sottolinea Consolo- Uccello non nutriva nostalgia, ma desiderio, speranza di riscatto. Tale desiderio/speranza di riscatto nel libro del 1965 si coglie più che nel contenuto specifico di qualche canto di carcerato, nelle osservazioni sparse che lo studioso viene facendo su singole figure di suoi “informatori”, relazionati al loro ambiente di appartenenza, e sui contesti paesani, in cui effettuò le sue registrazioni. La raccolta Carcere e mafia…è costruita infatti non solo su Canti di carcerati dell’800 tramandati da Vigo, Salomone Marino, Pitrè, Corrado Avolio, Serafino Amabile Guastella, ma anche su quelli raccolti, soprattutto fra il 1960 e il 1963, dallo stesso Uccello, col supporto tecnico-logistico del Centro Nazionale Studi di Musica Popolare dell’Accademia di Santa Cecilia, nei territori di Partinico, Balestrate, Montelepre, Roccamena, Riesi, Canicattì, Enna, Delia, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni e nel penitenziario di Noto (SR), e su Canti registrati nel 1954 dal CNSMP a Palma di Montechiaro (Agrigento), a Naro (Agrigento), a Giarratana (Ragusa), a Sortino (Siracusa). Secondo un percorso cronologico e una distribuzione territoriale -come si vede- che consente di cogliere diffusione e persistenza di tematiche, ma anche trasformazioni e sfilacciamenti dei contenuti, sempre più ripetitivi alla fine e accozzati per inerzia (talora senza interna coerenza) già alle soglie degli anni ’60, in concomitanza col mutamento dei costumi, con l’abbandono delle campagne (le difficoltà ad esempio di alcuni informatori a ricordare i testi, dato che non si cantavano più) e per l’influenza dei nuovi mezzi di comunicazione di massa (Radio, Televisione) che venivano erodendo l’ancestrale condivisa memoria collettiva. I Canti, in qualche zona detti rô carcirateddu, con un vezzeggiativo -precisa Uccello- che esprime[va] la solidale pietà del popolo verso i reclusi, gli erano dettati o cantati da carcerati e ex-carcerati che li avevano appresi in prigione, oppure da informatori che li avevano sentiti cantare o dalla ciurma dei braccianti durante i lavori agricoli (mietitura, semina, potatura, raccolta delle olive, mandorle, agrumi), o dai carrettieri, nei tempi passati sempre in viaggio da un paese all’altro o in sosta di notte nei fondaci. “Informatori” a volte erano gli stessi carrettieri (u jazzu [giaciglio] miu -dice uno- era ammienzu ô stratuni [stradale]), e pure le donne, che li avevano cantati a loro volta nei campi lavorando, o li avevano uditi intonare anche dai muratori nel loro quartiere. Una trasmissione orale fitta, continua, che si colorava di cadenze e timbri diversificati -informa Uccello- a seconda che i canti venissero eseguiti â vicariota (alla maniera del carcere), â carrittera (alla maniera dei carrettieri), â campagnola (come i contadini), â bacchittiota (alternando e incrociando le voci: uno facendo l’attacco col primo distico, altri l’accordo coro, un altro il secondo distico, e via dicendo…). Durante le registrazioni alcuni però si rifiutavano di cantare e si limitavano a dettare, cambiando talora qualche particolare per diffidenza, per paura… sebbene i testi selezionati e riportati dallo studioso non appaiano compromettenti e abbiano risvolti politici piuttosto radi. Quanto ad alcuni dei paesi sopra elencati, Uccello citando la documentazione di Danilo Dolci circa le zone a maggiore densità di banditismo e illegalità, rimarca l’analfabetismo diffuso o il bassissimo livello di scolarizzazione, con bambini sfruttati già a 5/6 anni, l’incuria delle amministrazioni locali per la manutenzione (scalinate di immondizia), il controllo mafioso, la crisi delle zolfare e delle piccole rendite contadine, con conseguente emigrazione in Belgio, Venezuela, Canada, Usa, o verso le città del Nord Italia, o verso l’area industriale di Priolo/Melilli. Indicativo del disagio e della rabbia delle classi popolari si rivela l’episodio di un giovane venticinquenne, totalmente renitente a collaborare con l’autore, il quale raccontava di essere stato costretto a rubare fin da bambino verdure e legumi per la fame, e di essere stato arrestato (in quegli anni ’60!) per avere sgozzato per sfregio delle galline, pulendosi poi le mani insanguinate con il certificato elettorale. Umori simili, espressione della situazione economica e sociale degli anni del secondo dopoguerra e del disappunto per le promesse fatte al popolo dai politici e disattese dopo il voto del 1948, e anche per le vane inchieste parlamentari sulla mafia, trapelano da qualche testo scritto da alcuni carcerati rinchiusi a Noto, o dal distico di un informatore di Riesi, dettati tutti a Uccello per così dire “a denti stretti”, tipo: u populu vutau soddisfattu,/ cridennu… d’aviri assicuratu lu so piattu/… Ma si cc’è statu quacchi saccu chinu,/ lu populu l’ha vistu di luntanu./ Ccu-cciarli e mbrogli iru a lu putiri:/ semu rridotti tutti a lu suffriri… con annessa denuncia per l’incapacità/non-volontà di scendere alla radice dei problemi: La cammira delli Dibbutati si pripara/ per livari la mafia ura ppi ura:/ cerca di sparagnarli (risparmiare i miserabili) di la lupara/ pi-ppurtarli n-calera, in-zipurtura (nella sepoltura)…o per l’inefficienza/corruzione di certa giustizia: Staiu viniennu di Cartanissetta,/ vaiu diciennu cca la liggi è-ttorta. Nei Canti tuttavia antologizzati da Uccello prevalgono gli aspetti psicologici della dura condizione dei carcerati, e gli elementi storico-sociali restano sullo sfondo o affiorano a flash intermittenti. Aprono il libro alcune ottave date al Vigo da Francesco De Felice, da lui raccolte a metà Ottocento nella Cittadella di Messina, dove erano reclusi insieme delinquenti comuni e patrioti della rivoluzione del 1848. Uno di loro vorrebbe liberare dalla comune sventura politica se stesso e la madre, e si conforta al pensiero che la riscossa finale è vicina: Lu to nimicu, ch’è nimicu a mia/ trema di scantu ca vicina è l’ura, e lui non vorrebbe essere nella pelle di quello. Chiede anche alla madre, con forte nostalgia della propria casa, di non essere “abbandonato”: Quannu vennu li festi principali (Natale e Pasqua),/ matruzza, ricurdativi di mia. Un altro invece canta la monotonia dei giorni in quella fossa tinibrusa e ria:/ comu passa l’està, passa l’invernu e maledice il sole alto nel cielo, la luna e tutti gli elementi naturali e il loro creatore, dicendo che la sua gran pena è superiore a quella dei dannati nell’inferno. Un altro ancora ironizza, invece, sulla Vicaria nova (l’Ucciardone) chiusa da un bastione: Scì, quant’è bedda la vicarìa nova!.../ li finistreddi ca dunanu fora,/ ammenzu li surdati e li cannuna. / Cu’ la vidi di fora s’innamura/ ma cu c’è dintra perdi la palora. Protesta che torna anche in canti riferiti da Pitrè e da Vigo: Tempu di stati ci coci lu suli,/ tempu di ‘nvernu nun si cci po’ stari, vicarìa dove nei primi tempi per mancanza di impianto idrico, i detenuti arraggia[vanu] di siti e chiedevano acqua alla madre: Lu manciari a la casa mi faciti,/ ccu me fratuzzu nicu lu mannati,/ na quartaredda d’acqua ci mittiti… I luoghi descritti sono cupi: grate interne e esterne, celle buie, umide, o sotterranee come gli antichi, famigerati dammusi (Ch’è friddu stu dammusu! E’ comu un gniazzu [covile] ca acqua spanni di tutti li mura), e da un testo all’altro, che veniva portato e cantato da un carcere all’altro, a emblema di una condizione che era generale e immobile, si ripetono i versi (spesso fra loro intercambiabili) sulle terribili prigioni di Favignana e di Bagnara (dove non si vedono né suli né luna, non si odono né roggiu [orologio] né campana, ma solo scrusciu ri catina), di Sciacca e di Noto (ccu trasi câ palora, nesci mutu, oppure li vai [guai] li trova) e sulla peggiore di tutti: San Vito (Agrigento) nfernu addumatu, cani arraggiatu. E la predestinazione al carcere per il reo vero o presunto suonava come sarcastico avviso sul cartello affisso al carcere di Palermo: curri quantu vuoi ca ccà t’aspiettu. Nell’animo del condannato si agitano nostalgie, ricordi, invocazioni, autocompianto (l’amaru, lu sbinturatu, cunigghieddu preso al laccio), autoironia, odio, accuse a se stesso o agli altri, minacce (pioggia di pallottole, lampo di scupetta…) e arrogante braveggiare mafioso. E si può seguire l’evoluzione degli istituti giuridici nel tempo nel relazionarsi dei detenuti prima con i centarmi (gendarmi), il capitano di giustizia, la Ccillenza titolata, poi con li carrabbuneri, lu bbriateri, lu custuri (il questore)….ma fissi restano i termini sbirru e nfami (sbirrazzu, nfamazzu, nfamuni) per bollare il delatore/spia e ogni rappresentante dello Stato (guardia, giudice). Un carcerato catanese chiuso a Favignana da 11 anni più che dei quartieri suoi della Rotonda e del Tindaro (me spassu e sbiju) ha nostalgia della festa di S. Agata; il poeta popolare Giuseppe Bonafede carcerato innocente per l’astio di un deputato locale pensa ai figli e con intensità poetica paragona il suo cuore che svolazza fra le sbarre della cella a una passaredda cui hanno rubato il nido e lo cerca campagna campagna la cura all’aria e l’aluzzi a lu ventu. Domina nei testi il ricordo della madre (cara matri, mamma, mammuzza mia) alla quale si chiede la benedizione, o la preghiera (forsi pri vui pirdunassiru a mia), e il carcerato ora soffre perché ha vanificato affetto e sacrifici della madre che sarebbe stato meglio avesse abortito, ora si autoaccusa (testa traritura, testa maliditta) per non averla ascoltata e la vede piangere e invocarlo (figliu pirdutu/ nun la pigliari no, ssa mala via… figliu pirdutu di la casa mia), ora invece la accusa, perché non lo ha saputo educare (si-ffrinautu a mmìa/ eu nti stu carciri ’un ci finìa) e vorrebbe darle na vasatedda/morso. Formula stereotipa ricorrente è invece l’invito all’Angelo di Dio, che con le ali può rompere le porte, a consegnare alla matri la lettera del figlio che cci rici ca nun scrivi a-nnudda parti/ pirchì lu prisirenti -viene spiegato- mi cunnanna a-mmorti. Quanto alla donna amata, il carcerato sfoga con lei le pene intime e fisiche, o le dice che non la dimenticherà; talora sogna che quella con le sue manuzzi apra le porte del carcere, o mentre con le lacrime attassa (avvelena) le pietre della cella, le canta il suo amore: bella, talìu cuomu si’ cumposta,/ squaglia la carni mia cuomu la cira,/ lu to curuzzu senza fuocu adduma, innalzandosi qualche autore a volte a immagini tragiche e toccanti per l’intensità del dolore e del desiderio, quali: cc’eni na ronna nna la tramuntana/ la testa si la runa mura mura, oppure: l’urtimu abbrazzu è chistu di la morti:/ e siddu ungniornu ti viegnu a disiu/ votati (voltati): sugnu l’ummira (sono l’ombra) ca puorti. Ma per l’amanti che ha tradito il suo uomo recluso ci sono solo rabbia, odio violento, accusa (tinta carogna, nun è vapparìa) e promessa di vendetta (il coltello, friscu ammulatu/ c’appena nèsciu cci àggiu a-ffà u tabbutu [la bara]). Uno invece chiama i diavoli, che abitano nelle viscere dell’Etna, a partecipare a una singolare jurnata lavorativa per vuscari na bona manciata: devono i diavoli portare incudine e martello, e dare colpi a beddu a beddu (piano piano) senza fari nissuna rimurata, per aprire le porte d’u Casteddu (il carcere di Noto) e fare uscire -dice- l’amanti mia ca è carzarata. Altre volte è la donna che agisce. O prega: Matri Sant’Anna mia, vecchia putenti,/ Turiddu è nnucenti, e-ll’aviti âiutà; o soffre, perché con il suo uomo carcerato parrari ccu la bbucca nun putimu/ e-mmancu fari nzinca ccu la manu, ma quando si rivedranno, è pronta a emigrare con lui; o fieramente trionfa dell’avere ucciso il traditore e recuperato l’onore: Muori, e-mmuristi, nfami e-ttrarituri!/ Ora ca tu ha murutu/ m’arricupuru l’anuri. Signuri e-mmarasciallu… tiniti a rivoltella/ e amuninni m-micarìa (in vicarìa). Non manca l’ironia amara di carcerati e carcerate sul cibo: Poviri carcirati/ ccu-cciciri e ppatati/ li panzi sû aggiggiati (vuote), ma ancora più acre è l’autoironia: la sentinella sta alle costole del detenuto come gli uccelli trampolieri; sua mammuzza sono catene e carcerieri, suo patruzzu il pretore, fratuzzi i carabinieri, amici le grate, cumpari San-Giuvanni il questore che pianta chiodi al condannato. E con più malizia e arguzia uno dice che i carcerieri, per farlo uscire, vorrebbero una statua d’oru del suo peso più un altro quintale, oru che non possiedono né il re né tutti gli argentieri della sua Acireale e un altro, vedendo già schierate truppe e cavalleria per giustiziarlo, commenta che va alla forca cu tanta assistenza! Uccello fornisce esempi anche del tipico linguaggio e costume mafiosi: l’omertà (nun dati cuntu si siti chiamati/ faciti li locchi e li sturduti); il: “tira manu!”, che era la formula dello sfidante nel fronteggiarsi col coltello (a tirata); il “fari vientu” o no, espressione gergale per dire “il confessare” o no al giudice la verità; l’autovantarsi del mafioso: che farà suonare li campani a-mmuortu, o che è un’erba che ntuossica a-ttutti… e-ccu m’agghiutti li fazzu affucari, oppure, nessuno può fargli dispetto (speci), perché -minaccia- di ghiummu ci la pigghiu la misura. Costanti, dominanti e violenti sono poi l’odio, il disprezzo e le fantasie vendicative contro lo sbirrro e l’infame. Nfami è il giudice cui il carcerato non confesserà mai la verità, neanche a colpi di coltello; nfami è la spia che se arriva alla Vicarìa sarà sottoposta dai traditi al cascittuni (la testa ingiù nella cassetta-cesso) o sarà, fuori dal carcere, tagghiatu (sfregiato) a corpa di rasola (rasoio). Lo sbirro è disprezzato. Non è omu, né lupu, equivalente di omu, ma cani pirfettu (appunto “guardia”) e pure da assassinato fa vomitare: Chiddi che si liccaru lu piattu/ dissiru: mamma mia, cca mi rriettu. Uno sbirro/Stato curnutu così persecutorio e oppressivo da andare ad arrestare pure il diavolo nel fuoco dell’inferno: Talìa ch’ardiri stu sbirru curnutu,/ ca si porta un diavulu attaccatu. Molti proclamano vanamente la loro innocenza e formule ricorrenti sono: carciarateddu sugnu… senza fari un centesimu ri ddannu, oppure con icasticità epigrammatica: autri fa dannu, iu cianciu lu piccatu,/ autru ha la curpa, iu la pinitenza! Cosi come ricorrente di bocca in bocca, con carica consolatoria, era la storia vecchia di secoli, pare dal ‘500 circa ma riciclata, con adattamenti, come sempre attuale, del carcerato abile verseggiatore-improvvisatore liberato per questa abilità da sua Eccellenza (duca, conte, giudice…) in visita alle carceri con la moglie: ci rassivu licienza quantu passa,/ pi l’amuri c’aviti a la Duchissa. Se il delinquente abituale fa l’elogio del carcere: casa filici, pararisu, villiggiatura, perché vi trova li frati e l’amici,/ dinari, bon manciari e allegra paci, mentre fuori deve misurarsi con i nemici e se non lavora -dice- moru di miciaci (fame), gli innocenti si sentono invece tremare le reni al suono di chiavi e catene (chi lo “suona” è lu macillaiu ri la carni umana) e, con efficace effetto onomatopeico, per i colpi di mazzuolo delle guardie a ogni avvimmaria sui ferri delle finestre: ferri bbattuti e finestri nsirrati. E in qualche testo c’è la cruda riflessione che il carcere non “corregge” (castìa), insegna anzi con il suo tristo ambiente a delinquere: lu carziri è violu chi vi invia (che instrada)/ chi vi ’nsigna li strati e li purteddi (gli agguati), realtà espressa metaforicamente anche attraverso l’invito ai giudici nfamuna che studiano “la legge” a cercare l’inferno fra i “vecchi carcerati”, sfogliando a una a una le pagine del carcere, pagine di dolore e di scuola del male: truvati deci giuvini assittati,/ ddrà ‘mmienzu cc’è lu masciu di la scola;/ di foglia a foglia lu libbru vutati:/ lu ‘mpiernu (l’inferno) nti li carzari si trova. Perciò la felicità del carcerato che finalmente ne esce, sentendosi rivivere comu na rosa nata all’uortu (orto), è dovuta non solo alla gioia di tornare al paese, ma anche all’essersi finalmente lasciato alle spalle quel luogo d‘amici sbirruna e trarimintusi. Un contesto avvelenato, dove l’aria è satura soprattutto di rabbia e furore di vendetta non solo -come già visto- verso lo sbirro che arresta, spregiativamente, naschiannu comu un cani e rovistando (scaliannu) pure lu fumeri (concime) fina a lu muzzuneddu (brocca rotta) ccu lu sali, ma soprattutto verso quegli amici che hanno tradito e che al momento dell’arresto hanno addirittura festeggiato: si cunzaru la tavula e-mmanciaru/ comu avissiru truvatu lu trisoru, ma il condannato, se camperà e uscirà, sarà per loro come un sirpenti ammilinatu, e se sbaglierà il colpo -grida un recluso- mi tagghiu lu vrazzu,/ iu stissu mi cunnannu mpisu (alla forca) allura! Una disperazione umana e sociale -come si vede- senza redenzione. Ma solo allora? O per tanti “esclusi” anche oggi? Una realtà quella delle carceri, che continua a interrogare la società, e di cui negli anni Sessanta, quanto alla Sicilia, Antonino Uccello volle e seppe vergare un ricco e inquietante documento storico e poetico.