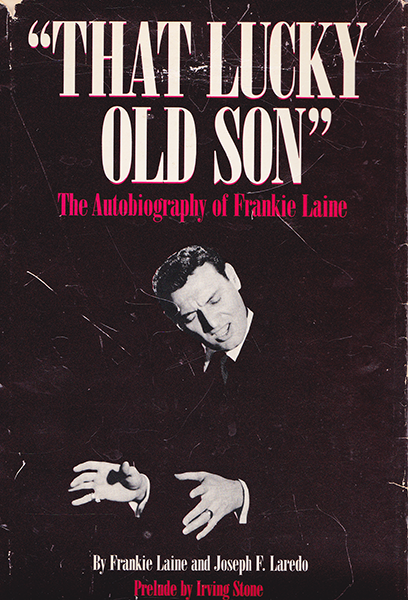Francesca K. Matina, "La casa nel vento" (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 08 Marzo 2018
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1869
di Giuseppe Bagnasco
Capita spesso quando ci si trova davanti al testo di una scrittrice che s’affaccia per la prima volta alla ribalta dello scenario letterario, che la lettura in qualche modo “benevola” ceda il passo ad una più approfondita critica tale da poterne fare emergere un qualche lato “debole”, con la conseguenza di condurci “colpevolmente” ad un superficiale giudizio. Ma questa di Francesca K. Matina, presentata come “Opera prima”, evidente preludio di successive elaborazioni letterarie, potrebbe al contrario, considerarsi come un’opera frutto di un cultore del pensiero giunto al pieno della sua maturità “sofoletteraria”. Un’Opera Prima, questa La casa nel vento (Edizioni Thule, Palermo–2016) che potrebbe leggersi come l’epilogo che una docente di filosofia destina ai suoi giovani alunni nell’ultimo giorno del corso di studi. Giovani che mai più ritornerà ad incontrare e quindi assume nel suo contesto una dimensione eclettica. Ma ancor prima di anticiparne il giudizio, vediamo, come siamo d’uso fare, cosa c’è esposto nella copertina, impreziosita da un dipinto di Sergio Ceccotti e che funge come sempre da vetrina. Rappresenta una porta-finestra semiaperta che ce ne richiama un’altra, quella della copertina di Tempo dorato del filosofo Tommaso Romano, lì come saggista nelle vesti di un socio-antropologo. Quella della Nostra, scrutando gli interni, raffigura una donna vestita con un convenzionale tailleur, la borsetta al braccio, mentre con lo sguardo smarrito si appresta ad uscire. Si arguisce, ma è una nostra parallela lettura, che non esce attratta dal bel cielo azzurro riflesso sui vetri dell’imposta, bensì dall’intima volontà di uscire comunque. Andare via, via da cosa?. Questo interrogativo potrebbe sembrare un azzardo di lettura ma sta nel proseguo dell’esposizione dell’itinerario che traccia nel libro la scrittrice, che troviamo la sua spiegazione. Un itinerario che è un viaggio introspettivo che partendo dal suo “me”, la porta a raggiungere il suo più profondo “io”. Nonostante l’Autrice classifichi riduttivamente il suo lavoro come un racconto, ci troviamo invece di fronte ad un pregevole saggio sulla ricerca della felicità. Felicità che non è un luogo ma un granello portato dal vento che passa, entra nella nostra vita e ne esce proditoriamente, lasciandoci un vuoto.
Il lavoro di Francesca K. Matina, dove anche il suo nome è diviso da quel punto che insidia la K, si presta ad una univoca lettura, divisa anch’essa in due parti e che si estende da accadimenti che imperversano tumultuosi nel suo incedere, aggettivazione lontana dal “tumultus” latino, ad una calma meditazione filosofica. Infatti mentre la prima parte rappresenta il “corpo” in un tormentato percorso di vita quotidiana, la seconda esprime, con l’aspirazione alla realizzazione autentica della vita, lo spirito, l’anima. E in fondo le due parti le potremmo identificare e distinguere, invertendone l’ordine, nell’Essere e nel non Essere di parmedineana memoria. La “fisica” e “metafisica” scrittrice d’origine lampedusiana affronta, lasciando la sua isola per una metropoli, il suo primo dualismo: da una parte il piccolo nucleo d’anime, visto come individualismo, dall’altra il grande crogiolo della massa informe della città, sofferto come collettivismo. E questa sofferenza la porta a riconsiderare il suo rapporto con la sua “Itaca”, l’isola del ritorno al punto da non vedere alcuna differenza tra una panchina cittadina e il suo abituale scoglio, posto di fronte al suo mare, dove portava i suoi pensieri, le sue aspirazioni. Lo stesso dualismo in cui differenzia un grande viale con una piccola strada, meglio un vicolo, dove si sente più a proprio agio, più vicino al suo essere, più intimo, più raccolto, più consono alla meditazione, più a sua misura e dove si riappropria istintivamente di se stessa. Una sofferenza, quella vissuta a contatto con una società fittizia ed ipocrita, dagli stereotipi fatti di convenzioni standardizzate che ad un certo punto, afferma l’Autice, la sua “era diventata una tragedia senza pubblico, nel teatro sfuggente della vita, dove a pagare il biglietto ero sempre io”. Ed è esattamente proprio partendo da quel certo punto che la Nostra, forte delle parole della madre “Tu non sei felice. Punto”, l’arresta nella convinzione che “ bisogna perdersi per ritrovarsi ”, tornare al punto di partenza giacchè in fondo la vita, come afferma il filosofo Tommaso Romano, è sempre un ritorno a se stessi.
E’la svolta che imprime nella sua vita liberandosi da quello zaino “pieno di nulla e vuoto di tutto” che per tre anni era rimasto appeso alle sue spalle. E’ qui che la trama del libro cessa di essere un racconto autobiografico e diventa esercizio del pensiero, un gabbiano che riprende il volo verso ciò dove amava andare: i lidi perigliosi della filosofia. E’ in fondo la metafora della donna della copertina che esce da casa per andare verso quella “Vita nuova” di dantesca memoria dove cessa il discorso con la realtà e inizia quello con l’anima. Una sorta di osmosi tra il testo e la copertina. Una scelta voluta intimamente e che nel suo “primo giorno di quiete” ritrova nella frase sibillina della sua amata insegnante di filosofia: “ Ti auguro tanta serenità, anima inquieta”. Nella contrapposizione tra l’Essere e l’Apparire, afferma la Matina, bisogna uscire dagli schemi della nostra forma mentis e dare campo alla bellezza delle anomalie perché è dal contrasto tra il positivo e il negativo che si può affermare di vivere veramente.
La casa nel vento è tutto questo. E’ un saggio, lo ripetiamo, di ricerca della felicità attraverso la stesura mediatica di un racconto a metà tra un diario e un complesso esercizio di filosofia. A differenza di quando potrà colloquiare “peripateticamente” coi propri discepoli, certa che per allora potrà dominare con la serenità raggiunta la fastidiosa balbuzie che l’affligge, per ora la nostra K. affida le proprie meditazioni alla scrittura allo scopo di rivolgerle all’immaginaria platea dei giovani. Giovani che esorta a guardare a La casa nel vento come una “finestra aperta sul passato ma orientata al futuro” e lo fa servendosi proprio di quel mezzo mediatico da cui rifuggiva nell’antichità un grande maestro del pensiero e che risponde al nome di Socrate, come viene riportato da Platone nel “Fedro”. Il Maestro pensava che per avere un contatto diretto con i giovani ci si dovesse affidare alla parola, alle domande e risposte proprie dell’interloquire estemporaneo e a diffidare della scrittura sia perchè il pensiero scritto non poteva mutare e sia perchè in ogni momento poteva essere interpretato difformemente da quello originale e infine perché la vedeva come un rallentamento dell’esercizio della memoria. Il Filosofo ateniese non prendeva in considerazione la facoltà di permettere a chiunque di appropriasi della sapienza e della conoscenza riservate ai filosofi. Ma è quel “chiunque” che non poteva essere comprensibile all’aristocrazia del tempo, a cui lui apparteneva, perché evidentemente non si rendeva conto come quella forma comunicativa fosse uno dei pilastri della democrazia, come partecipazione e divulgazione (gratuita) del pensiero. E qui viene consequenziale fare una digressione.
La filosofia non nasce tra le case del popolo minuto nei “Demo” ma tra le persone appartenenti alle classi più elevate delle città. E’risaputo che gli ateniesi amavano passeggiare nelle Agorà e discutere di politica, oppure concedersi alla libertà del pensare o del dolce far niente poiché ritenevano che non era degno di un uomo libero avere bisogno di lavorare per vivere. Questo era riservato agli schiavi. La filosofia è dunque figlia primigenia dell’ozio? Non del tutto, se inteso nella semantica dell’otium dei latini cioè come tempo dedicato oltre che al riposo, allo spazio per pensare. Ma è un fatto che per secoli il potere ha diviso le società del tempo in tre “Stati”, a cominciare da quello federiciano - feudale, ecclesiastico e demaniale - che pose fine al medioevo, a finire a quello prerivoluzionario francese in nobiltà, clero e borghesia -. Lo “Stato” del popolo, detto “Quarto Stato” e in seguito con Marx, del proletariato, non era affatto deputato alla speculazione filosofica attanagliato com’era dal lavoro e dalla necessità della sopravvivenza. E lo dimostra il fatto come alla classe dell’aristocrazia e di seguito a quella borghese, appartenessero quelli che, per restare tra i nostri e ciò fino all’Ottocento romantico, giusto per citarne alcuni, facevano capo alle casate dei Leopardi, Manzoni, Alfieri, Foscolo, ecc. Ma anche il popolo aveva le sue scuole di saggezza, la filosofia dei semplici e dalla quale si originarono i proverbi: erano gli anziani dei borghi o i nonni nelle case con i loro detti, motti, esortazioni per governare le relazioni tra individuo e società, tra società e Natura o tra quanti formavano una famiglia. Relazioni che offrirono le basi alla formazione della Sociologia.
A completamento di queste note non possiamo non ricordare tra i dieci capitoli de La Casa nel vento della Matina, i suoi rapporti sia con la sua personale “Grande prostituta”, di volta in volta identificata nel tempo, con l’antica Babilonia o in seguito con la Roma papale al tempo delle vendite delle indulgenze e sia, aspetto non trascurabile, con la fotografia. La Nostra definisce “magica” la Sicilia, ama Palermo (la Grande Prostituta) di un amore viscerale, l’ama per il suo carico di storia, per quelle antiche civiltà che lì progredirono e si affermarono. L’ammira per i suoi monumenti, i ritrovi, i teatri, le chiese, cercando però nei vicoli, e non nelle eleganti strade, l’anima ancestrale della vecchia polis, con i suoi odori, insieme ai colori del cielo, del mare e non ultimo per “ il più bel promontorio del mondo”. Al contrario non ne tollera gli abusi, il disordine, l’ipocrisia dell’appariscenza e, aggiungiamo noi, la corruzione dei pubblici uffici, la prevaricazione nella circolazione stradale, l’abusivismo edilizio con l’occupazione del demanio, gli incendi boschivi dolosi e la generalizzata prostituzione morale. Palermo vende o svende tutto ciò, e si offre con seducenti ammiccamenti all’obiettivo dei turisti che l’Autrice, da appassionata dell’arte fotografica, apostrofa mentalmente: “Chissà, cosa ci trovassero nel bloccare il tempo, sottraendo il presente al suo destino, quello di diventare passato”. Per Lei invece quello che conta non è il souvenir fotografico da inscatolare in un album, ma un ricercare nelle cose, nelle persone ciò che vi sta dentro, nel profondo dell’anima. Si veste pertanto da archeologa per una missione di antropologia spirituale, con l’obiettivo di tirar fuori dal corpo lo spirito, al pari dell’andare alla ricerca dell’anima della città, scavando nei vicoli del centro storico. Alla nostra archeologa non interessa la “piramide” della bella e sontuosa costruzione appariscente e seducente, ma l’interno, la “ stanza del re ” dove riposa l’eterno. E’ in fondo una continua lotta per la supremazia tra il fuori e il dentro, tra una tesi e un’antitesi, come nella più classica dialettica e che trova nella sintesi della scelta di docente di filosofia, quella serenità che chiama felicità.
Francesca K. Matina investendosi di una sorta di “legazia apostolica”, delega all’uomo, ai giovani, il compito di non rinunciare mai al proprio intimo sentire, ma andare oltre investigando e tirando fuori ciò che veramente conta, specchio e orgoglio dell’affermazione dell’Io. Il suo verbo risulta ammantato di un “romanticismo laico”, giacchè riscopre e ama il suo passato, l’aura delle sue radici, si nutre dei segni della natura, del calore del sole, dell’umore mutevole del mare e soprattutto di quel senso di riposo e di pace che le concedeva il suo “scoglio” e a cui ricorreva al tempo delle sue inquietudini. La casa nel vento pertanto costituisce una casamatta posta a difesa degli ultimi scampoli di una civiltà largamente insidiata dal vacuo e del superfluo e dove finanche nell’Olimpiade della Cultura, qual’è il Premio Nobel, si è trovato il modo di squalificarlo assegnandolo inopinatamente nel campo della letteratura (!) a personaggi dello spettacolo quali Dario Fo e recentemente Bob Dylan. E la definisce, com’Ella afferma nell’ultimo capitolo, una casa di frontiera, una casa con pareti di parole e mattoni di pensieri e, aggiungiamo noi, simile ad un deposito di concetti, di enunciazioni, quasi un emporio, in cui le domande si propongono in modo dirompente e costante , quasi una corsa a recuperare il tempo perduto nella ricerca di se stessa e dove le risposte arrivano nelle nebbie del tempo dove c’è sempre un dubbio in agguato che impone sempre un’attesa, quell’attesa che in fondo è la vita stessa.