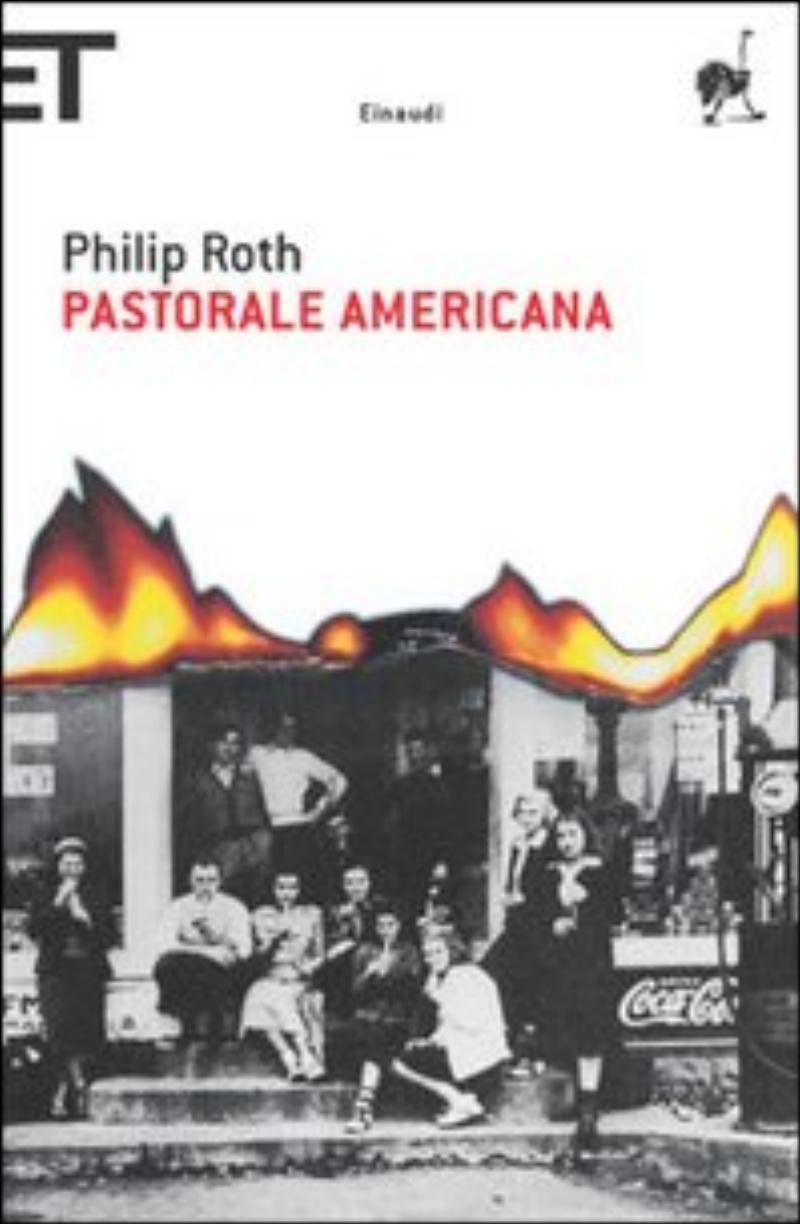Giuseppe Pappalardo "Çiuri di notti" (Ed. Thule)
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 11 Febbraio 2020
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 2314
 LA SCRITTURA POETICA DIALETTALE
LA SCRITTURA POETICA DIALETTALECOME SVELAMENTO DELL’ANIMA
di Maria Patrizia Allotta
La poesia è un’eco dell’anima
che chiede all’ombra di ballare.
Carl Sandburg
Così scrive Victor Hugo: «C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo; c’è uno spettacolo più grandioso del cielo, ed è l’interno di un’anima».
Ne siamo pienamente consapevoli.
Cogliere, però, nel suo totale splendore, l’interno di un’anima, certamente, facile non è.
Tuttavia a volte capita che la scrittura - specie quella lirica - dia la possibilità di leggere più agevolmente la vera natura di un’anima la quale, appunto, si svela -magari inconsapevolmente - in quei fogli bianchi segnati non tanto da quel tipico tratto d’inchiostro nero, quanto da quell’appena percepibile respiro, capace, incredibilmente, di rappresentare l’essenzialità di un singolo.
Capita anche che più il respiro è lieve più la scrittura è chiara, e più il respiro è affannato più l’anima si palesa in tutto il suo splendore!
Ed è quello che avviene in Ҁiuri di notti, dove Giuseppe Pappalardo attraverso i suoi trentasei testi lirici, pubblicati dalla prestigiosa casa editrice Thule, palesa - in punta di piedi, senza orpelli, né giravolte e quasi a fior di labbra - il suo stesso spirito che appare ora immerso nella contemplazione dell’armonia cosmica, ora preso dal dolore esistenziale, ora assorto nella beatitudine passionale.
Un’anima tenue e leggera ma anche resistente e forte quella che appare, capace di liberarsi dai pesi dell’inutile tangibile per perdersi in quella vivificante natura che appare, nell’economia della stessa sussistenza, elemento alchemico totalizzante.
Infatti - tra notti di luna e ciuri di notti, tra i mistiriusi stiddi splinnenti e l’abballata di la luna - il Nostro - similmente al famoso pastore errante dell’Asia di leopardiana memoria - durante le notti buie e aspettando l’alba, sembrerebbe parlare con la luna, con le stelle e con il creato tutto, senza ricevere, almeno in apparenza, nessun cenno di risposta alle sue incalzanti domande che nascono da quei dubbi assillanti, da quelle incertezze moleste e, quindi, da quel dolore continuo che diviene condizione caratterizzante del suo stesso essere.
Almeno in apparenza, si diceva. E, in effetti, non siamo in presenza di uno sterile monologo, ma piuttosto davanti a un costruttivo dialogo, dove la muta natura diviene divina voce silente capace - con la sua sola bellezza - di alleviare l’anima del Poeta il quale, ora ferito dalla volgarità, dalla brutalità e dalla bassezza dei suoi stessi simili, ora leso dalla mestizia, dall’amarezza e dalla tristezza dell’esserci, trova riparo nell’ammirazione dell’elemento cosmico, quest’ultimo vissuto in pectore e narrato in flatus come manifestazione di quel Principio del Tutto che appare unico, vero e insostituibile conforto.
Dunque, così come per i filosofi tedeschi del primo ‘800, analogamente anche per il nostro rimatore siciliano doc dall’indole tipicamente romantica e dalla disposizione distintamente panteistica - come ampiamente dimostrato anche nelle altre sillogi dal titolo Occhi ‘i pueta (Aulino 2012), Di mia a tia (I.L.A. Palma, 2013) e Contraventu (Arianna 2016) - la benevola e provvidente natura è espressione tanto dell’Assoluto quanto dell’infinitudine dell’Io.
Ed è qua che il cantore si immerge, si identifica e si perde nella ricerca della pace interiore.
Pace che rinasce come fenice egizia.
Infatti, nonostante alcune strofe potrebbero suggellare un pessimismo radicato ed una quasi eutanasia - “iu mi sentu sulu, cchiù sulu di la luna” o “... trovu sulu silenziu / agghiuttennu pinzeri / e stricànnumi l’occhi. / Ѐ daccussì / ca passu li me notti.”, oppure “lu mantu di la notti m’accarizza / lu chiantu m’addurmisci / a stizza a stizza” e anche “ (...) sugnu vecchiu / e la iurnata mori / e mi strinci lu cori / pinzannu a quannu sona / lu toccu cubbu di la me campana” - in realtà in altri versi evidente è l’attaccamento alla vita e palese è il legame all’esistenza.
Infatti: “la vita me triunfa e si ni vanta / sta vita è meli e zuccaru pi-mmìa / mi ntrica, mi ncatina, mi mpircanta” o “ si di l’amuri ni mintemu l’ali / talè, mori lu lupu e nasci l’omu” oppure “sintiti comu batti lu me cori... / un trenu pari, curri a centu all’ura”. E, dunque, si tradisce (forse volutamente!) l’Autore di Paternò, il quale, preso, dallo sturm und drang, nel cantare la malinconia e la sofferenza, l’incomprensione e la solitudine, la nostalgia e l’afflizione, l’odio e la morte, in verità sublima la gioia e l’allegria, l’amicizia e la pace, l’afflato e la felicità, l’amore e la vita.
Un singolare chiaroscuro, dunque, dettato da una nobile anima capace quest’ultima di narrarsi attraverso uno stile sobrio, misurato, serio, dotato di una scansione lenta ma ritmata, lieve ma incisiva, irripetibile e unica, proprio come lo stesso lemma autoctono scelto, certamente, nella consapevolezza che “il dialetto permette di non smentire le proprie radici”, inoltre “risveglia l’inconscio” ma soprattutto “è la lingua del cuore”.
E con la forza delle proprie radici e con la veemenza della lingua del cuore, il nostro Poeta all’interno delle tre sezioni intitolate Fìmmini e òmini, Parrannu di mia, Àutri puisìi - più o meno consciamente ma sempre in modo significativo - canta la preziosità della Fìmmina, vista come àncilu e non serva di l’omu, e la necessità dello ncantu d’amuri, che di ss’occhi è la ricchizza, e lo splendore del dono di curaddi e stiddi e di tappiti d’oru e sita, e il valore della preghiera o del cantu d’un omu ca nascìu luntanu, e ancora, la singolarità dell’eco che “cala la notti di la virità/ suprô silenziu di l’umanità”, e la magnificenza di essere picciriddu, e del santo Natali che veni pi tutti, e di San Valintinu con il suo amore eterno, e Pasqua con Cristu Signuri, e infine l’attaccamento al sole della propria terra che non t’abbannuna a li to làcrimi, e a Palermu, àcula di re, vantu di un’ìsula ca voli cancellari lu suli ca di notti si fa chiantu, ma soprattutto l’importanza del poetare anche quando la palora si fa chiummu e di lu celu spirìscinu li stiddi.
Una palora-chiummu - paradossalmente - leggera, elegante e raffinata, anche asciutta ed essenziale, mai ridondante, né banale, equilibrata sempre, che rapisce totalmente per condurre in un aureo mondo dove l’armonia del vernacolo, l’eternità dell’incanto e la sacralità della Tradizione è ancora possibile carezzare.
Così il Poeta diventa Vate; e il Vate, profeta; e il profeta, epifanico uomo che nel dolore rinasce vittorioso.
«Tu non tocchi un libro, tu tocchi un uomo e la sua anima». Così scrive, Francis Otto Matthiessen.
Ecco, in effetti, riprendendo quanto all’inizio sostenuto, sfogliando le pagine di Ciuri di notti e altre poesie in dialetto siciliano, non si ha semplicemente la sensazione di toccare un libro, o leggere ottimi fogli dialettali, o mantenere un’opera d’Autore.
Di più. Perché lo svelamento dell’interno di un’anima, appare in tutto il suo splendore.
Ed è così che Giuseppe Pappalardo diviene, emblematicamente, grandioso spettacolo più del cielo e del mare.