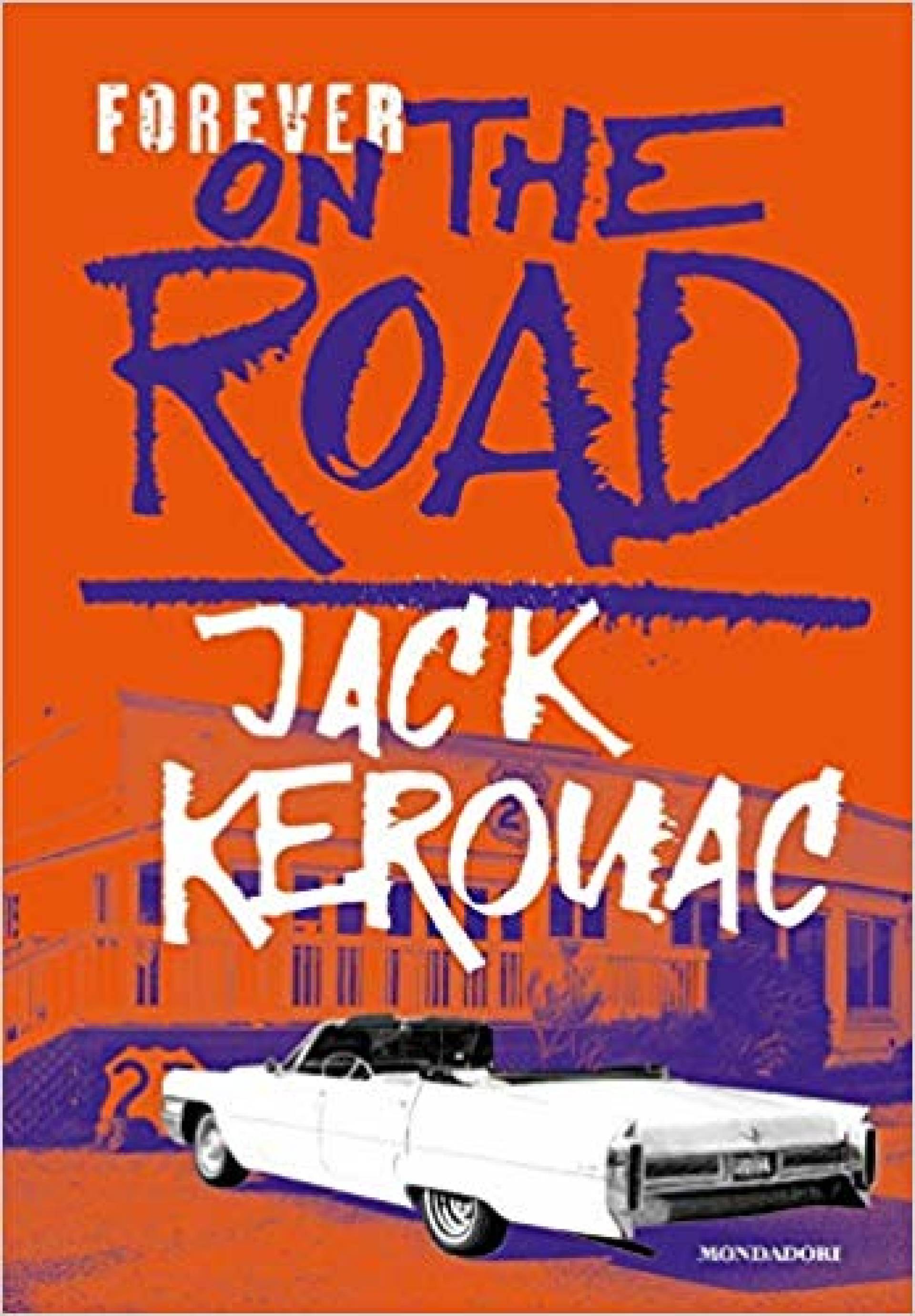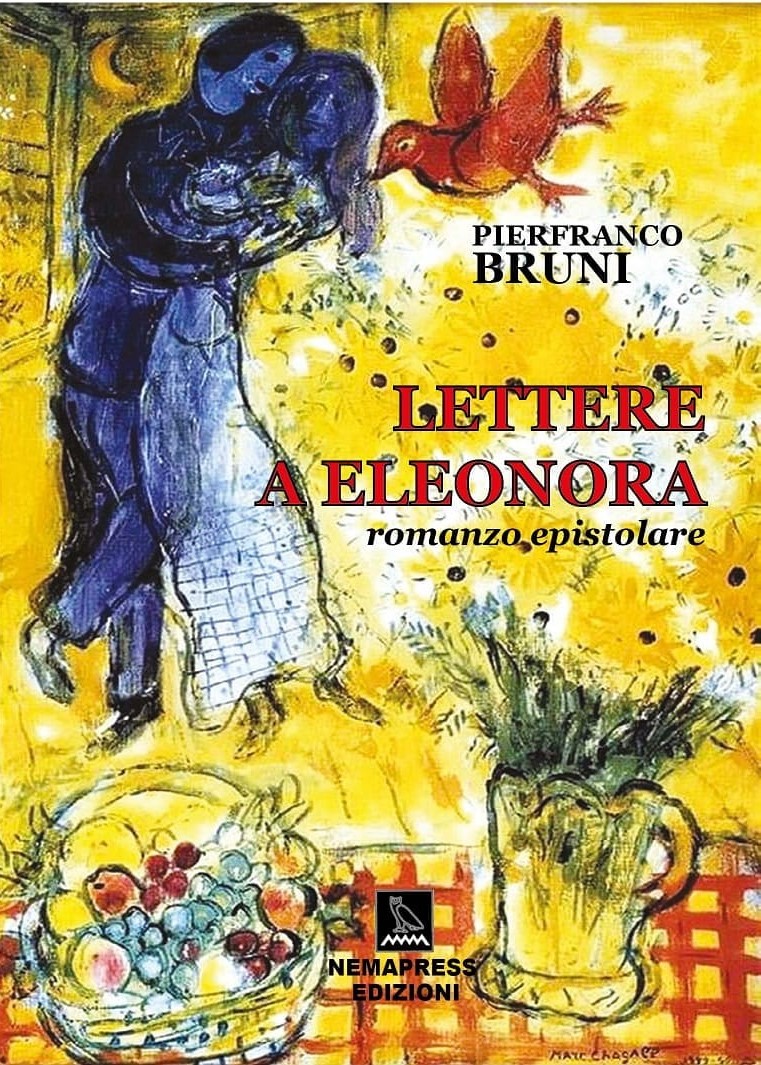“L’ atroce mistero” un racconto di Giacomo Civiletti
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 14 Marzo 2023
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1743
 Forse era soltanto una leggenda che si tramandava, così come fanno certe famiglie, tanto per darsi un tono, ma la storia del trisavolo trovato con le mani in bocca dentro la sua bara, a Daniele faceva molta impressione, anzi lo terrorizzava.
Forse era soltanto una leggenda che si tramandava, così come fanno certe famiglie, tanto per darsi un tono, ma la storia del trisavolo trovato con le mani in bocca dentro la sua bara, a Daniele faceva molta impressione, anzi lo terrorizzava.
Il Commendatore Astolfo Vallelunga, terzo ed ultimo rampollo del fu Marchese Rinaldo Vallelunga, aveva terminato la sua esistenza di alto funzionario statale alla non più tenera età di novantasette anni.
Aveva sposato Armida l’unica figlia di un suo superiore e da questa ebbe il figlio Achille che nascendo ne causò la morte.
Achille, orfano di madre e con un padre costantemente all’inseguimento di una carriera ostacolata dal suocero, suo nonno che lo odiava considerandolo la causa del decesso della propria figlia, crebbe senza affetti, rinchiuso in severi collegi, si laureò in scienze matematiche, si diede alla docenza universitaria e sposò una giovane allieva di buona famiglia, Silvia, di venti anni più giovane che s’innamorò perdutamente di lui. Ebbero, nonostante la costante ed appassionata applicazione di tutte le pose del Kamasutra, acquistato in viaggio di nozze in oriente, un solo figlio, Osvaldo.
Il Commendatore Astolfo, trisavolo di Daniele era stato calato nella bara con il suo frac completo di ghette e gibus, le mani dentro i guanti, composte sul petto, tenevano un grosso Rosario d’argento e madreperla e chiuso il coperchio, senza scosse, il feretro era stato delicatamente estratto dalla carrozza con il tiro da sei che lo aveva condotto al Cimitero e sistemato dentro una tomba provvisoria, in attesa che fossero completati i lavori di ristrutturazione della cappella di famiglia.
Quando, dopo poco più di dieci anni dalla morte , il corpo del Commendatore o quello che ne restava , fu riesumato per essere traslato nel loculo che gli spettava nella rinnovata cappella, la cassa benché lussuosa e solida all’origine era ridotta ad un fascio di listelli di legno che sembravano , più che contenere il cadavere, appoggiati su di esso ; scostati quelli che dovevano corrispondere al coperchio , la scena che il Professor Achille e suo figlio Osvaldo videro fu fra le più agghiaccianti che la mente umana possa sopportare.
Il corpo dell’avo era contorto dentro la bara, avvitato su se stesso ed aveva le mani in bocca come se avesse voluto mangiarsele per la disperazione.
Il fatto destò molta impressione nell’opinione pubblica, perché gli estranei presenti diffusero l’agghiacciante notizia della quale in città si parlò per molti anni.
In famiglia quando se ne accennava, si diceva “l’atroce mistero” e sembrava che soltanto a pronunciare quella velata evocazione, un vento gelido attraversasse l’ambiente.
Il terrore di venire seppelliti vivi fu risparmiato a coloro che ne avevano visto con il loro occhi l’effetto, Achille fu richiamato e Maggiore del Genio, morì in guerra per l’esplosione di una mina; il figlio Osvaldo, di professione avvocato, richiamato anch’egli Capitano di Cavalleria, fu fra i primi piloti d’aerei e venne abbattuto da fuoco amico nei cieli delle colonie africane; catturato dalle truppe del Negus fu crocifisso, castrato, scorticato e poi fatto a pezzi ancora vivo.
Fortunati nella disgrazia, diceva il Dottor Alfonzo padre di Daniele quando il suo sguardo si posava sulle due grandi fotografie esposte in salotto, del nonno e del padre entrambi in divisa, ma lui, tranquillo dirigente di banca, marito esemplare, padre affettuoso, amico fedele, un uomo normale insomma, senza i fremiti eroici dei suoi ascendenti, temeva una fine peggiore della loro, temeva “quella fine”.
Daniele capiva che in quel “fortunati” rivolto ai due eroi morti straziati, suo padre intendesse esprimere tutta la sua angoscia di venire sepolto non morto e di risvegliarsi nella bara come l’antenato Commendatore Astolfo ed il suo amore filiale escogitava per lui tanti e vari modi per assicurargli un trapasso sicuro quando fosse arrivato il suo momento.
Ed il momento arrivò mentre il direttore stava rileggendo un canto della Divina Commedia seduto comodamente in salotto avvolto dalla sua poltrona preferita.
Aveva la testa leggermente reclinata, sembrava che dormisse e nessuno se ne sarebbe accorto ed avrebbe pensato al peggio, se non fosse stato per un’evidente distonia con l’ambiente e le abitudini della persona: l’elegante volume era aperto e caduto in terra mentre, ovviamente, il morto, da vivo, prima d’addormentarsi, il libro l’avrebbe chiuso e posato sul tavolino vicino o riposto nella grande libreria che occupava interamente due pareti. Il dottor Alfonzo era sereno, nessuna smorfia spasmodica sul viso, fu composto nel grande salotto dentro una elegante e lucida bara. Da subito Daniele si sedette su una poltroncina che aveva collocato all’altezza del viso del padre e non si mosse, mentre sua madre e le sue due sorelle, la maggiore con marito e figli, l’altra nubile sorretta da un cugino si erano accomodate in sala da pranzo per assaggiare qualcosa per affrontare la lunga veglia ed il successivo il funerale, a lui non restava molto tempo, doveva agire subito.
Dopo avere sfiorato con le dita una guancia di suo padre, come a volergli comunicare che sarebbe tornato subito, si alzò di scatto e a lunghi passi felpati percorse il lungo corridoio, che conduceva alla camera di sua madre e vi entrò, aprì l’armadio e trovò quello che cercava. Aprì una cappelliera e con due dita prese il cammeo che avvolgeva la testa dello spillone, lo sfilò ed uscì. Tornò al feretro del padre, superando un attimo d’esitazione, gli scostò la giacca, sbottonò due bottoni all’altezza del cuore, gli aprì la camicia, poi puntò lo spillone e fece forza. Il ferro entrò in tutta la sua lunghezza trapassando il muscolo cardiaco subito dopo la maglia di lana che il direttore portava da vivo fino a tutto giugno per rimetterla il primo settembre. In certi momenti tragici a volte si pensano cose buffe ed in quel momento estremo, gli passò per la mente che ora il Cavaliere Dottor Alfonzo Vallelunga Direttore Centrale del Banco di Torreverde, la maglia di lana, l’avrebbe portata per sempre.
Si vergognò del pensiero e quello che avrebbe voluto essere un sorriso gli contrasse la bocca in una smorfia che gli rimase stampata in viso per tutto il tempo che gli occorse per sfilare lo spillone e sussurrare: “Addio papà riposa in pace.”
L’arma estratta dal petto del morto lasciò un puntino rosso appena percettibile lì dov’era penetrata , Daniele riabbottonò la camicia del padre , gli risistemò la giacca, lo baciò in fronte e poi tornando verso la camera di sua madre per riporre lo spillone, promise a se stesso due cose : che avrebbe cercato in tutti i modi di farsi assumere in banca come avrebbe voluto suo padre e che mai avrebbe raccontato ai suoi figli, se ne avesse avuto, l’agghiacciante storia del loro avo né quello che lui aveva appena fatto.
Sarebbe stato lui, diceva a sé stesso, ad interrompere quel tipo di terrore che considerava aggiuntivo a quello già terribile del pensiero della morte che opprime tutti i viventi che si fa più pressante quando si supera quella metà di vita che ognuno si augura di vivere.
Daniele non riuscì ad avere il lavoro in banca e la necessità lo spinse ad accettare un posto di praticante nell’avviatissimo studio di un cugino di sua madre.
La consapevolezza che il suo impiego fosse frutto di carità familiare, gli diede la carica per studiare tanto, di notte, perché di giorno galoppava per l’avvocato ma presto riuscì a vincere un concorso in magistratura e divenne sostituto.
Una delle sue prime cause la vinse proprio contro il figlio del prozio avvocato che detestava perché questo, la sera, prima di lasciare lo studio, non mancava mai di dirgli:
“Omaggiami la mia carissima cugina” rimarcando in maniera inequivocabile il “carissima” e Daniele era ossessionato dal pensiero che il suo impiego non fosse dovuto alla semplice parentela fra sua madre e l’avvocato, ma a loro intimi trascorsi giovanili.
Rimase a vivere con la madre e la sorella rimasta nubile che però gli usò la gentilezza di morire improvvisamente giusto la mattina del giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio. Daniele per nulla turbato si presentò in perfetto orario al cospetto del suo capo, il Procuratore.
La carriera di Daniele avanzò spedita; era considerato inflessibile, alcuni dicevano che fosse addirittura crudele, alcuni dicevano sadico.
Le confessioni “spontanee” con ammissione di colpevolezza erano la maggior parte dei risultati che otteneva e non passò molto tempo che divenne Procuratore.
Morta anche la madre, non essendosi mai sposato Daniele era invecchiato da solo e senza figli. Vicino ai settant’anni gli fu diagnosticata una malattia incurabile, era in ambasce, ma dopo un’accurata riflessione pensò di chiedere al suo vice prediletto, De Angelis, di fare quello che lui aveva fatto a suo padre. Di De Angelis conosceva l’intenso fuoco repressivo, lo stesso che aveva animato i suoi primi anni in magistratura ed intuiva una vena sadica che eguagliava o forse addirittura superava la sua. Convocò Angelo De Angelis nel suo ufficio e gli chiese notizie di un caso sul quale il giovane magistrato si era accanito.
Ne discussero e Daniele si persuase che l’innocenza dell’imputato era lampante e chiara, ma gli fu altrettanto evidente la persecuzione che il suo sostituto aveva messo in atto contro quella sua povera vittima, volle dimostrarglielo e gli chiese il motivo di tanto accanimento.
Il De Angelis che conosceva la natura crudele del suo capo si confidò. Fuori dalla Procura, era stato importunato dalla moglie dell’imputato che piangendo ne aveva proclamato l’innocenza ed in ginocchio, con tre bambini aggrappati alla gonna, aveva implorato la sua pietà e la sua misericordia. Un coro di pianti, di preghiere, di suppliche, di terrore per il futuro che gli avevano fatto montare un furore tale che li avrebbe pestati tutti, calpestati come pidocchi lì per strada dove avevano avuto l’ardire di fermarlo, ma, con sforzo, si era contenuto pensando al suo stato che non gli consentiva d’abbassarsi a tanto e poi perché li avrebbe puniti più duramente facendo infliggere una pesantissima condanna all’uomo
I bambini affamati sarebbero stati sottratti alla madre e lui avrebbe avuto cura di farli internare in una casa famiglia dove avrebbero rimpianto d’essere venuti al mondo, la donna sola e senza mezzi avrebbe finito per perdersi.
Questa dichiarazione d’intenti da parte del suo sostituto convinse Daniele che la sua richiesta avrebbe potuto trovare accoglienza e sicuro di potersi fidare raccontò al giovane la storia dell’ avo e quello che lui aveva fatto a suo padre che glielo aveva quasi suggerito e che ora stava chiedendo a lui.
Il dottor De Angelis rispose che era spiacente di non poter obbedire, dato che la Legge punisce chi profana e vilipende un cadavere e quindi si permetteva di suggerire l’espianto degli organi. Disse: “una volta eseguito, signor procuratore può stare sicuro che non si sveglierà mai più.” Daniele si convinse e davanti a De Angelis scrisse che dopo il decesso gli fossero espiantati gli organi, il corpo cremato e le ceneri sparse al vento.
Alcuni giorni dopo, in aula, Daniele, dopo avere annaspato per alcuni secondi cadde a terra con un grido strozzato in gola mentre il giudice, che non si era accorto del suo malessere finiva di pronunciare una sentenza per non avere commesso il fatto nei confronti di un poveraccio per il quale Daniele aveva chiesto l’ergastolo. Cadde e nessuno si avvicinò per soccorrerlo, tranne un carabiniere che dopo avergli toccato la giugulare gridò: “E’ ancora vivo, chiamate un’ambulanza”.
Il dottor De Angelis, arrivato mentre stavano caricando il suo capo esanime sull’ambulanza, si qualificò al medico come magistrato e come esecutore testamentario del Signor Procuratore; aggiunse che lui stesso avrebbe assistito all’espianto degli organi e delle altre disposizioni del suo capo. L’ambulanza partì a sirene spiegate ed il dottor Daniele Vallelunga arrivato all’ospedale e poco prima che il suo cuore cessasse di battere del tutto, venne aperto come una valigia e gli tirarono fuori: cuore, fegato, milza, polmoni, reni; subito dopo lo ricucirono con una rapidità ed una precisione che il P.M. non si sarebbe mai aspettato dalla sanità della sua città tanto che sgranò gli occhi e pensò: “ Che velocità! Sembra d’essere in una valigeria cinese!” Tentò di richiudere gli occhi ma non ci riuscì perché glieli avevano tolti durante il suo pur breve attimo di sbalordimento. Però era contento Daniele, contento quanto può esserlo uno da morto fresco ed espiantato. Pensava “Mi hanno levato tutto, sono morto al cento per cento; ormai è sicuro che nella bara, sotto terra, non mi sveglierò certamente … sono morto … morto? … ma … ma … Ma io penso …Cogito ero sum! … Quindi tanto morto non sono! Ed ora dove mi portano? Alzano la bara … Noooo… il forno crematorio !!!… fritto sono … anzi bruciato. Il cervello! Me lo hanno lasciato, non li trapiantano i cervelli … Peccato ci sarebbero meno cretini in giro e si! Trapianterebbero soltanto cervelli con quozienti d’intelligenza alti, quelli dei pochi buoni, dei tanti cattivi, assassini, ladri, ma intelligenti: “meglio un ladro intelligente che un cretino onesto … Poi se tutti fossero onesti ed incapaci a fare del male che ci staremmo a fare magistrati, polizie, avvocati e cancellieri? Giusto… bella pensata! …E già io ancora penso! Beh sentirò le fiamme che bruceranno il mio corpo fino a ridurlo in cenere e non ci potrò fare niente … comunque è quello che volevo e poi sarà un attimo, calma! Meglio qualche scottatura che risvegliarsi vivi nella tomba …”
Tutto questo pensava Daniele, che sarebbe stato un momento soltanto, ma non fu così.
Sentì un terribile dolore appena il suo corpo fu avvolto dalle fiamme e quella fu l’ultima sua incancellabile ed eterna sensazione.