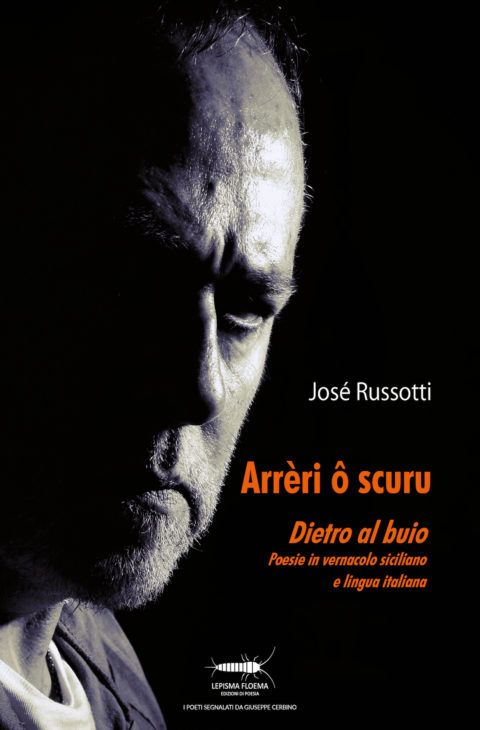“Sarudda e il Meli bacchico” – di Maria Nivea Zagarella
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 14 Ottobre 2022
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1281

Tradotto da Goethe e da Foscolo, ammirato da Leopardi, per il quale l’opera dialettale di Giovanni Meli era fra le poche da salvarsi dall’oblio, e da Pirandello che nel saggio L’umorismo scriveva che la poesia del poeta palermitano non fu sonata soltanto su la zampogna pastorale, ma ebbe anche tutte le corde della lira e si espresse in tutte le forme, Meli con il ditirambo Sarudda ha dato una delle prove più articolate della complessità della sua cultura, del suo spirito e della sua ispirazione. Un concentrato quasi della sua capacità di osservazione “realistica” del mondo e degli uomini, della sua lucida e amara visione intellettuale (sotto l’apparenza dello scherzo) e della sua abilità linguistico-stilistica. Quanto a quest’ultimo punto basti osservare l’opportuno variare di metri e ritmi secondo il variare dei gesti e degli umori e il crescendo di ubriachezza del protagonista, e l’incastro nel tessuto letterario, per efficace resa mimetica o effetto parodistico, di nomignoli popolari (Andria lu sdatu [fallito], Brasi galiotu [galeotto]…), di espressioni plebee (a taci maci, cacanaca, ciricocculu, l’acqua mali faciri/ vinu cunfurtibili, tsè-tsè [asino], sarrabutì…), o latine (ab hoc e abbacchi [ab hac]), o straniere anche alterate (sanatodos, trinch-vaini [trincke wein], tringh- lansi, vin de Fransi [trincke lange, vin de France]…), e di espressive onomatopee (ticchi-ticchi, tracchi-tracchi, bùffiti…). Questo miscuglio va evidenziato di colto e di popolare, spinto al limite del non-senso riscontrabile già nel testo, più “leggero”, che ha fatto da modello a Meli e al contemporaneo poeta catanese Domenico Tempio: il ditirambo Bacco in Toscana di Francesco Redi, scienziato e Accademico della Crusca, che al suo gusto formato sui classici unì l’innovativo sperimentalismo del Seicento, evolvendo il suo componimento da occasionale e iniziale brindisi conviviale (1673), in gara con un analogo testo di Lorenzo Magalotti, fino ai 979 versi della redazione finale stilata nel 1685 e passata anche attraverso vari titoli (Vini di Toscana, Baccanale dei vini di Toscana). Il ditirambo, nella lirica greca, era un canto corale intonato nelle processioni in onore di Dioniso, in cui alle lodi del dio si alternavano quelle alla sua sposa Arianna. Dal dialogo ditirambico fra il capo coro e i coreuti Aristotele fa derivare la nascita della tragedia classica. Redi immagina che Bacco e Arianna al ritorno dall’India sostino in Toscana, facendo esperienza “gustativa” dei migliori vini della regione e assegnando la vittoria finale al vino di Montepulciano. Nei versi conclusivi si legge: Bella Arianna, con bianca mano/ versa la manna di Montepulciano;/ colmane il tonfano, e porgilo a me… e più avanti: Onde ognun che di Lieo/ riverente il nome adora,/ ascolti quest’altissimo decreto,/ che Bassareo pronunzia, e gli dia fé:/ Montepulciano d’ogni vino è il re. Non è mitologica invece l’ambientazione di Meli, ma “realistica” (la Palermo popolare fra famose taverne e un volgare “festino“ di nozze), e il suo ditirambo -a detta del poeta di Cianciana, Alessio Di Giovanni- sarebbe stato “perfetto” e “coeso”, se Meli non vi avesse introdotto, seguendo la falsariga di Redi, le lodi pleonastiche dei vini siciliani, togliendo risalto al testamento di Sarudda. Di Giovanni con le sue riserve mostra di avere intuito che nucleo ispiratore profondo (e dissimulato) del polimetro sono il tema della Morte e dei limiti conoscitivi dell’uomo e il disagio “storico” di Meli, tuttavia il testo rivela una sua “coerente” logica interna e una perfetta coesione delle varie parti, che lo fanno adeguatamente “crescere” fino alla sua naturale conclusione: la perdita di coscienza dell’arciubriacatosi Sarudda (gira… sbota… trabballa… all’urtimata/ buffiti ‘nterra na strimazzunata) spintosi volontariamente fino a quell’estremo limite, preannunciato dai versi 112-116: Sorti curnuta, m’ai sta grazia a fari/ chi cantannu e ciullannu (bevendo) comu un mattu/ pozza tantu cantari, e poi ciullari/ pri fino chi, facennu un bottu (scoppio), scattu (io crepi). Il fatto è che in Sarudda Meli mimetizza in parte se stesso. Infatti è l’unico a non avere il nomignolo/nciuria che contraddistingue i suoi compagni di ubriacature che -il poeta stesso avvertiva nelle note dell’edizione del 1814- erano beoni celebri in Palermo della lega del basso volgo (con Andria e Brasi, Masi l’orbu [il cieco], Ninazzu lu sciancatu [lo zoppo], Peppi lu foddi [il folle]), cosi come erano donne distintesi in Palermo per la loro scostumatezza le convitate al banchetto di nozze dello ziu Roccu e di Betta la caiorda [la sozza]: Catarina la Niura, Narda Caccia-diavuli, Bittazza la linguta (linguacciuta), Ancila Attizza-liti, Rosa Sfincia (grossa) ‘Ntossica-mariti. Altrettanto noto il taverniere Bravasco nella cui reggia taverna ha inizio l’avventura di Sarudda. Antefatto “poetico” del ditirambo sembrano, per talune concordanze di linguaggio e immagini, l’ode Li baccanti e la Canzuni V (Ricetta ammirabili contra lu filatu [malinconia] ippocondriacu), entrambe presenti nell’edizione del 1787, ma esemplificative di tipi diversi di edonismo. Nella Canzuni la ricetta salvifica antimalinconia dei quattro amici menzu pazzi, con cui consumare vino a bizzeffe, pasta, salsiccia, carni salvaggina, ballare al suono di nacchere, liuti, citarrazzi (chitarracce) e giocare a carte sempre a testa vacanti e panza china, evoca sollazzi da luoghi comuni e un divertimento triviale, superficiale. Negli agili quinari dell’ode invece l’edonismo leggero, gioioso, smemorante da vivere con gli amici, la donnina di piacere, il calasciuni (strumento a due corde) e vinu abbuluni è classicamente (vedi Anacreonte, Orazio) cantato come risarcimento/alternativa ai guai della vita, alla gloria/fumu, alla gioventù jocu fugace, alla vecchiaia che arriva tremmula, alla Morte che ci accorcia i giorni e non distingue fra l’oro e il rame, vanificando ogni avara corsa alla ricchezze, donde le allusioni al non invidiabile “mercante” inglese, ai lontani porti del Messico e dell’aurifero Perù, e il conseguente invito a bere in un tedesco e francese storpiati (trinch-vaine/ frauli curtisa,/ maetres francisa/ alon tuchè). Nel ditirambo è come se i precedenti tasselli trovassero la loro definitiva, organica, collocazione integrando, nella teatrale messinscena del plebeo Sarudda sotto gli occhi di un uditorio affine e consenziente e ciclicamente appellato (amici, amici cari, mastri mei, cumpari Brazzitu…), il dato privato/personale (la visione esistenziale di Meli) con quello storico-sociale (l’occhio polemico dell’intellettuale), colorando in tal modo la sbornia di consapevole trasgressione. Nella strofe I Sarudda e i compagni, usciti dalla taverna dove hanno rumorosamente pranzato e vuotato fiaschi e botti, vanno saltando e ballando per le strade, schizzando col fango delle pozzanghere i passanti, accompagnati da un codazzo di persone che, mentre li burlano facendo olè, non appaiono meno grottesche o più “presentabili” di loro: picciotti e picciriddi,/ vastasi e siggitteri (facchini e portantini), cuccheri cu stafferi (cocchieri e staffieri),/ decani cu lacchè. L’orizzonte del poeta è la Palermo “irredimibile” del tempo. Nelle strofi II e III il quadro “si arricchisce” dei ritratti dei due sposi, Betta, figlia bastarda di fra Decu e Narda, brutta, cenciosa e rissosa, e Roccu, devoto di Bacco, morto di fame e vagabondo, e dei loro amici li chiù cunfidati (già citati) che stanno sturando il secondo barile di ottimo vino stagionato, sul quale nelle strofi IV e V si allippanu (gettano) Sarudda cu un imperiu d’Alessandru Magnu e la sua brigata. Dalla strofe VI alla XI Sarudda, tenendo in pugno un boccale ricolmo di vino spumeggiante dal ciauru chi pareva na musìa (prelibatezza), con tracotante braveria e minacciando insulti ai vili, aizza i compagni a bere smoderatamente (tummamu cumpà…) fino a crepare sotto il barile, e intona un brindisi/denuncia alla statua simbolo del Genio di Palermo nella fontana di Piazza della Fieravecchia, rinfacciandogli la sua decadenza: eri a tempu la vera cuccagna/ ti mantinivi cu tutta la magna… ora invece gli sprechi nobiliari, oziu, jocu, superbia ‘mmaliditta lo hanno ridotto senza un quattrino e non gli resta che pisciarsi e ripisciarsi la sditta (la disgrazia). Ma nei versi espunti dal poeta per timore della censura e recuperati dai critici l’attacco andava più a fondo: il “serpente” che morde al petto la statua simboleggia le “tasse” che “purgano e salassano” il popolo in una città piena di ‘mbrogghi e raggiri dove lu bonu accucca (soccombe), lu latru ciurisci (fiorisce), e il povero va a la furca. Perciò il bisogno di trincare abbondante, per scacciare i pensieri malinconici e vivere in compagnia di Bacco come (altra stoccata!) i monaci che cantannu, vivennu e manciannu/ campanu cu la testa ntra lu saccu. Solo quando fa smaccu (consumo stragrande) di vino Sarudda calpesta (sic!) tutti li cancari/ tutti li trivuli, e invoca pertanto, con rabbia, dalla sorte cornuta (sic!) la grazia di ciullari (nei versi espunti si legge più drasticamente: duri pi tuttu l’annu stu sistema di vita accussì esattu) fino a morire di sbornia! Quindi dalla strofe XI alla strofe XXX, mentre il vino gli “diluvia” nel petto e i suoi effluvi gli salgono alla testa, che gli gira come una trottola o un arcolaio; mentre continua a bere guarnaccia da un boccale che lo “bacia”, e guai a maritare il vino con l’acqua!; mentre tutto attorno gli gira, e balla: tetti tavole pavimento sedie, e Giove stesso pare piovere vino dalle caterattte e dai purticati spalancati del cielo e dal suo Empireu purpurinu, scatta, in un gioco frizzante e continuamente variato di versi ora più lunghi ora più brevi, quella euforica (criticata) girandola di elogi dei vari vini, volti ciascuno (moscato di Siracusa e di Catania, malvasia di Lipari, Risalaimi, vernaccia di Ficarazzi, vino di Ciaculli…) a ”sanare” e “riscaldare” specifici malesseri e specifiche categorie di persone. Fra facezie, luoghi comuni e divertimento gratuito, viene così lumeggiata (e fra le pieghe dei versi) la non molto felice condizione femminile (la monaca racchiusa, le zitelle affruntuseddi confinate in casa, le vedove per costume a lungo ‘ngramagghiate [a lutto], le maritate annoiate o gelose resesi laschi e friddi [mosce e fredde], la ragazza paffutella smaniosa cui -nei versi espunti- il padre vieta di sposare il suo beddu giuvineddu) e vengono efficacemente sbozzate miserevoli figurine di deboli di stomaco e di reni e di depressi cronici e atteggiati con gli occhi ‘nfurrati di prisuttu (foderati di prosciutto), e sono scherniti gli usi degli inglesi, che preferiscono la birra ai vini spirdatizzi (molto alcolici) siciliani, e dei francesi che prediligono quei vini delicati che per Sarudda sono acqui triacali (bevande vermifughe per bambini). Donde l’augurio che il sole continui a piovere gli influssi più propizi sui maglioli e che le vigne si salvino dall’assalto di vacche, merli e tordi, e il passaggio (strofi 31-41) alla lode di Bacco allegra-cori che annega tutti i mali e nel quale non solo si ricapitolano tutti gli effetti benefici dei suoi vini, ma accende il dio anche l’estro dei poeti e sa rendere poeta pure un cuticuni (zoticone ignorante) come Sarudda: un sulu to vuccuni (boccone) -afferma- / mi fa spacciari perni (perle). Sarudda è dunque sul punto di raccogliere tutte le sue forze per l’importante messaggio finale: il testamento e le disposizioni per il suo funerale (rivelandosi la Morte come il vero spettro sotteso e esorcizzato da ogni inebriamento di Piacere), funerale che come nel Satyricon di Petronio ha bisogno di un rumoroso sottofondo musicale (la popolaresca napulitana) a base di nacchere, tamburelli a sonagli, liuto e chitarra. E mentre gli serpeggia nelle carni l’inganno supremo di Eros (la bella fa a la gula nicchi e nicchi… ssi toi biddizzi quantu sù vigliacchi), dice che vuole essere collocato dopo morto (e dopo lavate le ossa in un tino ricolmo) dentro un magazzino del Borgo sopra una pila/mausoleo di botti, e tavernieri (tuttu tuttu l’interu lummardisimu) e compagni devono rompere per lui gotti carabbi (caraffe) carabbuni e ciaschi (fiaschi), celebrando l’offiziu di vinu pistammutta (pesta e imbotta), cioè bere continuativamente senza mai restare a vucca asciutta, e intanto formula il testamento (strofi 42-52) nocciolo della sua “filosofia“ del vivere. Contro la sorte instabile la felicità sta nel vino che magicamente trasforma in teatru di dilizii un mondo tuttu guai, ‘mbrogghi e spurcizii, e in una ciotola di vino vanno annegati, con l’impotenza della scienza e ragione umana incapaci a penetrare i segreti dell’origine del mondo e degli uomini, della forza di gravità, della varietà dell’esistente (pirchì [si chiede umoristicamente] longhi li vrocculi (broccoli), chiatti li cavuli, russi li fràuli (fragole), citrola storti?), i fallimentari tentativi degli alchimisti di trovare lu lapis (pietra filosofale), midicina universali. Nelle ultime due strofi il poeta descrive gli ultimi tentennamenti, sfinimento e stramazzata a terra di Sarudda, che portato via semimorto a cava-cavuseddu, sulle braccia incrocicchiate di due compagni, inerme comu un picciriddu (paragone espunto: comu un picciuneddu [piccolo piccione]) emblematizza per il Meli “bacchico” e di altri suoi pessimistici componimenti (le tre elegie Lu chiantu d’Eraclitu, La cugghiuniata) la sconfitta storico-esistenziale dell’uomo.