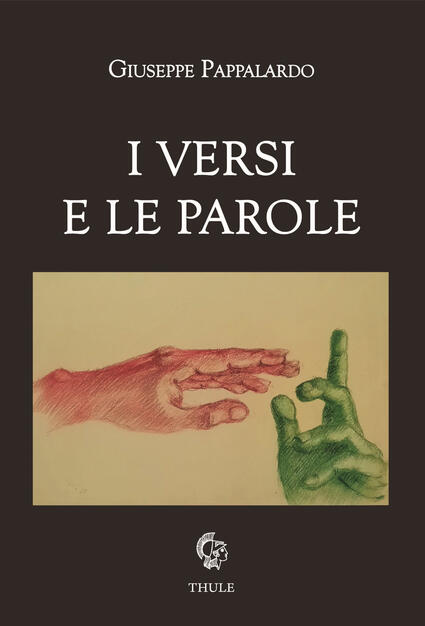“Senza eredi” di Marcello Veneziani – Commento di Giovanni Teresi
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 02 Dicembre 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1331
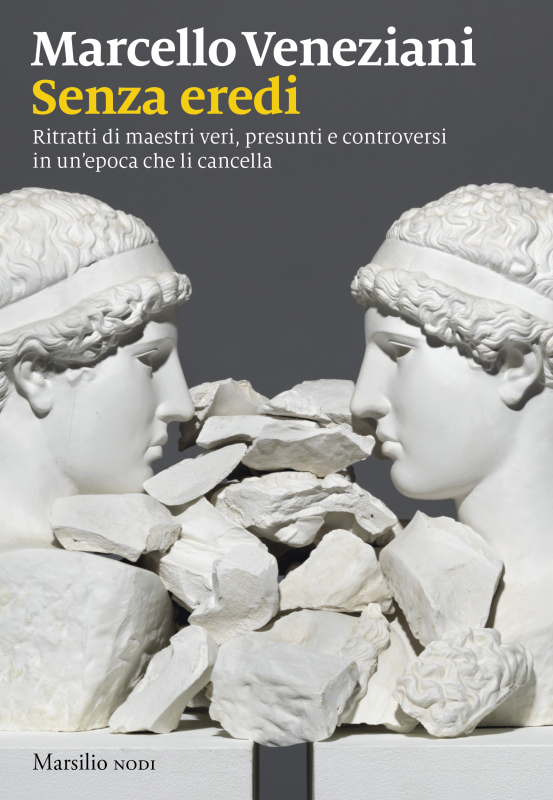 Dal testo: “Senza eredi” di Marcello Veneziani si evince subito la tematica affrontata dall’autore riguardo il problema che oggi ad essere senza eredi sono i classici, i grandi del passato, cancellati o abbandonati, e che la vera sciagura del presente non è l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale ma la ritirata dell’Intelligenza Umana.
Dal testo: “Senza eredi” di Marcello Veneziani si evince subito la tematica affrontata dall’autore riguardo il problema che oggi ad essere senza eredi sono i classici, i grandi del passato, cancellati o abbandonati, e che la vera sciagura del presente non è l’avanzata dell’Intelligenza Artificiale ma la ritirata dell’Intelligenza Umana.
In quanto viviamo una realtà tecnologica, in oblio del passato a partire dai grandi autori e dalle loro opere, Marcello Veneziani, per reagire a questa amnesia, ha composto una raccolta di settanta miniature di saggi, succinte biografie, profili non convenzionali nel libro: “ Senza eredi.”
Da Pascal a Vico, da Leopardi a Manzoni, da Baudelaire a Proust e a Kafka, da Vittimo a Ratzinger, fino ai pensatori e scrittori più vicini a noi e viventi.
Senza eredi non è possibile un pensiero nuovo, rivolto al futuro e all’essenziale, in grado di superare la nostra società dell’oblio che tende a perdere il senso critico, la cultura e l’umanità.
Il tempo non è galantuomo ma smemorato: non renderà giustizia. Allora è necessario ribellarsi e riprendere i giganti della storia e della letteratura.
L’autore si pone delle domande. Perché non c’è più un pensiero nuovo? Perché non è pensabile, non è convertibile in pratica. Oggi il nuovo si addice ai modelli della tecnologia che seppelliscono i precedenti: nuovo può essere uno smartphone, un tablet, un’app, un video, uno spot. Ma un pensiero nuovo è inconcepibile. Ciò che è nuovo invecchia in fretta e cede il passo al più nuovo.
Così, ci fa riflettere: “A un narratore chiediamo di portarci via di qui, di farci vedere un’altra vita, o comunque con altri occhi sotto altra luce. A un pensatore, invece, chiediamo di portarci nel cuore delle cose, di darci le chiavi per entrare nell’essenziale o per ricercarlo, tra libertà e destino.”
Cosa vuol dire oggi il pensiero se non comporta un’applicazione, ossia conseguenze pratiche nel condurre la propria vita? “Può esserci un’emozione, un evento un accesso, però cos’è il pensiero oggi, se non sterile, astratta, ineffabile, improduttiva concettualizzazione?. Così diventa impossibile concepire il mondo, la vita, la morte e oltre. Non è un pregiudizio idealista, ma la nostra civiltà vive nel declino e nell’attesa della morte anziché della nascita, finché non riuscirà a pensare il nuovo. Il Nostro, inoltre, fa altre reali considerazioni in merito alla filosofia: “ Il pensiero è una nuova vista, mentre la filosofia sta scemando in una nuova cecità, sorretta dal bastone bianco dell’innovazione tecnologica e guidata dal cane-lupo del dispositivo elettronico.”
E continua ad asserire che il pensatore vuole intelligere il mondo e non si arresta davanti alla soglia del sacro e della profezia, della scienza, dell’arte e della vita, e lancia “sguardi sul mondo attuale”, come s’intitola un’opera di Valéry, penetra l’epoca che vive e compara le civiltà.
Purtroppo, filosofo è diventato colui che dell’universalità ha fatto una specializzazione. Pensatore è colui che abbraccia con il pensiero la vita e tende all’assoluto, in una visione del mondo, non in un sistema. I pensatori rimangono per così dire a piede libero, solitudini astrali e viandanti del pensiero. A tal proposito l’autore conclude che “per capire la vita, il mondo e la condizione umana il pensatore intreccia saperi ed esperienze, non è irretito da un sistema e da un lessico, o ingessato in un corso d’insegnamento”.
Davanti al disordine universale e a una quantità di situazioni e problemi inediti, davanti a “un regime permanente di perturbazione delle nostre intelligenze”, nota Valéry, gli insegnamenti del passato sono più da temere che da meditare e le previsioni sono vane e sbagliate; bisogna invece saper leggere il presente per preparare, affrontare, resistere o utilizzare gli eventi, modificando in noi “ tutto il sistema delle attese”.
Marcello Veneziani ci fa riflettere sul fatto che alla fine, in una società senza eredi, l’intelligenza artificiale resta l’unica erede universale in cui confluiscono, liofilizzati e polverizzati, tutti i saperi e ogni cultura devitalizzata diventa un granello d’informazione nel Big Data Universale.
Sempre che il mondo senza eredi non si riveli un mondo senza pensiero, dove non ha più senso pensare, non c’è più tempo né luogo né convenienza per farlo.
E allora da dove ripartire?
Qui, il Nostro, prima di dare una risposta, fa delle riflessioni citando autori come Anne Geddes e Socrate. “Pensiamo al nostro presente, così avaro di bambini e di natalità, che giudica oscena la fertilità e offensiva, bestiale, retrograda la gravidanza e la maternità. È il tempo in cui l’aborto diventa un dogma costituzionale. È il tempo dei figli di Nessuno, degli uteri in affitto, della compravendita dei neonati. … È il tempo del declino e della decadenza.”. Ma, nel testo Small Word di Anne Geddes, l’autrice madre, dice semel mater semper mater , una volte che si è madri lo si è per sempre. “Attorno ai bambini appena nati, dice Anne, c’è solo il bene ed è questo che mi affascina”. L’inerme, assoluta purezza del bene e del bello in natura.
La nascita è promessa di eredità. La vita che nasce è la più bella risposta a ogni perdita, passata, presente e futura. Ogni essere vivente nasce da un essere vivente, omne vivum ex vivo, e la nascita di umani resta la risposta essenziale a chi abdica in favore dell’Intelligenza Artificiale e lascia ogni eredità. Socrate diceva di praticare con il pensiero l’arte di sua madre levatrice. I concepiti in lui erano i concetti. Questa è l’arte di pensare, di scrivere, di essere autori: arte maieutica che tira fuori il nuovo da chi ascolta, da chi legge, dalla vita.
Il pensiero ha bisogno di nascere, di tornare alla sorgente. È pensiero aurorale. Scrivere è come partorire, pensare è come portare alla luce, narrare è venire dal mondo.
Anche se devono morire, gli uomini non sono nati per la mortalità, ma per incominciare, scrive Hannah Arent in “Vita activa”.
Nella società senza eredi non c’è sopravvivenza né riscatto postumo. Non ci sarà un altro tempo,
non ci sarà un altro mondo. Alla fine, il problema non è il fatto che la gente dimentica, ma che vivendo tra mode e consumi, ascoltando gli influencer, i manipolatori dei desideri, mancando un pensiero, la gente vive confusa il presente, e quando in realtà tante cose scompaiono dal mondo fisico, possiamo immaginare quante ne vengono continuamente dimenticate.
L’idea stessa di educazione è ormai considerata una violenza autoritaria, un’inaccettabile prevaricazione di una personalità su un’altra. Senza l’autorità c’è l’autonomia, ma arriverà poi la tecnologia a trasformare l’autonomia in automatismo, in cui le scelte si generano in maniera meccanica. La tradizione era fondata sul principio di eredità biunivoca, ricevuta e consegnata, in virtù della quale siamo “ eredi gravidi”. Il passato, quando non demonizzato, va cancellato, rimosso, superato. Tutto accelera, si meccanizza e si sostituisce. Non ci sono più maestri neppure laddove, per storia, istituzione e professione, dovrebbero esserci. L’insegnante, cioè colui che lascia il segno, è meno di una guida e poco più di un istruttore, un coach o un animatore.
Nella perdita progressiva di eredità, finisce anche un mondo che accompagnava i libri e i lettori, le letture e gli autori. Finisce la civiltà letteraria, inabissatasi insieme al dibattito culturale. E più i giornali si fanno simili ai social, alla tv, alle mode dell’epoca, più si rendono superficiali, irrilevanti.
Il Nostro ribadisce che bisognerebbe riaprire la mente; invito unanime a riconoscere le differenze e ad ammetterle in campo.
Io sono pienamente d’accordo e inviterei tutti a riappropriarsi di sé stessi, a riscoprire una dimensione interiore che può condurci alla virtù e a una vita felice. E come dice Seneca: “Vindica te tibi”, massima di carattere morale ma anche un’esortazione amichevole, una delle tante espressioni intime e fraterne che ci restituiscono la cifra di una pedagogia non convenzionale ed estremamente moderna. La locuzione latina vindica te tibi compare all’inizio della prima delle “Epistole a Lucilio” di Seneca, all’interno della frase:
“Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus quod adhuc aut auferebatur aut subripiebatur aut excidebat collige et serva”.( “Fai così, mio Lucilio: rivendica te stesso a te stesso, e il tempo che fino adesso ti era o sottratto o portato via o che ti scivolava via, ricomponilo e preservalo”).
Il tono di tutta la frase è confidenziale e amichevole, è il suggerimento di un maestro che anziché impartire lezioni cattedratiche a un allievo lo esorta fraternamente, si mette sul suo stesso piano, dispensando suggerimenti pratici che si sostanziano di posizioni filosofiche ben definite.
Il tema è quanto mai attuale: Seneca suggerisce, innanzitutto, a Lucilio di riprendersi sé stesso.
Abbiamo diritto soprattutto al nostro tempo, che Seneca considera come l’unico vero bene, e che spesso ci viene sottratto dalle questioni mondane in cui restiamo invischiati ma che, ancor più spesso, per negligenza nostra, lasciamo quasi inconsapevolmente fuggire via.
C’è, in questa esortazione, un forte richiamo alla dimensione dell’interiorità; se volessimo usare le parole di Sant’Agostino, non commetteremo grandi errori a parafrasare con il suo “redii in te ipsum”: ci riappropriamo, infatti, del nostro tempo quanto riusciamo a distanziarci e a mettere tra parentesi gli affanni del mondo, quando allontaniamo l’ansia e smorziamo la fretta, ma anche quel turbinio di stimoli futili che affollano lo schermo del nostro cellulare.