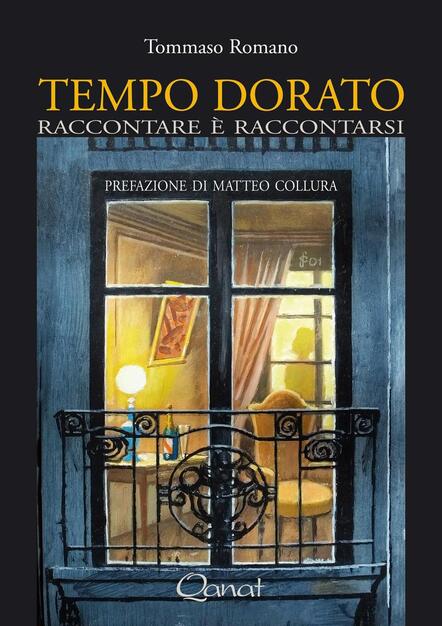“Note esplicative sulla mia lettura dell’ultima opera del pittore Nuccio Squillaci” di Piero Montana
- Dettagli
- Category: Arte e spettacolo
- Creato: 09 Agosto 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 849
 Forse può sembrare eccessivo, se non fuori luogo, che in un’opera pittorica un critico d’arte possa parlare di teofania. Ma se lo Spirito Santo è una componente della Trinità Divina, la manifestazione dello Spirito in un’autentica opera d’arte non può che trovare il suo nome più appropriato che in quello di teofania.
Forse può sembrare eccessivo, se non fuori luogo, che in un’opera pittorica un critico d’arte possa parlare di teofania. Ma se lo Spirito Santo è una componente della Trinità Divina, la manifestazione dello Spirito in un’autentica opera d’arte non può che trovare il suo nome più appropriato che in quello di teofania.Lo Spirito Santo come tutti sanno per mezzo della Grazia può illuminare l’uomo e questa illuminazione dello Spirito, quando ciò accade, di conseguenza viene a manifestarsi nei suoi atti e nelle sue opere.
Ora tra tutte le opere dell’uomo, l’opera d’arte è quella che più rivela la manifestazione dello Spirito.
Negare questa evidenza è rendersi ciechi innanzi a un fenomeno, che pur avendo una base materiale su di essa proietta la luce non beninteso quella della ragione, come per i razionalisti, che tutto vogliono comprendere e spiegare, riducendo il tutto alla logica dei concetti, bensì la luce del Mistero e dell’Ineffabile ossia la luce dello Spirito.
Teofania dal greco theophàneia composto da theos («dio») e da phàinein («manifestarsi») non può che rinviare anche a φῶς (phaos/phōs ), che si deve considerare come la radice di phànein. Φῶς è dunque l’indispensabile, necessaria luce con la quale solo può attuarsi ogni manifestazione sovrannaturale o meno.
Con il termine theophàneia si deve pertanto intendere rigorosamente quella manifestazione di Dio, o dello Spirito che è una delle sue ipostasi, nella e attraverso la luce, ma, forse ancora più in profondità, la manifestazione divina nella sua essenza luminosa.
Un esempio. La gloria di Dio fu annunciata a Mosè sulla vetta del Sinai in uno scenario e con un gesto terrificanti. Geova discese in una nube e pronunciò il suo nome. Là Mosè stette con Geova per 40 giorni e 40 notti senza averne visto il volto e tornò, dopo questo incontro, trasfigurato: << Quando Mosè scese dal Monte Sinai, portando con Sé le Tavole della Testimonianza, non sapeva che la sua faccia era diventata raggiante, mentre parlava con il Signore. Ma Aronne e tutti i figli d’Israele, guardando Mosè, videro che la sua faccia era raggiante ed ebbero timore d’avvicinarsi>> (Esodo, XXXIV, 29-30).
Commentando tale episodio della Bibbia, Baltrusaitis nel suo libro “Lo specchio” così scrive: << Questo splendore altro non era che il riflesso della gloria di Dio. Segni profondi di questo grande incontro (con il Divino) sono rimasti sul volto del profeta che Dio ha fatto specchio della propria luce.>>
Dunque con questo incontro con Dio, Mosè, senza saperlo, subisce una trasfigurazione, che per il popolo d’Israele, è però, senza alcun dubbio, una teofania nel vero e profondo senso della parola, una teofania ossia una manifestazione di Dio nella sua essenza di luce.
E’ questa essenza luminosa o forse un suo diafano riflesso, che ci ha colpito nell’ultima opera di Squillaci. Per questo abbiamo parlato a riguardo di un incontro del pittore con Dio, essendo per noi tale essenza di natura propria del sovrannaturale, che ci ha portato a definire per l’appunto questa sua ultima opera un diamante di luce trascendente.
Fin dall’inizio della nostra esposizione critica su di essa noi rischiamo dunque di essere incompresi, giacché la critica moderna si fonda sui quei dati materiali, che solo ritiene oggettivi, negando realtà a tutto quel che li trascende.
Ed è questo un grave errore della critica, giacché l’arte contemporanea a partire proprio dall’astrattismo ha voluto essere al contrario una testimonianza fortemente caustica nei confronti del materialismo, ideologicamente, culturalmente imperante nel nostro tempo.
Materialismo, in base al quale si sostiene quindi riguardo alla pittura, che la sua materia sono i colori e che questi sono o derivano esclusivamente da terre.
Ma affermando questo, non ci si accorge neppure di restare ciechi innanzi all’opera di un vero pittore e non di un semplice, banale illustratore, giacché l’arte del pittore, quel vera, quella che ha davvero valore, consiste proprio nell’estrarre dalle terre, che sono la materia, la loro quinta essenza: la luce dei colori.
Per troppo tempo, a causa di una lunga tradizione aristotelica, sì è considerata la quinta essenza come un elemento puro, un elemento a parte, altro dai quattro (terra, acqua, aria, fuoco), elemento pertanto da collocarsi nelle alte sfere del cielo, al di sopra della materia del nostro mondo.
Che la quinta essenza non stia in alto, nell’etere, bensì qui in basso sulla terra da cui si può estrarre, ce lo dimostrano le ricerche degli alchimisti, ma soprattutto ce lo suggerisce il mondo vegetale che da essa (la terra), trae la linfa, quel nutrimento a cui l’albero non solo deve il suo rigoglioso sviluppo ma anche la meravigliosa epifania di questa quinta essenza: la luce, lo splendore dei fiori e dei loro colori.
Estrarre dalla terra la luce è il compito metafisico del pittore, giacché questa luce può essere estratta solo dallo spirito dell’artista, la cui arte consiste nel disseppellirla e dunque portarla alla luce, non alla luce delle percezioni sensibili né alla luce dell’intellegibile, bensì alla luce di una dimensione altra, in cui solo può rivelarsi lo spirito dell’uomo, illuminato dallo Spirito Divino, in una fenomenologia, che non ha nulla di hegeliano, giacché luce di una materia colta al di là delle percezioni sensoriali e delle categorie razionali, su cui si fonda la logica di Hegel, fondamento della sua alquanto nota Fenomenologia dello Spirito.
Ora questa ricerca della luce assai evidente in opere di Squillaci è un superamento di una concezione dell’arte, espressa a partire degli anni 40 del secolo scorso, dai così detti pittori informali.
Con essi il nostro artista avrà in comune il rifiuto della forma e della figurazione e di certo una predilezione per la materia e il suo impasto. Ma la materia pittorica, che gli è più congeniale è quella che gli si rivela come sostrato, supporto dell’anima, quella in altre parole in cui lo Spirito, come in un tempio, trova la sua dimora.
Questo comporta che lo Spirito di natura trascendente ha il suo luogo in questo mondo e non nell’Altro, irriducibile ad esso. Ripetiamo in questo mondo e non nella sua negazione o svalutazione, nell’ errata convinzione che la materia, che lo costituisce, soggetta a corruzione sia l’essenza del Male. Questo lo hanno creduto gli gnostici cristiani e pagani, smentiti da Plotino. (Enneadi II, 9)
In verità la materia per come Squillaci ce la rivela nelle sue opere pittoriche è anch’essa di origine celeste, giacché impregnata di quella luce non fisica, che è la luce riflessa, in un supporto materiale, da uno Spirito di natura divina, celeste.
La materia come luce dello Spirito, come luce della Purezza in essa riflessa, per quanto riguarda l’arte contemporanea ha avuto un’evidente espressione nella pittura di Morandi, ma Squillaci influenzato dall’informale ce ne fornisce nelle sue opere una versione avulsa anche dalle figure alquanto minimali e stilizzate di vasi e bottiglie dipinti dal grande maestro bolognese.
Squillaci, in quanto artista del nostro tempo, della teofania, da intendere come manifestazione dello Spirito ipostasi della Trinità, vuol comunicarci attraverso la sua pittura, una visione tout court, nella semplice Forma di una luce abbagliante ed ineffabile, che non é altro che luce trascendente, senza perciò dover ricorrere agli angeli o a figure affini impregnate di divinità, così come hanno fatto i pittori della nostra pur gloriosa tradizione, convinto com’ è che l’aura del Divino trovi la sua manifestazione in quel mistero, di cui nessuna forma, nessuna figura può renderci conto.