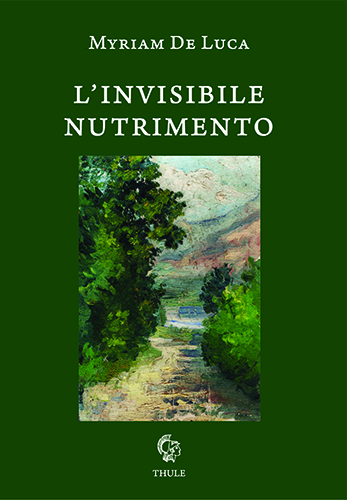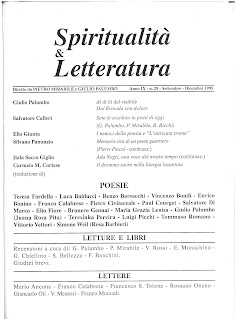I Parte - “Quando una lingua non basta: Beppe Fenoglio e Cesare Pavese” di Dario Pasero
- Dettagli
- Category: Scritture
- Creato: 08 Maggio 2024
- Scritto da Redazione Culturelite
- Hits: 1158

I
Beppe Fenoglio: La MALORA
Il 1° di marzo del 1922 nacque ad Alba (Cuneo) Beppe Fenoglio, il quale, nella seconda metà degli anni ’30, frequentò il locale ginnasio-liceo classico Giuseppe Govone[1], dove, tra gli altri insegnanti, si trovò particolarmente a suo agio con la docente di inglese Maria Lucia Marchiaro. Delle lezioni di letteratura inglese durante gli anni ginnasiali egli ricavò non solo modelli linguistici, ma anche morali, così come possiamo ricavare dalle sue stesse opere, in cui uno dei riferimenti a lui più congeniali è la storia inglese del secolo XVII, rinvenibile in filigrana sia nella scelta del soprannome partigiano di Milton, che egli scelse per il protagonista di vari suoi racconti, sia nella figura emblematica di un round-head[2], cioè un soldato dell’esercito repubblicano di Oliver Cromwell, cui egli si paragona spesso[3].
Dal punto di vista linguistico, invece, l’eredità più evidente lasciatagli dallo studio dell’inglese è – come si sa – la presenza, massiccia ed invasiva talora fino al parossismo, di termini inglesi intercalati, con estrema nonchalance dovuta alla padronanza assoluta dello strumento linguistico, nel tessuto lessicale italiano del testo del romanzo Il partigiano Johnny[4], in cui la presenza di una sorta appunto di “sostrato” inglese ha fatto sì che l’attenzione sulla lingua dell’autore si concentrasse sui rapporti italiano-inglese, tralasciando (almeno in parte) il rapporto tra quella che doveva essere la lingua materna fenogliana, cioè il piemontese (sia la koinè regionale che la sua variante langarola)[5], e quella imparata sui banchi di scuola, cioè l’italiano.
La lettura dei testi fenogliani[6] ci presenta infatti una presenza continuativa di piemontesismi, sia (soprattutto) lessicali sia sintattici e fonetici, oltre ad un discreto numero di forme idiomatiche, presenti in maggior misura nelle parti dialogate, ma tuttavia non del tutto assenti anche in quelle narrative o descrittive. Certamente troviamo una maggior quantità di voci piemontesizzanti in testi ambientati nell’alta Langa e narrati in prima persona e/o con molte parti dialogate, come La malora[7], mentre più rare tali voci sono in testi o ambientati ad Alba (o con protagonisti comunque cittadini) oppure – dal punto di vista narratologico – che prevedano un narratore esterno.
A questo punto vediamo da vicino le più evidenti forme piemontesizzanti nel romanzo breve La malora.
1. Fonetica
Un solo esempio di fenomeno fonetico chiaramente piemontese: bei stupidi (406), adattamento del piemontese bej stùpid[8].
2. Lessico
Si collocano in questa categoria sia a) prestiti o calchi di parole piemontesi, solamente traslitterati in italiano, sia b) termini che, pur esistenti anche in italiano, sono tuttavia da Fenoglio usati in un’accezione peculiare del piemontese, differente rispetto al loro uso nella lingua nazionale.
a)
bricco (brich): collina, altura, anche in senso metaforico “gran quantità” (cfr. it. “montagna di…”), un bricco di cose (397); cabalizzare (gabolisé): ipotizzare, indovinare (393); cadreghino (cadreghin, diminutivo di cadrega, “seggiola”): seggiolina (410); cascinai (cassiné): proprietari o conduttori di cascina (419); censa (censa): privativa di tabacchi (372); chiabotto (ciabòt): casetta rustica (407); corba (còrba/gòrba): cestino (381); diffizioso (difissios): diffidente, difficile da accontentare (398); disgenato (dësgenà): non imbarazzato (400) e, al contrario, genato (genà: imbarazzato; 412) e genava (dal verbo gené; 419); droganti (drogant): imbroglioni (392); frusto (frust): consumato (410) e sono frustato (sono consumato, dal verbo frusté; 425); lingeria (lingerìa): biancheria (423); macello gentile (masel gentil): macelleria, specificamente di vitelli (372); paglione (pajon): pagliericcio (379); partitante (partitant): compagno di gioco, di partita (405); paste dolci (paste dosse): pasticcini (405); pelandracce (plandrasse): sfaticate (usato come peggiorativo di plandra, pelandrona) stroppo di pelandracce (374); penduto (pendù): appeso (420); piumarli (piumé): spennarli, usato in senso metaforico come l’it. “spennare” al gioco (392); porrata (porà): termine di cui l’autore stesso dà nel testo la spiegazione[9] (434); rubarizio (robarissi): furto (409); sbardati (sbardà/sbardlà): dispersi (421); schiavenze (s-ciavensa): cura di un podere d’altri (431); schivare/schiviare (schivié, ed anche nella forma riflessiva schiviesse): mettere da parte, farsi da parte (riflessivo) schivarmeli (“mettermeli da parte”; 371) schivai un po’ di soldi (“misi da parte”; 429) oppure ancora “evitare, tenere lontano” se potevo schivarlo lo schivavo (419); sfisonomiata (nell’espressione “la voce… sfisonomiata”; [dë]sfusumià): alterata (425) ed allo stesso modo lo sfisonomiava (“gli storceva i lineamenti”, dal verbo dësfusumié; 405); smangiate (smangé): corrose, sfilacciate (410); stanchità (stanchità/strachità): stanchezza (408); si stortagnavano (stortagnesse): si contorcevano (408); stracco (strach): stanco (374); stroppo (strop): gregge, mandria (e per traslato: gruppo) stroppo di pelandracce (374); svegliarino (dësvijarin): sveglia (410); sversa (nell’espressione “anima sversa”; svers): sconvolta (399); tiretto (tirèt): cassetto (423); travata (travà): trave centrale (378).
b)
abbrancata (brancà): attaccata (401); andare (nel nesso “far andare”; fé andé): lavorare la terra far andare la terra (398); arrangiare (nell’espressione: “t’arrangia lo stomaco”; rangé): sistemare, mettere a posto (401); arrembarsi (arambesse): avvicinarsi ci si arrembarono (396); ascoltare (scoté): ubbidire (392); avanzare (vansé): evitare o risparmiare avanzare lo zolfino (373); battere (nell’espressione “battere i mercati”; bate ij mërcà): vendere al mercato (372 e 376); i bracci (ij brass): le braccia (375); budelle (buele): budella (380); buon’ora (bonora): presto (383); cimentarsi (cimentesse): stuzzicarsi, darsi fastidio si cimentavano (396); comandare (comandé): ordinare (usato in genere all’osteria) comandai una bottiglia (436); comprare (caté [na masnà]): partorire (423); contentare (contenté): accontentare mi contenta (377); cuciniera (cusinera): cuoca (389); fardello (fardel): corredo da sposa (387); figlio (specialmente nella formula “un bravo figlio”; fieul/brav fieul): ragazzo[10] (400), oltre che anche “figlio”; forgiare (forgé), usato come intransitivo: essere fatto in certo modo, pensarla in un certo modo ero forgiato (383); garretti (nell’espressione: “giù fino ai garretti”; garèt): talloni (395); gesto (gest): azione, fatto (specialmente in senso negativo) che gesto (395); giornata (giornà): misura terriera piemontese, equivalente a 3.810 m2 (379); giuntare (gionteje): rimetterci ci avrei giuntato (402); governare, solo nell’espressione “governare le bestie” (goerné le bes-ce): accudire alle vacche (430); incamminare (ancaminé), usato in forma transitiva: cominciare incamminargli il discorso (402); incontrare, usato in forma intransitiva assoluta (ancontré): avere fortuna non incontriamo (418); mancare (manché): (eufemistico) morire era mancato (371); mischiare (mës-cé): nell’espressione “mischiare un mazzo di carte” lo mischiava (404); naturale (natural): carattere (388); onta (onta): vergogna non ti piglia l’onta? (381) si lasciò prender dall’onta (432) e così l’aggettivo ontosa: vergognosa (405); originale (original): strambo (417); particolare (particolar): piccolo proprietario agricolo (387); partita (partìa [’d gent]): gran quantità, numero; nell’espressione “una partita di…” una partita di gente (404); pastura: il pascolare in pastura (374); perdonare (përdoné): condonare, lasciar perdere stasera ci perdonate il lume (405); pertugio (përtus): buco (386); pilone (pilon): edicola votiva campestre (407 e 428); ramazzare (ramassé): letteralmente scopare, ma usato col valore traslato di raccogliere, prendere tutto, far piazza pulita ramazzava la posta (404); riva: costa, fianco (di una collina) la riva da legna (373); rocca (ròch/ròca): masso, macigno (401); scorciare (scursé): accorciare scorciato i capelli (377); scuro (scur): sera (nella locuzione a scur: a sera) a scuro (372); servente (serventa): serva, domestica (383); servire (serve/servì): essere servitore (in campagna) avevano già servito (377); slargare (slarghé/slarghesse): spargere si slarga la voce (410); soffrire, transitivo e in espressioni in genere negative (sufrì/seufre): sopportare non poteva soffrirlo (419); solette (nell’espressione “far solette”; fé solëtte): fare la calza (426); spesso, come sostantivo: l’insieme ammassato di qualcosa lo spesso delle case (382); spogliare, nell’espressione “spogliare la meliga” ([dë]speujé): sfogliare il granoturco (dëspeujé la melia; 419); studiare (studié): pensare attentamente, riflettere o cercare una soluzione lasciami studiare (399); svariare, usato come intransitivo pronominale (svariesse): divertirsi (412); taglie (taje): tasse pagare le taglie (373 e 378); tempesta (tampesta): grandine (378); tirare, nell’espressione “mi sentivo tirato verso”; essere attratto (406); tossico (tòssich/tòssi): veleno (380); uomini (òm/òmini): mariti (389); inoltre l’espressione buonuomo per “sempliciotto, ingenuo, poco furbo” (407); vegliare (vijé): nel senso specifico di “si faceva la vijà (veglia) nella stalla” (398); verga (vërga): fede nuziale (387).
In particolare notiamo l’uso dei pronomi, quello delle reggenze verbali, ed alcune costruzioni sintatticamente diverse da quelle italiane, alcune delle quali – invero – potrebbero anche essere registrate nell’elenco, successivo, delle forme idiomatiche.
da me solo: da me (372; da mi sol); non me ne sarebbe fatto niente: importato (380; a sarìa famne gnente); mentre che ero: mentre ero (382; mentre ch’i j’era); tanta di quella gente: così tanta gente (383; tanta ’d cola gent); della meglio: della migliore (387; dla mej); niente del tutto: assolutamente niente (390; nen d’autut); con tutto che: per quanto, benché (394; contut che); con più niente da dire: senza nulla più da dire (398; con pì nen da dì); né di sì né di no: né sì né no (400; che ’d si e che ’d nò); guardava di storto: guardava storto (400; dë stòrt); da raro: raramente, di rado (402; da ràir); dirmelo amico: considerarlo amico (404; dimlo amis); lungo questa settimana: durante (405; arlongh costa sman-a); discorrergli insieme: parlargli (407; ciaciareje ’nsema); ce n’è almeno mezzi più indietro di me: c’è almeno la metà meno bravi di me (412; a-i n’j’é almanch mesi); per nostro conto: per conto nostro (416; për nòst cont); né più né meno che te: di te (417); aveva solo fatto che prendere: non aveva fatto altro che… (419; a l’avìa mach fàit che); non si sentiva più che chiamare: si sentiva solamente chiamare (420; as sentìa mach pì ciamé); esserci al caso: essere nel caso in cui (420; esse al cas); fin passato: fin oltre (420; fin-a passà); il più su che arrivai: il punto più alto a cui… (421; ël pì sù ch’i son rivaje); a mio povero figlio: usato senza l’articolo determinativo (438; a me pòvr fieul).
Forme idiomatiche ovvero modi di dire tipici del parlato quotidiano:
sia scesa alla mira di: sia arrivata al punto di (372) e siamo a una buona mira: siamo ad un buon punto (379); in mira ai figli: di fronte ai (380) e alla mira degli altri, all’altezza degli altri (383); si viene a una mira che: si arriva ad un punto che (409)[11]; col cuore in bocca: col cuore in gola (373); Braida: uso del cognome, da parte della moglie, per indicare il proprio marito (374 e 423: Rabino); con del buon tempo: tempo da perdere (374; ëd bontemp); tirò un numero: andare di leva (374; tiré ’l nùmer); in paga: in contraccambio, in ringraziamento (375 e 421; an paga); il mazzo ce l’aveva sempre lui: era sempre al centro dell’attenzione, teneva sempre banco (375; avèj ël mass an man); uno scudo: moneta da 5 lire (375); le dava dei nomi: la insultava (376, dé dij nòm/nomass) e mi caricavi di nomi: di improperi (423); alla larga nel bosco: libero (377), mi diede la larga: mi lasciò libero (384) e diede la larga: liberò (420; dé la larga); bestemmiare un’esagerazione: moltissimo (381); sotto il grano e sotto l’uve: al tempo del raccolto del… (381); c’è posto che: può darsi che (381); alzargli gli occhi in faccia: guardarlo in faccia, negli occhi, sfidarlo (384); o assassino: disgraziato, usato come insulto (384, ah sassin!); per quattr’ore: per le quattro (384; quatr ore); allungato le gambe sotto una tavola: mettersi a pranzo, in genere nelle feste (387; slonghé le gambe sota la tàula); cos’aveva visto: cosa le era capitato (390; cò a l’avìa vist); ci faceva basta: ci bastava (392; a fà basta); gli aveva dato sul cuore: danneggiato il cuore (394; dé an sël cheur); il tempo s’era girato: era cambiato (396; ël temp a l’era virasse); dare i due botti: suonare le due (al campanile) (398; dé ij doi bòt); le case in faccia: di fronte (398); le disse tutto attaccato: tutto di seguito (399; tut tacà); parlato del vento e della pioggia: del più e del meno (400; dël vent e dla pieuva); m’aveva attaccato una festa: aveva parlato male di me (404; taché na festa); non c’è nessun confronto: non c’è paragone (405; pa gnun confront); della mia leva: mio coscritto, coetaneo (406); assaggiarlo bagnato nell’olio: averci a che fare sempre (407; tastelo bagna ’nt l’euli); con la pancia lunga: dover attendere quando si ha fame (411; avèj la pansa longa); di sua scienza: di testa sua, con la sua esperienza (414; ëd soa siensa); toccarlo nei soldi: toccare negli affari o costringere a pagare o ancora chiedere un prestito (415; tochelo ant ij sòld); allegro: modo di salutare (415; alégher!); una faccia mezzo e mezzo: così così (417; mes e mes); madame di cascine: signore (ricche) cascine (418); avevano più caro: preferivano (419; avèj pì car) e ho più caro (427); venivo su a once (probabilmente altra grafia per a onge, cioè “a unghie”): a piedi (421); passata sul raspo: alla meno peggio, alla lontana (426; calco per passà sla rapa); che metà bastavano: che erano fin troppe (427; la metà a vansava); non era fuori del caso: non era impossibile, strano (428; pa fòra dël cas); mi tiravano le satire: mi prendevano in giro (434; am tiravo ’d sàtire).
II
Beppe Fenoglio: I Romanzi e I Racconti
Dopo aver analizzato le forme piemontesizzanti in La Malora, proseguiamo ora rintracciandole anche nel resto dell’opera fenogliana[12]. Anche per le restanti opere narrative di Fenoglio manteniamo la scansione di analisi adottata per La Malora[13]: lessico, distinguendo i termini piemontesi (calchi e/o imprestiti) solamente trascritti in italiano (a) e le parole che sono usate nella loro accezione piemontese (b), differente da quella italiana; sintassi; forme idiomatiche caratteristiche dei piemontofoni.
Lessico
a)
ammanato (amanà): pratico, avvezzo (RS III [Il paese], 34); anfanare (anfané): parlare a vanvera, biascicare che vai anfanando (RS III [Il paese], 12) rantolare, avere l’affanno Davide anfanò un poco (Sc Nota ai testi, Appendice, 770); battocchio (batòcc): battacchio (RS III [Il paese], 16); bevuto (beivù): alticcio (RS IV [L’esattore], 80); boetta (boeta): scatolino, di piombo o stagnola, per una libbra di tabacco (< fr. boite, secondo la pronuncia arcaica di oi in oe)[14] (RS III [Il paese], 63); bonboni (bonbon): confetti (RS IV [L’esattore], 82); brenno (brenn): crusca (RS III [Il paese], 63); bricco (brich): collina (RGC II [L’andata], 26)[15] e il diminutivo bricchetto (collinetta; VGA VIII [Quell’antica ragazza], 338); burgons (bërgòm): sorta di caramella gommosa o gelatinosa (I penultimi Nota ai testi, 2/I [Io e la zia Luigia], 607); busa (busa): deiezione bovina mosche e buse (RS III [Il paese], 40); calzamento (caussament/caussamenta): calzatura (Sc Nota ai testi, Appendice, 741); carrata (carà): carico di un carro una carrata di fieno (RS III [Il paese], 36); cascinaio (cassiné): proprietario o conduttore di cascina (Sc, IV [«Davide» Davide al mercato], 439); cazza (cassa): grosso mestolo mi sporge una cazza d’acqua? (RS III [Il paese], 16); censa (censa): rivendita di tabacchi (RS V [L’affare dell’anima], 89); chiabotto (ciabòt): piccola costruzione rustica (RS IV [L’esattore], 82); cicchetto (cichèt): bicchierino di liquore tornò con un altro cicchetto (RS III [Il paese], 32); cuna (cun-a): culla (RS IV [L’esattore], 78), poi corretto in culla (cfr. Nota ai testi, Apparato, 532); diffizioso (difissios): schizzinoso (RS I [Alla langa], 6); disinteressamento (disinteressament): disinteresse (RS XIII [Un Fenoglio alla prima guerra mondiale], 167); doito (deuit): garbo, bel modo di fare ha bel doito (RS III [Il paese], 28); empiura (empiura): riempitura, imbottitura (Un Fenoglio alla prima guerra mondiale Nota ai testi, 622); febbretta (fevrëtta): febbricola (PS V, 176); filo [della schiena] (fil/filon dla schin-a): spina dorsale (PS V, 167 e RS V [L’affare dell’anima], 93); gerbido (gerb): luogo incolto (RS III [Il paese], 55); grottino (crotin): parte inferiore della cantina, riservato esclusivamente al vino (RS VII [Lo scambio dei prigionieri], 105), e anche nella grafia più vicina all’originale piemontese, crottino (D, r. XLIII: Dopo pioggia, 212); incantonare (ancantoné): spingere in un angolo, in genere con intenzioni amorose (lett.), illudere (metaf.) non mi lascerò incantonare da questa parola amore (I penultimi Nota ai testi, III [Il nonno e il mortorio], 568); langa: come nome comune (e non proprio), cresta di collina (VGA VIII [Quell’antica ragazza], 336 e passim); lapa (lapa): cibo squisito, gradevole (semi-gergale) vivere a lapa e marzapane (I penultimi Nota ai testi, VI [Mi mandano via], 576); madama (madama): signora, come termine appellativo di rispetto (RS X [La licenza], 126); malparlante (malparlant): maldicente manica di malparlanti (RS III [Il paese], 16); mannarino (manarin): grosso coltello da macellaio (RS III [Il paese], 24); meliga (melia): granoturco (RS III [Il paese], 22 e passim); mantile (mantil): tovaglia (L’affare dell’anima Nota ai testi, [L’affare Abr(igo) Capr(a)], 549); merendare (marendé): fare merenda (RS IV [L’esattore], 73); mira (mira): punto, soprattutto nell’espressione a la mira che: al punto che… (RS I [Alla langa], 5) all’altezza di… in mira della stazione (RS X [La licenza], 125); onta (onta): soggezione, vergogna se aveva un pò d’onta (RGC IV [Gli inizi del partigiano Raul], 51); pedaggera (pedagera): strada o località dove si paga il pedaggio (anche toponimo) (Un Fenoglio alla prima guerra mondiale Nota ai testi, 621); penduto (pendù): impiccato (RS III [Il paese], 19); pintone (pinton): bottiglione per il vino della capacità di 2 litri (RS IV [L’esattore], 76); poggiolo (pogeul): balcone (RS III [Il paese], 30); rinculoni (arculon): all’indietro andando rinculoni (RGC II [L’andata], 24); rittano (ritan/ritan-a): fogna di campagna , e per estensione “valloncello” (RGC III [Il trucco], 39 e passim); roc (ròch): masso, rupe (I penultimi Nota ai testi, V [Il sogno], 572); sbardare (sbardé/sbardlé): sparpagliare gli uomini e le donne sbardati (RS I [Alla langa], 6) rovesciare tutto in giro avevano sbardato sulla scaletta … un mastello di acqua saponata (L’affare dell’anima Nota ai testi, [L’affare Abr(igo) Capr(a)], 551); sbruffare (sbrufì): sbuffare (RS III [Il paese], 13); schivare/schiviare (schivié): risparmiare, mettere da parte schivare un po’ di soldi (RS I [Alla langa], 6) e schivarsi/schiviarsi (schiviesse): evitare, farsi da parte si schivò (PS II, 129); sfisonomiare ([dë]sfusumià): stravolgere (in viso, nei lineamenti) sfisonomiati (“stravolti in viso”; RGC IV [Gli inizi del partigiano Raul], 52) sfisonomiata (RGC V [Il vecchio Blister], 65), detto anche della voce (“deformata”) la voce mi arrivava sfisionomiata (RS I [Alla langa], 6); sgonfiare (sgonfié): seccare, importunare mi sta sgonfiando (RS III [Il paese], 21); sicurarsi (siguresse): assicurarsi (RS IV [L’esattore], 79); slargare (slarghé): allargare si slarga (PS VIII, 212) ha slargato la fessura (RGC V [Il vecchio Blister, 65) la voce si slargava (RS I [Alla langa], 6); solforatrice (sorforatris): strumento per irrorare di zolfo le viti (Sc Nota ai testi, Appendice, 775); sovente (sovens): spesso (PS VIII, 206); spregiosamente (spresiosament); sprezzantemente (RS III [Il paese], 15) e spregioso (spresios; “sprezzante”) (RS III [Il paese], 50); stanchità: stanchezza (RS I [Alla langa], 5); stortarsi (stortesse): stravolgersi gli occhi gli si stortavano per la rabbia (RS I [Alla langa], 6); stranfiare (stranfié/tranfié): ansimare, respirare affannosamente poco più alta dello stranfiare (T, Solitudine, 391); straparlare (straparlé): parlare a vanvera, sragionare (PS I, 127); tabalori (tabaleuri): minchione, fesso (RS III [Il paese], 50); tenimento (teniment): tenuta, proprietà (RS Nota ai testi, Frammenti III [Teresio Manzone], 638); travata (travà): trave portante del tetto (Sc Nota ai testi, Appendice, 758); trigo (trigo, forma abbreviata per trigomiro): pasticcio, impiccio (RS III [Il paese], 68); vergnacco (vërgnach): poltrone, infingardo (RS IV [L’esattore], 78); vignolante (vignolant): vignaiuolo (RS IV [L’esattore], 82).
b)
abbrancare (branché): afferrare avesse abbrancato (RGC II [L’andata], 35); accompagnare (compagné): raccogliere il sugo col pane non sgridarla perché accompagna (Sc Nota ai testi, Appendice, 767); aggiustarsi (rangesse): sistemare, trovare una soluzione aggiustatevi (RGC II [L’andata], 32) come l’aggiustiamo? (RGC III [Il trucco], 38) regolare, mettere a posto aggiustiamo i conti? (I penultimi Nota ai testi, 2/I [Io e la zia Luigia], 604); ambizione (ambission): desiderio per l’ambizione di servirli bene (RS III [Il paese], 56); andare (nel nesso “far andare”; fé andé): cucinare o lavorare la terra fatta andare (“cucinata”; PS IX, 216); appeso (pendù): metonimico per “impiccato” (RS V [L’affare dell’anima], 84); ascoltare (scoté): ubbidire (PS III, 153); avanzare (vansé): evitare avanzare di mettermi al mondo (PS IX, 220) mettere da parte, risparmiare non s’è avanzato una lira (RS III [Il paese], 55); baccelliere (bacialé): sensale di matrimonio la processione dei baccellieri (RS IV [L’esattore], 75); bariletti (barlèt): barilotti (RS XII [I penultimi], 161); bene/beni (bin); proprietà sul bene degli altri (RS IV [L’esattore], 74); bestie (bes-ce): metonimico per “mucche” (RGC II [L’andata], 25); bombata (bombà): tumefatta, gonfia (semi-gergale; RS VII [Lo scambio dei prigionieri], 106) e bombare (bombé): picchiare, gonfiare la faccia (idem; RS VII [Lo scambio dei prigionieri], 107); bordello (bordel): rumore, baccano farà del bordello (PS VI, 178); cognizione (cognission): buon senso, equilibrio (RS IV [L’esattore], 76); comprare (caté, raro e italianizzante compré): partorire già comprato (PS VII, 198); concezione (concission): impostazione, intuizione la concezione c’è ancora (RS III [Il paese], 46); confidenza (confidensa): fiducia ha mai mostrato confidenza nei preti (Sc Nota ai testi, Appendice, 774); conoscere (conòsse): riconoscere, capire non le conosceva il male (RS II [Il gorgo], 7); contare (conté): raccontare contami (VGA VIII [Quell’antica ragazza], 335) se mi conta una balla (PS IV, 155); costumarsi (costumesse): usarsi, esserci l’abitudine non si costuma più (RGC II [L’andata], 26); fidare (fidé/fidesse): affidare, consegnare gli si può fidare (PS VIII, 204); figlio/figlia (fieul/fija): ragazzo, ragazza povera figlia (PS V, 171; pòvra fija); filo (fil/filon): corrente (detto del vento) nel filo del vento (RS VIII [Quell’antica ragazza], 109); fissazione (fissassion): mania farsene una fissazione (RS III [Il paese], 28); gioco (geugh): metonimico per “luogo dove si gioca”, specie per le bocce (PS I, 126) o per il pallone elastico[16] (RS III [Il paese], 25); governare (goerné): gestire, condurre che brutta giornata hai governato (RS III [Il paese], 35); grattare (graté): rubare (semi-gergale) già l’avevi grattata (RS III [Il paese], 17); marcare (marché): sapere di marcavano troppo il latte di vacca (D, fr. XLIII: Dopo pioggia, 211)[17]; marocchino (marochin): persona originaria dell’Italia meridionale (GF Nota ai testi [Racconto per «Nuovi Argomenti»], 680; matteria (materia): arcaico in italiano, di uso comune in piemontese, specie nell’espressione fé ’d materie (fare delle stramberie, dar di matto) (RS XIII [Un Fenoglio alla prima guerra mondiale], 169); moro (mòro): negro, persona di colore (RS II [Il gorgo], 7); muraglia (muraja): muro (PS I, 126); palchetto (palchèt): pavimento di legno, parquet (RS IV [L’esattore], 81) e “ballo a palchetto” (ballo mobile nelle feste di paese; I penultimi Nota ai testi, XI [Prima parte del viaggio], 595); parare (paré); riparare, detto specialmente del riverbero della luce vuoi che te la pari? (I penultimi Nota ai testi, X [Gli addii], 588); patire (patì): soffrire pativa il torpedone (PS VIII, 200), patisce di cuore (RS X [La licenza], 127) anche in forma assoluta patì, “soffrì” (PS IX, 223¸ dovevo patirne di più (RS V [L’affare dell’anima], 86) penare non farci più patire (Un Fenoglio alla prima guerra mondiale Nota ai testi, 624); perdonare (përdoné): condonare perdonategli il tabacco infettato (RS III [Il paese], 11); pigliare (calco di pijé): prendere mi pigli? (PS VIII, 207); pila (pila; rectius pilia): pilastro (PS V, 174) pila dei portici (RS X [La licenza], 136) e pilone (pilon), edicola votiva campestre (RS III [Il paese], 17); pinnacolo (pënàcol): gazebo da giardino (I penultimi Nota ai testi, XI [Prima parte del viaggio], 592); portina (portin-a): porticina (Sc Nota ai testi, Appendice, 765); postarsi (postesse): appostarsi, piazzarsi si postarono (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 18); puntuto (pontù): fatto a punta (RGC II [L’andata], 27) sagace, perspicace (soprannome di persona) (L’affare dell’anima Nota ai testi, [L’affare Abr(igo) Capr(a)], 553); rimettere (armëtte): cedere rimettere la bottega (PS VIII, 213); risentirsi (arsentisse): provare fastidio, disturbo si risentiva del rumore (RS III [Il paese], 34); rivenire (arven-e): sovvenire, tornare in mente se solo mi riviene l’anno (I penultimi Nota ai testi, XI [Prima parte del viaggio], 592); sacramento (sacrament): bestemmia (RS V [L’affare dell’anim a], 84); sardegnolo (sardagneul): sardo (RS IV [L’esattore], 79); scienza (siensa): capacità, esperienza, conoscenza, competenza la sua scienza (PS VI, 178) sepoltura (seportura): funerale (PS V, 169); servente (serventa; femminile): serva, domestica (RS III [Il paese], 29); sforzare (sforsé): forzare (PS IX, 217) detto della pioggia “piegare, torcere” la pioggia che sforzava le cupole dei castagni (Sc Nota ai testi, Appendice, 782); soffrire (seufre/sufrì, e anche riflessivo sufrisse): sopportare come se non potesse soffrirsele (PS V, 176); sosta (sosta): riparo, nell’espressione “alla sosta di” (a la sosta) (RS IV [L’esattore], 82); sottano (sotan; aggettivo e detto di cose): inferiore, di sotto finestra sottana (RS III [Il paese], 30); sporgere (spòrze): consegnare le rincresce sporgerlo al parroco? (RS III [Il paese], 16); strusciare (strusé): trascinare lo sporco che ci portate e strusciate (RS III [Il paese], 15); studiare (studié): fare attenzione, pensare con calma studiava (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 11) lasciami studiare (M, 399) far degli studi (RGC III [Il trucco], 39); taglie (taje): tasse (RS IV [L’esattore], 70); taroccare (taroché): amoreggiare, fare il filo taroccavano le ragazze (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 18); tocco (tòch): pezzo fili di fieno e tocchi di legno (RS III [Il paese], 33); torchiare (torcé): prepararsi una sigaretta poteva torchiargliene una (RS III [Il paese], 34); travaglio (travaj): lavoro (RS I [Alla langa], 6); trombare (trombé): suonare la tromba (RS III [Il paese], 15); uomo: marito (PS IX, 223; RS II [Il gorgo], 8; passim); vaccina (vacin-a): vaccinazione (Sc Nota ai testi, Appendice, 753); vera (vera): fede nuziale (RS IX bis [senza titolo], 118); vergognoso (vërgognos; detto solo di persone o, tutt’al più, di animali): che si deve vergognare (RGC II [L’andata], 30); vitello della coscia (bocin dla cheussa): vitello da latte (RS IV [L’esattore], 74).
Sintassi
gli: a loro; (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 9; je/j, sia singolare che plurale, sia maschile che femminile); in Alba: ad Alba (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 10: an Alba); era in metà giusta delle posizioni: esattamente al centro (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 13; an mità giusta ëd); sparato il fucile: sparato col fucile/un colpo di fucile (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 13; sparé ’l fusil); un rumore da non sapere se: che non si capiva se (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 14; da nen savèj se); che comincia le battaglie: che dà inizio, fa cominciare (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 14; ancaminé, transitivo); marcì la terra: fece marcire (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 15; marsé); fino a passate le undici: fino alle undici passate (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 17; fin-a a passà óndes ore); sono da serva: faccio la serva (RGC II [L’andata], 23; son da serventa); c’è più di mezzi gli altri: c’è più di metà degli altri (RGC II [L’andata], 34; pì ’d mesi j’àutri) ha mezzo riempita (“ha riempito per metà”) (RS I [Il paese], 31), i mezzi mezzi (“i mediocri, quelli intermedi”) (RS IV [L’esattore], 69); ragionare (trans.): far ragionare credeva di avermi ragionato (RGC V [Il vecchio Blister], 62 e 66; rasoné); da sulla porta: dalla porta (RGC V [Il vecchio Blister], 71; da ’n sla pòrta); più pochi siamo: meno siamo (RGC VI [Nella valle di San Benedetto], 77; pì pòchi i soma); e non più finirla di parlare: e non finire di (PS I, 127; pa pì furnila); delle cose che a solo pensarle: che solamente a pensarle (PS III, 140; che a mach penseje); parlargli da in piedi: stando in piedi (PS III, 149; RS IV [L’esattore], 81; da ’n pe e passim); per mio conto: per conto mio (PS III, 152; për me cont) e, come forma idiomatica, “autonomamente, da solo, per i fatti miei” per suo conto (RS V [L’affare dell’anima], 88); in sua stanza: nella sua stanza (ibidem, 153; ant soa stansia); fanno un mestiere che non è il suo: che non è il loro (PS IV, 156 e passim; sò sia singolare che plurale); il meglio da fare: la cosa migliore (PS IV, 162; ël mej da fé); dovere da uomo: di uomo (PS V, 170; da òm); a solo guardarti: solo a (PS V, 175; a mach vardete); in mezzo alla strada: al centro della (PS VI, 181; an mes ëd); non mi oso: non oso (PS VII, 191; im n’ancalo nen); non sono andato in terra: non sono caduto a terra (PS VII, 197; andàit an tèra); sua madre di Vanda (pleonasmo): la madre di (PS VII, 197; soa mare ëd); essere niente cambiati: per niente (PS VIII, 201; esse gnente cangià); bell’e da me: anche io da solo (VGA VIII [Quell’antica ragazza], 336; bele da mi); uscirla: portarla fuori (VGA XI [L’odore della morte], 356; surtila); da in: in festa da in festa (RS II [Il gorgo], 9; da ’n festa); preciso: precisamente che hanno di male preciso (RS III [Il paese], 11); il meglio riuscito: chi è riuscito meglio (RS I [Il paese], 13; ël mej surtì); per mezze le colline: su metà delle colline (RS III [Il paese], 14; për mesi ij brich) e bicchieri mezzi: pieni a metà (RS III [Il paese], 18); il bel primo: il primo assoluto di tutti (RS III [Il paese], 19; ël bel prim); parlare insieme: parlare con gli parleremo insieme (RS III [Il paese], 44); tutto un discorso: un discorso completo, anche con valore ironico “che non finisce più” (RS III [Il paese], 62), uso dell’aggettivo raddoppiato al posto del superlativo in -issimo di buoni buoni nei negozianti di bestiame non se n’è visti mai: buonissimi (RS III [Il paese], 68); con tutto che: benché, sebbene (RS IV [L’esattore], 79; contut che); per: perché (causale in forma implicita) per non poterne più (perché non ne poteva più; RS IV [L’esattore], 81) scusandosi per riceverlo in cucina (perché lo riceveva (I penultimi Nota ai testi, VIII [Rinvio per la licenza dello zio Amilcare], 581); da qui in là: da qui a là (RS X [La licenza], 128); ancora: persino sai che siamo ancora parenti? (RS X [La licenza], 139); la più parte: la maggior parte (T Nota ai testi, Solitudine, 666; la pì part); tutto un bosco: un bosco intero (T Nota ai testi, Solitudine, 671; tut un bòsch); all’impiedi: in piedi (Sc Nota ai testi, Appendice, 754).
Forme idiomatiche
far bordello: far confusione, rumore (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 5); solo che (ibidem) e solo più (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], 19; mach che/mach pì); nessun patto: a nessun costo (RGC II [L’andata], 26; a gnun pat); non sei buono: non sei capace (RGC II [L’andata], 27 e passim; nen esse bon); la volta che viene: la volta prossima (RGC III [Il trucco], 38; la vòlta ch’a-i ven) questa primavera che viene (PS I, 127); come se avesse contro: di fronte (RGC III [Il trucco], 39; ancontra); era appena della leva: era appena coscritto (RGC IV [Gli inizi del partigiano Raul], 47: dla leva); le prendevo la foto: le facevo… (RGC IV [Gli inizi del partigiano Raul], 52; i-j pijva la fòto); mi sanguina il cuore: mi dispiace moltissimo (RGC V [Il vecchio Blister], 62; am sagna ’l cheur); non mi facevate la parte: non mi facevate fare la figuraccia (RGC V [Il vecchio Blister], 64), vigliacco se io gliel’ho stretta: forma esclamativa intensiva per “figurarsi se non…” (RGC V [Il vecchio Blister], 68; viliach se…); ladro d’un ladro: valore asseverativo-superlativo, dovuta alla probabile omissione di “figlio d’un…” (RGC V [Il vecchio Blister], 69; làder d’un làder); faceva di bisogno: era necessario (PS I, 124; a fasìa dë bzògn); dimmelo per lungo: per esteso, completamente (PS I, 125; për longh); a forza che era contento: tanto era… (PS I, 127; fòrsa che…); nel suo degli altri: nella proprietà d’altri (PS II, 136; ant ël sò dj’àutri); il più che posso: quanto più posso (PS II, 137; ël pì ch’i peuss); fumiamo una volta: fumiamo (forma pleonastico) (PS IV, 156; na vòlta); madre: usato al vocativo per mamma; PS V, 170 e passim; idem “padre”; mare/pare); un bene dell’anima: un gran bene (PS V, 171; na bin ëd l’ànima); vecchia carretta: catorcio (PS V, 171; veja carëtta); ti metto le mani al collo: le mani addosso (PS V, 173; it buto le man al còl); poteva andare sulla forca: andare al diavolo/all’inferno (PS V, 174; andé an sla forca); tutto d’un colpo: all’improvviso (PS VI, 181; tut d’un crep); faceva un tipo: era un tipo (PS IX, 218; a fasìa tipo); viene l’amicizia: nasce l’amicizia (RS I [Alla langa], 5); darsi la voce: parlarsi (RS I [Alla langa], 5; desse la vos); diede la larga: liberò, lasciò libero (RS I [Alla langa], 5; dé la larga); dava dei nomi: insultava (RS I [Alla langa], 6; dé dij nòm); fare flanella: oziare, perdere tempo (RS I [Alla langa], 6; fé flanela); per compensa: in compenso (RS III [Il paese], 11; an/për compensa); caricarmi di legna verde: prendere impegni gravosi (RS III [Il paese], 15; cariesse ’d bòsch verd); per qui: da queste parti (RS III [Il paese], 19; për sì); aver visto: nella sfera semantica della salute/malattia ha il valore di “quale malattia può essere capitata”: cosa può aver visto? (RS III [Il paese], 20; avèj vist); venire a taglio: essere utile, servire gli veniva a taglio (RS III [Il paese], 24; vnì ataj); prendersi guardia: far bene attenzione, evitare accuratamente me ne sono preso guardia (RS III [Il paese], 31; pijesse varda); mai al mondo: assolutamente mai, mai e poi mai (RS III [Il paese], 66), niente mondo: nulla di nulla (RS XIII [Un Fenoglio alla prima guerra mondiale], 167); uso di “grande” per “profondo, tanto…” la grande abitudine che aveva (RS III [Il paese], 67) la grande istruzione (RS IV [L’esattore], 72); fare fallita: fare fallimento aveva fatto fallita (RS IV [L’esattore], 69; fé falìa); una madama di…: una bellezza di… una madama di casa (RS IV [L’esattore], 69); mancare il saluto: togliere il saluto non gli mancassero il saluto (RS IV [L’esattore], 70); dare da mente: dare retta a tutto il resto non dava da mente (RS IV [L’esattore], 70: dé da ment); brusco come l’aceto: acido (RS IV [L’esattore], 72; brusch parèj dl’asil); a oncie: a piedi (lett.: a unghie; RS IV [L’esattore], 82; a onge); fare figure: fare brutte figure faceva figure (RS V [L’affare dell’anima], 89; fé ’d figure); attaccarsi coi denti: litigare violentemente s’era presto attaccato coi denti (RS V [L’affare dell’anima], 91); di buon giusto: equamente, giustamente (RS VIII [Quell’antica ragazza], 112; ëd bon giust); ubriachi morti: ubriachi fradici (RS X [La licenza], 129; cioch mortal); prendermi il gusto: togliermi la soddisfazione (RS XII [I penultimi], 165; pijeme ’l gust); tenere da conto: tenere cari li teneva da conto (L’affare dell’anima Nota ai testi, [L’affare Abr(igo) Capr(a)], 551; ten-e da cont); presentare l’uscio di legno: non far trovare nessuno (L’affare dell’anima Nota ai testi, [L’affare Abr(igo) Capr(a)], 551; fé trové uss ëd bòsch); capitare a (più inf.): per caso… se mia sorella capitasse a dirti (I penultimi Nota ai testi, X [Gli addii], 588); sognarsi: osare, avere il coraggio ma come si è sognato? (I penultimi Nota ai testi, X [Gli addii], 590); tutt’altro che: altro che, invece che tutt’altro che fermarsi (I penultimi Nota ai testi, XI [Prima parte del viaggio], 598); alla larga: alla lontana restava suo cugino alla larga (RS Nota ai testi, Frammenti III [Teresio Manzone], 638; a la larga); in un Torino: in una città come Torino (enfatico) (Sc Nota ai testi, Appendice, 749; ant un Turin); il mazzo in mano [avere/lasciare]: essere al centro dell’attenzione di lasciare il mazzo in mano a lui (Sc Nota ai testi, Appendice, 753; avèj ël mass an man); nuovo di trinca: nuovo di zecca (Sc Nota ai testi, Appendice, 758); sul fino: fine un tipo sul fino (Sc Nota ai testi, Appendice, 766; an sël fin); fieni e grani: metonimico per “tempo del taglio del fieno/grano” aiutare nei fieni e nei grani (Sc Nota ai testi, Appendice, 766; ant ij fen/ant ij gran); fuori tutela: maggiorenne, calco del piem. fòra tùa (Sc Nota ai testi, Appendice, 777); il sangue dà un giro: alterarsi il sangue ti dà un giro (Sc Nota ai testi, Appendice, 778; a dà ’n vir ël sangh).
In appendice possiamo passare in rassegna alcuni termini che, pur non comparendo nei lessici piemontesi, non sembrano tuttavia appartenere alla lingua italiana, almeno a quella letteraria.
allegatori: dal contesto sembrerebbe riferirsi a coloro che organizzavano partite d’azzardo illegali (I penultimi Nota ai testi, 2/I [Io e la zia Luigia], 606);
«andare a raid»: dal contesto sembra voler significare “andare fino in fondo, non avere scrupoli”; in tal caso dunque è forse da leggersi “andare a rais/arèis” (andare alla radice, e quindi in senso traslato “fino in fondo”) (RS XI [Il mortorio Boeri], 141); a meno di voler pensare all’anglicismo raid (“scorreria”);
gradino (gradin): visto l’etimo (< gré, grado) ed il contesto, si tratta evidentemente di uno strumento per misurare la gradazione alcoolica del vino (RS XII [I penultimi], 164);
manente: forma arcaica di origine longobarda col valore di “mezzadro”, voce tipica ligure e quindi coerente con la vicinanza ed i conseguenti rapporti, culturali e commerciali, tra alta Langa e riviera di Ponente; nel contesto sembra tuttavia usata in senso traslato col valore (affettuoso) di “malfattore, vagabondo” (Sc Nota ai testi, Appendice, 779);
sdrumarsi (sdrumesse?): (prob.) togliere via sfregando volesse sdrumarsi la prima pelle (RS X [La licenza], 125);
stacciare (stacé): investigare, cercare, mettere il naso, importunare (?) chi deve venirci a stacciare? (Un Fenoglio alla prima guerra mondiale Nota ai testi, 624);
verdone (vërdon) probabilmente termine locale semi-gergale per indicare una bestia scarsa, di poco valore (RS III [Il paese], 21).
Una categoria a parte di forme che potremmo definire “idiomatiche” è costituita da termini riguardanti il gioco del pallone elastico (per il quale cfr. supra n. 5). Pertanto vediamo:
pallone (RS III [Il paese], 18; balon): metonimico per “pallone elastico” se riferito al gioco, oppure, concretamente, il pallone con cui si gioca[18];
ricaccio (RS III [Il paese], 19; arcass) e ricacciare (RS III [Il paese], 26; arcassé): si tratta dell’azione della ribattuta, effettuata dalla squadra avversaria, susseguente a quella della battuta iniziale del gioco[19];
postare il braccio (RS III [Il paese], 19; posté ’l brass): preparare, predisporre il braccio per colpire il pallone;
pantalera (RS III [Il paese], 26): tavola di legno su cui, soprattutto nei paesi, dove mancava il “muro di appoggio”, si faceva battere il pallone per rendere meno agevole il ricaccio agli avversari;
quadriglia (RS III [Il paese], 45; quadrija): la squadra, composta di quattro giocatori (capitano, spalla, due terzini) e così capiquadriglia (RS III [Il paese], 55; cap-quadrija) sono i capitani delle due squadre in gioco;
caccia (RS III [Il paese], 47; cassa): sulla linea laterale si segnava, con una bandierina, il punto della caccia, cioè dove un giocatore era stato obbligato a fermare il pallone, non essendo riuscito a ribatterlo né al volo né al primo rimbalzo; una volta costituite due cacce, il gioco procedeva secondo uno schema differente, troppo lungo e complesso per essere qui spiegato;
intra (RS III [Il paese], 47): quando si mandava il pallone, con la battuta, oltre la linea di fondo;
volata (RS III [Il paese], 47; volada): battuta al volo (< fr. volée);
ferma e fermare (RS III [Il paese], 51; fërma/fërmé): quando uno dei giocatori, non riuscendo a colpire il pallone né al volo né al primo rimbalzo, lo fermava, determinando così la costituzione di una “caccia”;
farai un quindici (RS III [Il paese], 54; fé ’n quìndes): conquistare un punto, poiché il punteggio, come nel tennis, è scandito in 15/30/40 gioco, vincendo la squadra che per prima arriva a conquistare 9 o 11 giochi;
partitanti (Sc, III [«Davide» Giocare e non giocare], 433; partitant): partecipanti alla partita, giocatori;
lizza (Sc, VI [«Davide» Jose e Cino], 447): linea immaginaria delimitante il gioco, poiché nei paesi si giocava normalmente in piazza (“alla lizza”) e non in un campo, regolarmente segnato e delimitato dal cosiddetto “muro di appoggio”[20].
[1] Generale e uomo politico albese (1825-1872).
[2] Letteralmente “testa rotonda”: così erano popolarmente chiamati i soldati di Cromwell in quanto, in opposizione alla monarchia ed alla nobiltà, non portavano la parrucca.
[3] Sappiamo che Fenoglio tradusse alcune parti, per proprio interesse, della biografia di Cromwell dall’edizione inglese di Charles Firth (1857-1936), edita nel 1900. Inoltre, acutamente Davide Lajolo intitolò proprio Un guerriero di Cromwell sulle colline delle Langhe la sua biografia dello scrittore albese, che avrebbe certo voluto essere «un soldato di Cromwell con la Bibbia nello zaino e il fucile a tracolla», come ci rivela il suo amico e maestro Pietro Chiodi, suo professore di filosofia al liceo.
[4] La presenza di termini inglesi inseriti nel fluire della narrazione aveva fatto ipotizzare ad alcuni critici che tale romanzo, nella sua interezza o almeno in molte sue parti, fosse stato concepito direttamente in inglese, e poi tradotto in italiano, lasciando tuttavia alcuni relitti inglesi al suo interno. Tale ipotesi è stata poi confermata da un frammento, edito col titolo di Ur-Partigiano Johnny, di alcuni capitoli del romanzo scritti direttamente in inglese.
[5] Le vicende storiche e socio-linguistiche del Piemonte hanno fatto sì che nella regione, oltre alle varie forme dialettali locali (nel caso di Fenoglio il langarolo), si costituisse una koinè sovraregionale, in pratica coincidente pressoché del tutto col torinese. Tale koinè era, almeno fino a circa 70/80 anni orsono, compresa (e spesso anche usata) anche da coloro che normalmente usavano nel parlare quotidiano la loro forma dialettale locale. Questo doveva essere il caso di Fenoglio, così come di quasi tutti gli abitanti borghesi delle principali città e cittadine (come Alba) del Piemonte.
[6] L’opera omnia di Fenoglio è stata edita in Opere (ed. critica diretta da M. Corti); Torino (Einaudi) 1978. Vol. Primo (Tomo i): Ur-Partigiano Johnny [Ur] (a cura di J. Meddemmen); (Tomo ii): Il partigiano Johnny [PJ] (a cura di M. A. Grignani); (Tomo iii): Primavera di bellezza [PB]; Frammenti di romanzo [FrR]; Una questione privata [QP] (a cura di M. A. Grignani); Vol. Secondo: Racconti della guerra civile [RGC i-vii]; La paga del sabato [PS]; I ventitré giorni della città di Alba [VGA i-xii]; La malora [M]; Un giorno di fuoco [GF i-xii] (a cura di P. Tomasoni); Vol. Terzo: Racconti sparsi editi e inediti [RS]; [Quaderno Bonalumi; QB]; [Diario; D]; Testi teatrali [T]; Progetto di sceneggiatura cinematografica [Sc]; Favole [F] (a cura di P. Tomasoni); Epigrammi [Ep] (a cura di C. M. Sanfilippo). Le citazioni in questo nostro lavoro sono fatte seguendo tale edizione.
[7] In questa prima parte del lavoro affrontiamo, dunque, proprio questo romanzo quale opera più fortemente “piemontesizzante”, segnalando sempre la pagina secondo l’edizione einaudiana di riferimento. Rimandiamo alla seconda parte l’analisi di altri testi narrativi fenogliani. Sulla lingua di questo breve romanzo si veda anche B. Villata, La langue de La malora, in “L’Arvista dl’Academia” vii (Luglio-Settembre 1997), pp. 29-46.
[8] Anche nelle altre opere i casi sono rarissimi. Segnaliamo solamente, a mo’ d’esempio, dei zolfini (RGC I [I 23 giorni della città di Alba], pag. 13): non esistendo in piemontese il suono della z italiana, esso viene sostituito da quello della s sonora.
[9] «Che è una traccia di porri e meliga che si semina verso la porta di chi è stato lasciato da una donna nel giorno che lei si sposa con un altro». Il dizionario di G. F. Gribaudo (Dissionari piemontèis; Torino 19963) alla voce porà recita “minestra di porri”, mentre alla voce povrà (facendola derivare però da póver, “polvere”) ci dice “striscia di crusca che si spingeva fin sulla porta di chi era stato rifiutato in matrimonio”.
[10] Lo stesso per il femminile fija: “ragazza” oltre che “figlia”.
[11] Tutte queste forme originano dal valore del termine mira: “punto, altezza, riferimento, segno” (cfr. Gribaudo, cit., s. v.).
[12] Notiamo preliminarmente che in un racconto in particolare, vale a dire La novella dell’apprendista esattore, inserita nella raccolta Un giorno di fuoco, edita postuma a Milano (da Garzanti) nel 1963, compare all’interno della narrazione una sorta di brevissima lezione di lessico piemontese. Nell’edizione critica einaudiana curata nel suo insieme da Maria Corti essa occupa le pagine 513-529 del volume II, curato in particolare da P. Tomasoni. Nella Nota ai testi, alle pp. 661-694 dello stesso volume, abbiamo poi un’altra redazione dello stesso racconto, seguita da un Apparato di varianti d’autore (pp. 694-698). La trama del racconto – peraltro ricorrente in altri luoghi della narrativa fenogliana, tra cui nella medesima raccolta Un giorno di fuoco il racconto eponimo della raccolta stessa (pp. 441-457; ed. Corti) – è nota. La narrazione è incentrata sulla figura di Davide Cora, il quale – uscito di senno – si barrica in casa, sparando a chiunque si presenti sulla sua aia. Il racconto si sviluppa su diversi piani narrativi finché i carabinieri, che assediano già da parecchie ore il “ribelle”, con uno stratagemma riescono ad ucciderlo. Ideatore dello stratagemma è un giovane carabiniere meridionale (figura che nella redazione approntata per la rivista «Nuovi Argomenti» ha uno sviluppo, specie psicologico, molto più ampio che nel testo edito in volume), il quale, dopo aver aggirato la casa, può sorprendere Cora uccidendolo. Nell’ideazione dello stratagemma il carabiniere si fa spiegare da un uomo del luogo le caratteristiche del terreno retrostante la casa; tale spiegazione può essere riassunta in tre termini: meliga, che il carabiniere stesso si traduce da sé in “granoturco”, striscia di gerbido, la cui traduzione (“terreno non coltivato”) gli è fornita dall’interlocutore, e rittano, di cui l’uomo non riesce a fornire una traduzione (“Un rittano. Credo proprio che si dica così anche in italiano”), dovendo così ricorrere ad un esempio visivo (“Quello è un rittano”), da cui il giovane meridionale deduce la traduzione (“Ho capito. Valloncello”).
[13] Tenendo conto che l’aspetto fonetico, nell’ambito dei piemontesismi, si riduce a soli due esempi, esso è stato trattato già nella prima parte di questo intervento. Per quanto attiene invece alla morfologia, notiamo ginocchi (RGC VI [Nella valle di San Benedetto], 75), calco del piemontese genoj (maschile) e gridi (RS III [Il paese], 30), maschile per “grida”, dal piemontese braj/crij (entrambi maschili); nella morfologia verbale abbiamo compisce (compiss) per “compie” (T Nota ai testi, Solitudine, Appendice, 724). Nelle Note troviamo tuttavia ancora un aspetto fonetico: i zoccoli (Sc Nota ai testi, Appendice, 742; piem. ij sòch).
[14] Tale pronuncia arcaica, che denuncia una data molto antica per l’imprestito francese in piemontese, è testimoniata anche in altri francesismi, quale, per es., coefa (cuffia) < coife.
[15] Anche in senso traslato: un bricco di cose (“una montagna di cose”; (RS I [Alla langa], 6).
[16] Il pallone elastico (ora noto come “pallapugno”) è un antico gioco sferistico popolare. Un tempo praticato in tutto il Piemonte centro meridionale (Torino compresa) e nella Liguria di Ponente, è ora limitato alla parte meridionale delle province di Cuneo, Alessandria, Asti ed all’entroterra del Ponente ligure.
[17] In questo caso il Diario riporta un frammento di racconto, mentre tre altre citazioni, sempre dal Diario, rimandano all’uso linguistico consueto e quotidiano dello scrittore, aldilà di ogni travestimento letterario. Si tratta di: da per me (daspërmì): personalmente, da me (D, 201); attossicato (antossià): avvelenato (D, 204) e «leggére» (lingera): vagabondo, chi vive d’espedienti (D, 208).
[18] Per non confondere né i due giochi né i due “attrezzi”, il pallone del gioco del calcio veniva normalmente definito fótbal, con adattamento grafico e fonetico dell’inglese football.
[19] Come si vedrà anche per altri termini, diverse situazioni e regole del pallone elastico possono richiamare azioni simili nel gioco del tennis e in quello della pallavolo.
[20] Per questo motivo i tipi di partita, a seconda del campo di gioco, potevano essere: in uno sferisterio regolamentare, al mur, mentre nelle piazze di paese a la pantalera o ai tèit, qualora la pantalera venisse sostituita dai tetti delle case adiacenti al campo.